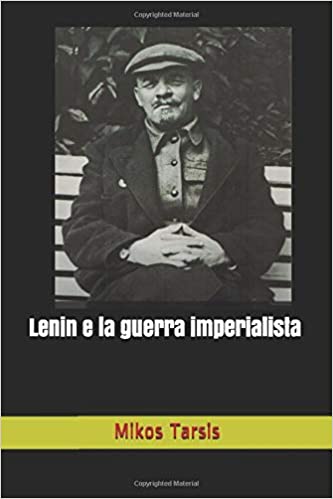
LENIN E LA GUERRA IMPERIALISTICA
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
1917: l'anno cruciale
Verso i primi di marzo del 1917 Lenin, dalla Svizzera, appresa la notizia della rivoluzione borghese di febbraio in Russia, inizia ad attaccare il governo in carica (fino all'ultimo premier, Kerenskij) e medita di rientrare in patria: in tal senso occorre leggersi sia le cosiddette Lettere da lontano1 che le Tesi d'Aprile.2
Le contestazioni e le proposte sono, come al solito, molto precise:
il governo vuol continuare la guerra fino alla vittoria sulla Germania e quindi non vuole la pace. Vuole la guerra perché è vincolato dai trattati segreti che già lo zarismo aveva stipulato con Francia e Inghilterra e altre nazioni belligeranti;
poiché il governo rappresenta i capitalisti industriali e gli agrari imborghesiti ed è legato agli interessi annessionistici e speculativi dei capitalisti anglo-francesi, che hanno prestato i soldi ai russi, la guerra non può essere giustificata in alcun modo, neppure in nome di una “difesa della rivoluzione” (di febbraio). Una guerra del genere sarebbe giustificata solo se il potere politico fosse nelle mani della classe operaia e dei contadini poveri: in tal caso però non sarebbe stata condotta come una guerra di annessione fatta nell'interesse del capitale;
il governo provvisorio non ha intenzione di concedere alcuna libertà alle colonie e alle nazionalità oppresse dell'ex impero zarista. D'altronde a febbraio esso ha preso il potere non solo perché l'autocrazia zarista era in sfacelo, ma anche a causa dell'insufficiente grado di coscienza e di organizzazione del proletariato;. Infatti buona parte della popolazione è stata ingannata dalla propaganda borghese sulla giustezza o sulla necessità di tale guerra, ma i bolscevichi han capito che è impossibile mettere fine alla guerra senza abbattere il capitale;
la propaganda bolscevica va estesa all'esercito fino all'invito alla fraternizzazione con il cosiddetto “nemico”;
il partito bolscevico, favorito dalle possibilità legali di svolgere il proprio lavoro politico, si deve preparare alla seconda fase della rivoluzione, quella che deve dare il potere al proletariato e agli strati poveri dei contadini, pertanto non appoggerà in alcun modo il governo provvisorio;
i bolscevichi sanno di essere un'esigua minoranza nella maggior parte dei soviet dei deputati operai, nei quali si è operata un'alleanza di tutti gli elementi opportunistici piccolo-borghesi. Tuttavia riconoscono che i soviet operai sono l'unica forma possibile di governo rivoluzionario, per cui tutti i poteri statali vanno trasferiti a loro;
la Russia deve diventare una repubblica dei soviet dei deputati degli operai, dei salariati agricoli e dei contadini. Sull'esempio della Comune di Parigi l'esercito permanente va sostituito dall'armamento di tutto il popolo e i funzionari statali devono poter essere eleggibili dal popolo e revocabili in qualunque momento, né possono avere uno stipendio superiore a quello medio di un operaio;
il programma agrario del partito prevede la confisca di tutte le grandi proprietà fondiarie e la nazionalizzazione di tutte le terre, mettendole a disposizione dei soviet locali dei deputati dei salariati agricoli e dei contadini;
tutte le banche del Paese vanno fuse in un'unica banca nazionale, posta sotto il controllo dei soviet dei deputati operai;
il partito deve convocare un congresso che approvi le modifiche al suo programma e il cambiamento del nome da “socialdemocratico” a “comunista”, per distinguersi dai capi della socialdemocrazia che hanno tradito il socialismo. Per lo stesso motivo occorre creare una nuova Internazionale, veramente rivoluzionaria.
Il programma di pace del partito bolscevico viene svolto in sei punti:
il soviet dei deputati degli operai, dei soldati e dei contadini di tutta la Russia deve dichiarare subito di non ritenersi vincolato ad alcun trattato, stipulato sia dalla monarchia zarista che dal governo borghese attualmente in carica;
il governo socialista, quando andrà al potere, deve pubblicare subito tali trattati segreti, per denunciare gli scopi briganteschi di tutti i governi borghesi;
tutte le potenze belligeranti dovrebbero firmare subito un armistizio;
le condizioni di pace proposte dalla Russia dovrebbero essere rese pubbliche subito:
a) liberazione di tutte le colonie;
b) liberazione di tutti i popoli e nazioni oppresse;
il proletariato deve far scoppiare la guerra civile nelle proprie nazioni, se non si accettano condizioni del genere;
gli operai e i contadini non devono riconoscere i debiti di guerra, per cui, finita la guerra, non vi sarà alcun indennizzo.
Il 3 aprile 1917 Lenin giunge a Pietrogrado e subito si mette in moto per organizzare l'opposizione al governo borghese. Sin dall'inizio la sua idea è quella di compiere la rivoluzione proletaria. Da più parti viene giudicato “folle”.
Lenin non vedeva la rivoluzione borghese in corso come uno step di lunga durata per la Russia, cioè una fase che avrebbe dovuto maturare le proprie contraddizioni interne, prima che si potesse parlare di rivoluzione proletaria. Egli vedeva il governo provvisorio come una forma disperata di sopravvivenza dei capitalisti e dei grandi agrari, i quali non potevano più contare su una monarchia completamente screditata sotto ogni punto di vista.
L'intenzione di voler approfittare immediatamente della situazione coglie di sorpresa gli stessi compagni di partito, che pensavano di aver già raggiunto un grande risultato nell'essere riusciti ad abbattere la peggiore autocrazia del mondo. Lenin, come al solito, era in grado di vedere più in là di tutti e di far leva sul suo pensiero divergente.
Il 4 aprile legge, prima ai soli bolscevichi, poi anche ai menscevichi, le sue tesi sui Compiti del proletariato nella rivoluzione attuale (pp. 226-28), di cui due sono fondamentali.
Non è ammissibile la benché minima concessione al “difensismo rivoluzionario”, a meno che il proletariato non vada al governo, rinunciando a qualunque annessione e troncando ogni rapporto coi capitalisti. In caso contrario la guerra continuerà a essere “imperialistica”, anche se il governo borghese dirà che serve per difendere la patria e non per fare annessioni.
L'attuale potere è passato alla borghesia non perché questa era forte, ma perché si è dimostrato debole il proletariato. La partita però non è ancora terminata. Per vincere la borghesia occorre sfruttare alcune condizioni favorevoli:
a) le possibilità legali ch'essa offre all'esercizio del potere sono le più ampie possibili, superiori a quelle di qualunque altro paese capitalistico del mondo, proprio perché la borghesia sa di essere debole;
b) non c'è violenza contro le masse popolari, anche perché queste stanno dando fiducia al governo provvisorio;
c) occorre sfruttare il fatto che le masse proletarie si sono ridestate alla vita politica;
d) attraverso queste masse proletarie occorre negare qualunque fiducia alle promesse del governo provvisorio, soprattutto quelle concernenti la rinuncia alle annessioni, cioè bisogna evitare accuratamente l'illusione che un governo capitalistico possa non essere imperialistico.
Per far capire tutte queste cose alle forze armate quindici giorni dopo viene diffuso l'Appello ai soldati di tutti i paesi belligeranti, tradotto in varie lingue e da distribuire in tutte le trincee. Vi si chiede di fraternizzare col nemico, di rinunciare a una guerra che fa solo gli interessi dei capitalisti sulle spalle degli operai e dei contadini. Si promette che appena possibile verranno resi pubblici i trattati segreti stipulati tra gli Stati capitalisti. Si pretende la liberazione di tutte le colonie e di tutte le nazionalità oppresse. Si chiede che in Russia e in Germania il potere governativo passi nelle mani dei soviet, attualmente composti da operai e da soldati (sono organi di governo locale presenti in molte città).
Nell'aprile 1917 i bolscevichi fanno una proposta di pace che avrebbe potuto far risparmiare un altro anno di guerra e milioni di morti. Lenin voleva far capire chiaramente che il governo provvisorio non aveva alcuna intenzione di terminare la guerra, se non dopo averla vinta, anche perché doveva mantenere gli impegni presi dallo zar verso gli alleati. Il 18 aprile infatti il governo lo dice esplicitamente.
I bolscevichi si devono però difendere dall'accusa di voler far scoppiare la guerra civile. E allora ecco la risoluzione del CC del Posdr approvata il 4 maggio 1917 (pp. 236-38):
il partito non ha bisogno di scatenare alcuna guerra civile, poiché il governo non osa usare violenza contro le masse. Cioè la democrazia politica è giudicata sufficiente per opporsi al governo;
la massa dei soldati e degli operai, nei soviet, esprime liberamente la propria volontà, elegge liberamente e destituisce tutte le autorità locali;
in luogo della guerra civile è sufficiente “la subordinazione alla volontà della maggioranza della popolazione e la libera critica di questa volontà da parte della minoranza insoddisfatta” (p. 236).
Questo significa agire d'astuzia. È infatti lapalissiano che la democrazia si esprime nell'alternarsi di maggioranza e minoranza. “Se si giungerà alla violenza – chiarisce Lenin –, la responsabilità ricadrà sul governo provvisorio e sui suoi sostenitori” (p. 236). Più chiaro di così non poteva essere. Non stava escludendo a priori la possibilità di usare la violenza; stava semplicemente dicendo ch'essa sarebbe stata usata come “legittima difesa”, proprio perché – e questo l'ha sempre detto – “una rivoluzione che non si sa difendere, non vale nulla”.
Stava insomma chiedendo che la volontà di una esigua minoranza (i capitalisti e gli agrari) si sottomettesse alla volontà della stragrande maggioranza dei lavoratori. Una posizione, questa, che poteva apparire ingenua, proprio perché aveva già detto che una buona parte della popolazione sosteneva il governo. Aveva però bisogno di far vedere che tra l'autocrazia zarista e il governo borghese le differenze non erano di sostanza. In ogni caso la situazione nella capitale Pietrogrado era sicuramente più tesa e incandescente che in qualsiasi altra parte della Russia, per cui Lenin poteva anche aver ragione quando diceva che lì la popolazione di operai e di soldati (i soldati semplici erano prevalentemente di origine contadina) non era disposta a bersi tutte le fandonie del governo provvisorio. Non dimentichiamo che per Lenin sarebbe stato sufficiente occupare la capitale, rovesciando il governo, per diffondere la rivoluzione in tutto il paese. Era lontanissima da lui l'idea di dover aspettare l'acquisizione di una maggioranza parlamentare. Quel che più gli premeva era di mostrare che il governo borghese non aveva alcunché di democratico, anche se all'apparenza sembrava essere migliore dell'autocrazia zarista.
Lenin era così sicuro che la popolazione della capitale non credeva nella democraticità del governo che chiese di indire una “consultazione popolare” (una specie di referendum), relativa all'atteggiamento da assumere verso la “nota governativa” con cui si dichiarava di voler continuare la guerra sino alla vittoria finale. Voleva anche sapere, in maniera ufficiale, l'entità dell'appoggio popolare di tutti i partiti.
Si stava comportando in maniera molto rischiosa, poiché non poteva essere sicuro che i soviet avrebbero espresso una volontà risolutamente antigovernativa. Infatti scrive: “Noi riteniamo profondamente sbagliata la politica dell'attuale maggioranza dei dirigenti dei soviet dei deputati degli operai e dei soldati, dei partiti populistico [leggi: socialista-rivoluzionario] e menscevico...” nei confronti dell'attuale governo, poiché è tutto meno che rivoluzionaria.
D'altra parte un certo margine d'insicurezza era inevitabile. Le rivoluzioni non si fanno quando si è sicuri al 100% di vincere. Sapeva di avere a che fare con dei partiti piccolo-borghesi, quale quello socialista-rivoluzionario e menscevico, che oscillavano continuamente tra le posizioni capitalistiche e quelle proletarie. I dirigenti di questi partiti si limitavano a credere nelle promesse che il governo provvisorio faceva di rinunciare alle annessioni una volta finita la guerra. Lenin invece continuamente ribadiva che nessun governo borghese, fosse anche il più democratico del mondo, può rinunciare alle annessioni, una volta che è entrato in guerra.
Non ci voleva molto a credere che quello che diceva era una verità scontata, che la storia stesse delle civiltà antagonistiche ampiamente documentava; eppure a volte le cose più semplici da capire possono essere le più difficili da accettare. Bisogna arrivare a vincere se stessi, i propri pregiudizi, le proprie convinzioni illusorie. Un bagno di umiltà: ecco quello che occorreva ai socialisti rivoluzionari (ex populisti) e ai menscevichi (socialisti riformisti). Può infatti apparire incredibile che i leader di questi partiti considerassero un “disonore” non rispettare i trattati conclusi tra capitalisti, e che non considerassero tali trattati in contraddizione con la volontà del popolo (p. 242). Eppure ragionavano come se appartenessero al partito ultra-borghese dei cadetti o a un qualunque partito liberal-borghese d'Europa. L'intelligenza, l'acume intellettuale a volte può trasformarsi in stupidità solo perché non si vuole ammettere l'evidenza.
Lenin voleva semplicemente far capire che non c'era da aspettarsi nulla di buono dal governo provvisorio. I capitalisti – diceva – non sono migliori dei monarchici. “La 'democrazia' americana – cioè i capitalisti democratici – non ha forse saccheggiato la Filippine e non sta saccheggiando il Messico?” (p. 243).
I suoi avversari erano convinti che il governo provvisorio avrebbe creato un sistema sociale molto più democratico di tutti quelli occidentali. E si accontentavano. Lenin non era un testardo che voleva il massimo, ma semplicemente uno che non si faceva illusioni. Rifiutava anche l'accusa di volere una pace separata con la Germania. Si dirà che fu proprio quello che ottenne col trattato di Brest-Litovsk. In realtà erano due cose diverse. Quando i bolscevichi non erano ancora al governo chiedevano la pace per abbattere i governi borghesi, cioè perché ogni paese usasse il proprio esercito, ancora non smobilitato, in una guerra civile contro i propri governi. “Noi siamo contrari ai negoziati coi capitalisti – diceva –, noi vogliamo negoziati e fraternizzazione con gli operai e i soldati rivoluzionari di tutti i paesi” (p. 237).
Quando invece i bolscevichi andarono al potere, la situazione era così disperata che per fronteggiare la controrivoluzione avevano assolutamente bisogno d'essere in pace con la Germania. Lenin aspettava che in Germania scoppiasse la rivoluzione proletaria, ma il kaiser fu cacciato solo alla fine del 1918, e sostanzialmente da una rivoluzione borghese, che di socialista aveva solo il nome.
Nel maggio del 1917 Lenin aveva solo le seguenti certezze: “In Russia ci si può procurare il pane, in Germania no. Si può far molto in Russia con l'organizzazione. In Germania non si può fare più niente: non c'è più pane e il popolo è condannato a una catastrofe inevitabile” (p. 273).
La Risoluzione sulla guerra della VII Conferenza panrussa del Posdr, tenutasi nell'aprile 1917, riflette bene il pensiero di Lenin in quel momento rivoluzionario:
il governo provvisorio non ha intenzione di rendere pubblici i trattati segreti stipulati dallo zar Nicola II;
li ha confermati senza consultare il popolo, permettendo così ai capitalisti russi di saccheggiare Cina, Persia, Turchia, Austria ecc.;
ciò vuol dire che ogni promessa di rinuncia alle annessioni di nuovi territori o a tenere con la forza determinate nazionalità entro la Russia, è una promessa che non vale nulla. Di fatto il governo non ha intenzione di permettere a tutte le nazionalità dell'ex impero russo, di decidere con libere votazioni quale debba essere il loro destino.
La Conferenza aveva riconosciuto che non si poteva metter fine alla guerra “mediante il rifiuto dei soldati di una sola parte di continuare a combattere” (p. 246). Occorreva cioè che la cessazione del fuoco fosse almeno bilaterale.3 “Non preconizziamo una cosa impossibile e irrealizzabile come il metter fine alla guerra per volontà di una sola parte... È impossibile uscire facilmente da una guerra così spaventosa. Si combatte da tre anni. O combatterete per dieci anni o vi avvierete verso una rivoluzione difficile, gravosa. Non c'è altra soluzione” (p. 277).
Se Lenin fosse stato un “tolstojano” avrebbe perorato la causa della “pace unilaterale”, quella che uno Stato dichiara a prescindere dall'atteggiamento dell'avversario contro cui combatte. Invece su questo punto diceva: “Che una guerra condotta dai capitalisti delle potenze più ricche... possa concludersi con la decisione unilaterale di cessare le operazioni belliche è un'ipotesi sciocca...” (p. 274). Né avrebbe senso mercanteggiare le profferte di pace che i tedeschi potrebbero fare: “Ti darò un pezzetto di Turchia e di Armenia, se mi concederai dei territori ricchi di minerali”. Quando Lenin farà la pace di Brest-Litovsk darà ai tedeschi tutto quello che volevano, chiedendo in cambio solo la pace, quella che gli servì per eliminare la controrivoluzione interna. Se la situazione della Russia, dopo l'Ottobre, non fosse stata disperata, l'idea dominante sarebbe stata sempre la stessa: “A una guerra condotta dai capitalisti di tutti i paesi si può mettere fine soltanto con la rivoluzione operaia contro questi capitalisti” (p. 275).
La suddetta Conferenza metteva tutti i capitalisti sullo stesso piano, senza fare alcuna differenza tra gli Stati, proprio perché non sono i popoli che vogliono la guerra, ma i governi, i quali fanno gli interessi di determinate classi sociali. È quindi impossibile una pace democratica se il governo non diventa proletario, almeno in alcuni paesi belligeranti. “Pace democratica” vuol dire rinunciare a qualunque annessione e indennizzo.
“Ci si dice: 'In Germania tutti i socialisti sono favorevoli alla guerra. Il solo Liebknecht è contrario'. Rispondo: soltanto questo Liebknecht rappresenta la classe operaia...” (p. 279). Lenin è sempre stato favorevole all'idea che la minoranza deve adeguarsi alla volontà della maggioranza, ma qui stava dicendo che quando è in gioco la verità delle cose, non c'è maggioranza che tenga. Non si è mai sognato di fare una rivoluzione socialista aspettando di avere una maggioranza parlamentare. Non ha neppure cercato di avere una maggioranza in tutta la nazione prima di muoversi nella capitale. La stragrande maggioranza dei contadini militava in altri partiti. “Nessuno, tranne la rivoluzione operaia in alcuni paesi – diceva –, uscirà vincitore da questa guerra... mostruosa, che costa milioni di vite umane...” (p. 279). Lucidamente si era già reso conto che una guerra mondiale, durata già un triennio, avrebbe provocato danni enormi anche ai paesi vincitori. Era altresì consapevole che “i soldati al fronte non possono staccarsi dallo Stato e decidere per conto proprio” (ib.), per cui la rivoluzione poteva essere fatta solo nelle retrovie, nelle città e soprattutto nella capitale dell'ex impero zarista. I socialisti non potevano aspettare che il segnale venisse dato dai militari. Semmai doveva accadere il contrario: la rivoluzione doveva essere compiuta dai civili armati. Soltanto dopo i soldati si sarebbero ribellati agli ufficiali.
Nella stessa Conferenza si emana anche una Risoluzione sul momento attuale in cui viene detto che la guerra sta precipitando l'umanità... sull'orlo dell'abisso, cioè verso la fame. Le piccole e medie aziende stavano scomparendo. Il capitale era sempre più concentrato in poche mani e sempre più internazionalizzato. Il capitalismo monopolistico privato trapassava in capitalismo monopolistico-statale. Lo sfruttamento delle masse lavoratrici era sempre più intenso.
Lenin voleva far capire che c'erano tutte le condizioni per fare la rivoluzione. Non era importante chi l'avesse fatta per prima. Di sicuro chiunque l'avesse fatta, avrebbe avuto degli imitatori. La crisi era mondiale, non regionale. Infatti si profilavano scioperi di massa. Sul fronte russo-tedesco i soldati fraternizzavano, anzi cominciavano a ribellarsi ai loro ufficiali, i quali provenivano dalla classe borghese.
Lenin si difendeva dall'accusa di guidare un partito di anarchici, dicendo di volere “la migliore organizzazione delle masse e il potere 'statale' più forte”, a condizione che fosse strutturato secondo i consigli dei soviet (p. 252).4 La guerra sarebbe finita solo grazie a una rivoluzione proletaria, cioè di massa, non perché qualche statista sarebbe stato assassinato o perché qualche singolo paese avrebbe deciso di uscirne fuori. Doveva essere una rivoluzione proletaria a spaventare tutti i paesi belligeranti. Quando poi Lenin deciderà, il 3 marzo 1918, di fare una pace separata con gli Imperi centrali, dirà che se non l'avesse fatta, la Germania avrebbe potuto occupare la Russia, soffocandone la rivoluzione.5
1Le prime quattro lettere furono scritte tra il 7 e il 12 (20 e 25) marzo; la quinta fu iniziata alla vigilia della partenza dalla Svizzera il 26 marzo (6 aprile) 1917. Furono spedite a Pietrogrado, ma soltanto la prima fu pubblicata sulla “Pravda” del marzo 1917, le altre solo dopo la rivoluzione d'Ottobre. Le idee della quinta lettera incompiuta furono poi sviluppate nelle Lettere sulla tattica e nei Compiti del proletariato nella rivoluzione attuale.
2Le Tesi di aprile sono una serie di direttive politiche scritte il 3 aprile (16) 1917, il giorno stesso del suo rientro in Russia dall'esilio svizzero. Lenin le enunciò più volte il giorno dopo e le pubblicò sulla “Pravda” del 20 aprile con il titolo Compiti del proletariato nella rivoluzione attuale.
3Da notare che invece la posizione trotskista era favorevole a una dichiarazione unilaterale di cessazione della guerra da parte della Russia.
4Quanto agli anarchici veri e propri, una parte partecipò alla rivoluzione. Un'altra parte invece si armò contro il governo sovietico nell'aprile del 1918, unendosi agli elementi controrivoluzionari. Terrorizzavano la popolazione e occupavano le ville signorili per rubare oro e gioielli. Il loro quotidiano, “Anarkhia”, venne pubblicato a Mosca dal settembre 1917 al luglio 1918.
5Subito dopo il trattato di Brest-Litovsk la Germania dovette “accontentarsi” di reprimere nel sangue, dopo tre mesi di guerra civile, la rivoluzione comunista in Finlandia, scoppiata alla fine del gennaio 1918.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube