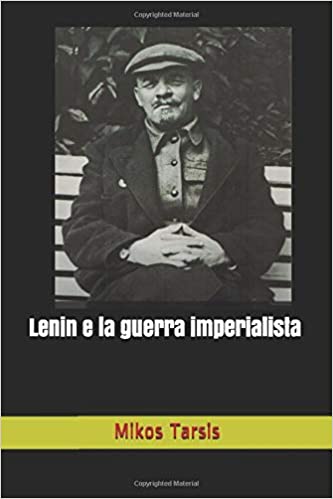
LENIN E LA GUERRA IMPERIALISTICA
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
Il capitalismo fino alla guerra imperialistica
La cosa che meno si capisce nell'analisi di Lenin è il motivo per cui esalta la nascita degli Stati nazionali, senza aggiungere che tali Stati si formarono non solo contro gli ultimi retaggi feudali, ma anche infischiandosene completamente del destino delle masse contadine. Tutte le unificazioni nazionali borghesi sono avvenute a discapito degli interessi dei contadini, i quali o sono dovuti diventare operai industriali o sono dovuti emigrare all'estero (p. es. dall'Europa al continente americano). Solo chi era già proprietario di un lotto di terra significativo ha potuto trasformarsi in un capitalista agrario. In Italia i contadini diedero vita anche al fenomeno del brigantaggio e successivamente a quello della criminalità organizzata.
Inoltre il colonialismo, se per molti versi è stato una conseguenza immediata della formazione del mercato nazionale, per altri versi ha addirittura preceduto tale formazione. Per es. in Spagna e Portogallo il colonialismo è avvenuto prima ancora che lo Stato fosse capitalistico. Anzi, si può dire che proprio grazie al colonialismo quegli Stati si sono illusi di poter fare a meno di uno sviluppo industriale delle loro società, limitandosi a un capitalismo meramente commerciale (e di rapina). Il colonialismo esiste sin dal tempo delle crociate, ed è stato proprio esso che ha permesso alle potenze europee di arricchirsi; anzi, in Europa occidentale esiste sin dal tempo dello schiavismo greco-romano.
Lenin vede positivamente gli Stati nazionali borghesi perché con essi il Medioevo ha avuto termine, anche se deve riconoscere che i grandi proprietari fondiari si erano trasformati in capitalisti agrari, ma non vede il rovescio della medaglia, e cioè l'assoluta proletarizzazione delle masse contadine, che passano da un padrone a un altro. O meglio non lo vede negativamente, ma come una inevitabile necessità. Gli interessa soltanto mostrare che lo sviluppo del capitalismo ha prodotto un proletariato industriale, che dovrà svolgere il ruolo di “becchino” della borghesia.
Per lui la I guerra mondiale è l'indizio più sicuro che il capitalismo industriale non può più svilupparsi pacificamente. Infatti “l'imperialismo è il capitalismo giunto a quella fase di sviluppo in cui si è formato il dominio dei monopoli e del capitale finanziario; l'esportazione di capitali ha acquistato grande importanza; è cominciata la ripartizione del mondo fra i trust internazionali ed è già compiuta la ripartizione dell'intera superficie terrestre tra i più grandi paesi capitalistici” (p. 220).1
Avrebbe però dovuto precisare meglio che lo sviluppo pacifico vi è stato soltanto nelle aree metropolitane dell'Europa occidentale, in quanto il capitalismo europeo non è mai stato “pacifico”, in nessun paese. Lenin avrebbe dovuto insistere di più sul fatto che il capitalismo europeo si era costruito sullo sfruttamento selvaggio delle colonie, sulle guerre coloniali in Africa, Asia, America Latina, anche se in Europa la situazione era tranquilla, in quanto al massimo si poteva notare la disperazione dei contadini privi di terra e lo sfruttamento della classe operaia.
Lenin non vede la necessità di realizzare il socialismo dopo la devastazione compiuta contro il mondo contadino e contro i paesi non europei. La vede soltanto quando i paesi europei non possono più svilupparsi al di fuori dei loro confini nazionali e al di fuori dei loro imperi coloniali, acquisiti durante la seconda metà dell'Ottocento. Lenin inizia a denunciare la vergogna del colonialismo solo quando scoppia la I guerra mondiale. Pensa che tale guerra segni la fase finale del capitalismo internazionale, ma non considera che se il proletariato dei paesi capitalisti più avanzati e le colonie di questi paesi non si ribellano al loro sfruttamento, questa fase può durare un tempo illimitato, o comunque un tempo non così facilmente quantificabile.
Non si può parlare di “fase finale” solo perché le potenze capitalistiche si ammazzano tra di loro. Non si può parlarne anticipatamente, prima che i nemici del capitalismo si siano ribellati. Si può soltanto dire che quando sulla scena mondiale appaiono nuovi Stati capitalisti, vi è sempre la tendenza a mettere in discussione la ripartizione delle colonie o comunque le modalità di sfruttamento delle risorse di tali colonie; ma vi è anche la tendenza (soprattutto dopo le due catastrofiche guerre mondiali) a cercare delle intese che possano scongiurare il rischio di distruggersi a vicenda. Ciò in quanto si è consapevoli del potenziale distruttivo delle armi in proprio possesso.
Quella “fase finale” di cui Lenin parlava all'inizio del Novecento, oggi esiste ancora, seppur in forme diverse, ed esiste proprio perché lo sfruttamento delle colonie ha subìto importanti modificazioni. Per es. la Germania, che pur ha perso due guerre mondiali, oggi è ancora uno degli attori principali del capitalismo non solo europeo ma mondiale. Ha soltanto cambiato il modo in cui si è posta sui mercati. Non ha bisogno di ricorrere alle armi: le basta la qualità dei suoi prodotti, la strategia di marketing, la politica finanziaria... Ed è ai primi posti pur senza avere un proprio “commonwealth”, un rapporto coloniale o semicoloniale con qualche area del pianeta. Anche il Giappone, pur avendo perduto la guerra, è tra i primi posti al mondo per la qualità dei suoi prodotti.
Il concetto di “fase finale” (o “fase suprema”) poteva essere usato come arma propagandistica per indurre il proletariato a insorgere, ma, a guerra conclusa, quando il potere di Francia e Inghilterra aumenterà ancora di più, non avrà alcun senso. Scompariranno dalla scena gli imperi ottomano, austro-ungarico, russo e prussiano2, ma emergeranno due nuove potenze: Stati Uniti e Giappone. E a partire dal 1933, col nazismo al potere, la Germania tornerà ad essere una grande potenza. Diciamo che se i partiti socialisti avessero seguito l'invito di Lenin a trasformare la guerra imperialistica in guerra civile, il mondo si sarebbe risparmiato la II guerra mondiale. Ora però che sulla scena internazionale è entrata anche la Cina, difficilmente l'umanità si risparmierà la terza.
Nel 1915 Lenin poteva tranquillamente affermare che “la politica coloniale ha portato alla spartizione di quasi tutto il globo terrestre” (p. 86). Questo è potuto avvenire in presenza di una monopolizzazione della produzione, che si muove (sia come merci che come capitali) in un ambito internazionale. Era infatti opinione comune che l'imperialismo si fosse formato nel periodo 1876-1914, cioè nel pieno della maturità degli Stati nazionali. Così infatti scrive: “Il capitalismo ha sviluppato a tal punto la concentrazione, che interi rami dell'industria sono nelle mani di sindacati, di trust, di associazioni di capitalisti miliardari, e quasi tutto il globo è diviso tra questi 'signori del capitale', o in forma di colonie o mediante la rete dello sfruttamento finanziario che lega con mille fili i paesi stranieri” (pp. 137-8).
Per lui un ulteriore sviluppo non avrebbe potuto esserci, se non per alcuni Stati, che avessero fatto fuori i loro concorrenti. A ben guardare tutto ciò era potuto avvenire mentre i paesi europei praticavano già da tempo il colonialismo. La guerra imperialistica era stata scatenata dall'esigenza di possedere ancora più territori stranieri, extra-nazionali; un'esigenza che veniva a scontrarsi con quella di farsi un mercato mondiale da parte degli ultimi arrivati (Germania, Austria-Ungheria, Russia, Giappone, Stati Uniti e Italia).
“Il libero commercio e la concorrenza – scrive Lenin – sono stati sostituiti dalla tendenza al monopolio, dall'usurpazione di terre per impiegarvi dei capitali, per esportare materie prime, ecc.” (p. 138). Questo era senza dubbio vero, ma tutto ciò i principali paesi capitalisti europei (Francia e Inghilterra) l'avevano già. Non avrebbero fatto esplodere una guerra mondiale per averne ancora di più, poiché in quel momento non erano in grado di sfruttare sino in fondo neanche le colonie che già possedevano. Al massimo avrebbero fatto scoppiare delle guerre regionali (p. es. contro l'impero ottomano in sfacelo o contro quello cinese in decadenza).
Considerando quindi che non vi era stata alcuna ribellione in massa delle colonie europee, non restava che una spiegazione per motivare lo scoppio della guerra imperialistica mondiale: erano entrati in scena, quasi contemporaneamente, nuovi competitori europei, che ovviamente rivendicavano il loro “spazio vitale”, le loro aree coloniali. La guerra non scoppiò per colpa dell'Austria, ma perché l'Austria fu immediatamente appoggiata dalla Germania, che cercava un pretesto per farla scoppiare. La Francia e l'Inghilterra erano sazie di colonie e non avrebbero mai fatto scoppiare una guerra “mondiale”: se avessero voluto farlo avrebbero estromesso Spagna e Portogallo dall'America Latina. Al massimo si sarebbero messe d'accordo con la Russia (e in parte con l'Italia, che voleva l'Albania) per spartirsi l'impero ottomano e i Balcani. L'Austria sarebbe arrivata sino all'Egeo, occupando la Grecia, e lì si sarebbe fermata. Giappone e Stati Uniti cominciavano ad affacciarsi in Asia, ma non sarebbe scoppiata una guerra mondiale per colpa loro: il Giappone perché ancora troppo piccolo, e gli Usa perché già troppo grandi e perché erano in procinto di monopolizzare con le loro merci industriali l'intera America Latina, senza bisogno di fare una guerra militare vera e propria contro Spagna e Portogallo.
Non ha quindi molto senso dire frasi come la seguente: “Da liberatore delle nazioni quale era nella lotta contro il feudalesimo, il capitalismo, nella fase imperialista, è divenuto il maggiore oppressore delle nazioni” (p. 138). Non ha senso sostenere che nell'arco di mezzo secolo il capitalismo si era trasformato da “liberatore” a “oppressore”. Era oppressore anche mentre svolgeva il ruolo del “liberatore”. La borghesia ha semplicemente sostituito un'oppressione con un'altra, senza soluzione di continuità, e se ha svolto un ruolo “liberatorio”, l'ha svolto solo per sé, non per l'intera collettività nazionale e, tanto meno, per il mondo.
D'altra parte lo stesso Lenin lo dice chiaramente: “le colonie furono conquistate col ferro e col fuoco” (p. 139). Dunque perché sostenere che nel momento in cui si realizzarono gli Stati nazionali la borghesia svolse un ruolo progressista? In realtà la borghesia non accettò mai, nel mentre si preoccupava di abbattere il potere degli aristocratici, di venire incontro alle esigenze dei contadini, né fu mai interessata all'idea di un socialismo agrario. Anzi, in taluni paesi (Germania, Italia) la borghesia, dopo aver acquisito il potere politico, scese a compromessi con l'aristocrazia semi-feudale, permettendo a questa di conservare il potere economico (che si stava sempre più orientando verso uno sviluppo capitalistico), proprio per evitare che i contadini rivendicassero la distribuzione gratuita delle terre. L'aristocrazia che sopravvisse alla guerra contro la borghesia si trasformò ben presto in borghesia agraria. I contadini in eccesso o non competitivi furono espulsi dalla terra o costretti ad abbandonarla, generando imponenti flussi migratori verso il continente americano e in tante altre parti del mondo. Molti altri contadini diventarono operai, militari o si diedero alla criminalità organizzata.
Lenin non parla mai di queste cose. Per lui la borghesia svolse un ruolo progressista proprio perché generò una nuova classe, il proletariato industriale, destinato a sostituirla nella gestione proprietaria dei mezzi produttivi. In realtà la borghesia, benché dicesse che il lavoro era fonte di ricchezza, era una classe parassitaria come quella aristocratica. Infatti voleva vivere sfruttando il lavoro altrui: la differenza stava soltanto nei mezzi e nei modi a disposizione, ma l'intenzione era la stessa. La borghesia fu costretta a ricorrere all'uso delle macchine proprio perché la proprietà della terra era monopolizzata dai nobili, che un tempo l'avevano conquistata grazie alle loro capacità militari.
La borghesia fece due rivoluzioni inedite: quella tecnico-scientifica e quella giuridica. Con la prima si arricchì sfruttando la forza-lavoro (manuale e intellettuale) del proletariato. Con la seconda s'inventò un rapporto di lavoro basato sul contratto, stipulato liberamente: l'operaio non era né uno schiavo né un servo, ma una persona giuridicamente libera. Siccome però non possedeva nulla, il suo destino era quello di diventare uno “schiavo salariato”. Il salario era il mezzo che l'operaio usava per acquistare sul mercato le merci ch'egli stesso aveva prodotto in fabbrica. Si può chiamare “progresso” una situazione del genere? Fino a che punto? Se non ci fosse stato il colonialismo, che fine avrebbe fatto il capitalismo in Europa? Quanto tempo sarebbe durato? Le guerre civili non sarebbero forse state all'ordine del giorno? Nella Roma classica l'esigenza di compiere continue guerre non era forse dettata dall'impossibilità di risolvere pacificamente e democraticamente gli antagonismi creati dalla proprietà privata?
Per Lenin invece era esistita una fase “progressiva”. “Da progressista il capitalismo è divenuto reazionario; ha sviluppato a tal punto le forze produttive che l'umanità deve o passare al socialismo o sopportare per anni, e magari per decenni, la lotta armata tra le 'grandi' potenze per la conservazione artificiosa del capitalismo mediante le colonie, i monopoli, i privilegi e le oppressioni nazionali di ogni specie” (p. 138). Peccato però che la storia abbia dimostrato che là dove si è sviluppato fortemente il capitalismo, le idee del socialismo sono venute meno, e che queste idee permangono invece nelle sue aree più arretrate, quelle appunto coloniali. Il capitalismo, nelle madrepatrie occidentali, è stato così “progressista” da togliere ogni capacità rivoluzionaria a favore del socialismo. E non è affatto detto che l'esigenza di una transizione socialista maturi nelle madrepatrie occidentali solo quando qui si viene posti di fronte agli orrori della guerra.
Se vi fosse un minimo di sensibilità rivoluzionaria, un minimo di coscienza, si prenderebbero le difese di quei movimenti rivoluzionari che nelle colonie vogliono ribellarsi al loro sfruttamento. Invece vengono guardati con distacco, con sufficienza, anzi, con preoccupazione, poiché si teme che con le loro iniziative eversive si minacci la stabilità del sistema, degli scambi commerciali, degli affari internazionali, delle borse di titoli e valori...
Ma lasciamo parlare Lenin. A suo giudizio la guerra era “imperialistica” a causa del confronto esistente in Europa occidentale tra Francia, Inghilterra e Germania; poi perché la Russia zarista aveva intenzione di occupare la Persia, la Mongolia, la Turchia asiatica, Costantinopoli e la Galizia. La guerra austro-serba aveva, rispetto a questi obiettivi, un'importanza del tutto secondaria. A tale proposito riporta una tabella demografica molto importante alle pp. 138-9, in cui risulta evidente che fino al 1918 chi dominava la scena mondiale era l'Inghilterra (lo sarà sino alla II guerra mondiale); probabilmente essa sarebbe stata seguita dalla Russia se non vi fosse stata la rivoluzione d'Ottobre.
Sei grandi potenze dominavano il mondo intero: Inghilterra, Russia, Francia, Germania, Giappone e Stati Uniti. Tuttavia la tabella parte dal 1876, quando già l'Inghilterra era una superpotenza grazie al proprio colonialismo, che aveva un'estensione superiore alla stessa Russia. A tutto il 1914 la Francia aveva, come grandezza fisica, la metà dei territori di cui disponeva la Russia. Quindi “dal 1876 al 1914 sei 'grandi' potenze depredano 25 milioni di kmq, una superficie 2,5 volte l'intera Europa, assoggettando 523 milioni di persone nelle colonie, su un totale di 1 miliardo e 657 milioni di abitanti dell'intero pianeta”. Il solo zarismo opprimeva 100 milioni di uomini e donne di diverse nazionalità all'interno dell'impero.
Al II Congresso del Komintern (19 luglio 1920) dirà: “Quarant'anni fa la popolazione delle colonie, sottomessa a sei potenze capitalistiche, ammontava a poco più di 250 milioni di uomini. Alla vigilia della guerra del 1914 la popolazione delle colonie si aggirava intorno ai 600 milioni e, se si aggiungono dei paesi come la Persia, la Turchia e la Cina, che già allora si trovavano nella posizione di semicolonie, si avrà in cifra tonda una popolazione di un miliardo di uomini oppressi...” (p. 358).
Sotto questo aspetto i socialisti non devono decidere il loro comportamento guardando chi ha dichiarato per primo la guerra o chi ha esploso il primo colpo di cannone. “Le frasi sulla difesa della patria, sulla resistenza all'invasione nemica, sulla guerra di difesa, ecc., sono tutti raggiri per ingannare il popolo” (p. 87).
Le ultime “guerre nazionali” si sono svolte dal 1789 al 1871, per combattere l'assolutismo feudale e l'oppressione straniera, per creare Stati nazionali borghesi. A quel tempo ci si era serviti, positivamente, dell'ideologia “nazionale”, anche se nelle guerre francesi (con Napoleone) si cercò di occupare territori altrui. D'altra parte anche nella guerra franco-tedesca (dell'ultimo trentennio dell'Ottocento) la Germania depredò la Francia, eppure fu proprio con quella guerra che il popolo tedesco fu liberato dal frazionamento feudale e dall'oppressione di due despoti: lo zar russo e Napoleone III.
In queste guerre Lenin vede solo la borghesia contro la nobiltà, non vede anche la borghesia contro i contadini. Quest'ultimi svolsero il ruolo di manovalanza negli eserciti della borghesia, ma, a guerra conclusa, non ottennero che una minima parte delle terre promesse. Spesso quelle che si requisivano (molte agli ordini regolari religiosi, poche ai latifondisti laici) venivano semplicemente messe all'asta, al miglior offerente. La borghesia non ha mai tolto tutta la terra ai latifondisti e, meno ancora, ha mai pensato di redistribuirla gratuitamente ai contadini.
Bisogna ammettere che Lenin faceva troppe concessioni al ruolo storico della borghesia. Se ne avesse fatte di meno, avrebbe dovuto ritenere l'imperialismo una diretta conseguenza delle unificazioni nazionali, condotte in nome degli ideali borghesi. Non è infatti possibile considerare l'unificazione nazionale come in sé migliore del frazionamento regionale tipico del feudalesimo. Lenin la considerava migliore perché, associata ad essa, vi fu lo sviluppo dell'industrializzazione (già Marx ed Engels avevano sempre giudicato migliore il profitto industriale rispetto alla rendita feudale). Ma resta tutto da dimostrare che tale industrializzazione, presa in sé, abbia davvero costituito un progresso per l'umanità. Sul piano teorico non vi era alcun motivo di considerare il capitalismo l'unica alternativa possibile al feudalesimo. Il fatto che il marxismo non abbia mai messo in discussione una transizione del genere non andava preso come un dogma.
Che Lenin non vedesse il mondo contadino nella lotta della borghesia contro l'aristocrazia, è evidente in questa sua frase: “Fino all'abolizione del feudalesimo, dell'assolutismo e dell'oppressione straniera, non si poteva nemmeno parlare di uno sviluppo della lotta proletaria per il socialismo” (p. 136). Qui gli errori sono due: 1) identifica col concetto di “proletariato” solo quello industriale e non anche quello agricolo; 2) identifica col concetto di “socialismo” solo quello formulato nell'Ottocento (prima dagli utopisti, poi dal marxismo), ma le lotte contadine a favore della propria emancipazione giuridica, libertà personale e acquisizione delle terre padronali avevano tutte le caratteristiche del socialismo, pur in assenza di un'ideologia specifica. Vi sono forme di socialismo persino nei movimenti pauperistici ereticali del Medioevo. La guerra contadina capeggiata in Germania da Müntzer era una forma di “socialismo agrario” ante-litteram. Vi era del “socialismo” persino tra gli Esseni al tempo di Gesù Cristo, e lo stesso movimento nazareno rappresentava una forma di socialismo rivolto ai centri urbani.
Inutile dire che all'interno di una concezione così deterministica ed evoluzionistica della storia, anche il colonialismo veniva ad essere giustificato, proprio in quanto esso è contestuale, parallelo al capitalismo. Non c'è capitalismo senza colonialismo, benché non tutte le forme di colonialismo favoriscano il capitalismo (impero romano docet), tanto meno quello industriale (gli imperi ispano-portoghesi non arrivarono mai a questo stadio). Per arrivare al capitalismo occorre un'ideologia, una cultura, una mentalità... e per arrivare a quello industriale un'altra ancora, altrimenti l'Italia, coi suoi Comuni borghesi nati nel Mille, sarebbe stato il primo paese ad arrivarci.
In ogni caso Lenin aveva perfettamente ragione a considerare che l'ideologia nazionale della borghesia, un tempo progressiva, era diventata particolarmente reazionaria durante l'imperialismo, e che nei confronti di tale ideologia bisognava ribadire una delle tesi principali del Manifesto, secondo cui “gli operai non hanno patria”.
La guerra civile doveva appunto servire:
per espropriare i capitalisti e i grandi proprietari terrieri;
per sostituire le monarchie con le repubbliche democratiche;
per imporre la giornata lavorativa di otto ore.
Lenin non vede (almeno qui) il periodo pacifico che va dalla Comune di Parigi alla I guerra mondiale strettamente collegato allo sfruttamento delle colonie né alla disperazione dei contadini. Di esso dà una duplice valutazione:
è stato un periodo positivo, poiché ha insegnato alla classe operaia a utilizzare il parlamentarismo, la cooperazione, i sindacati, la stampa, ecc.;
è stato un periodo negativo, poiché i leader socialisti hanno avuto la tendenza a negare la lotta di classe, a predicare la pace sociale, a negare l'obiettivo della rivoluzione socialista, a rifiutare le organizzazioni illegali, a riconoscere il patriottismo borghese, ad accettare il formarsi della burocrazia nel movimento operaio e di una certa aristocrazia operaia tra i lavoratori industriali, sfruttando sovrapprofitti provenienti dalle colonie e accettando troppi elementi piccolo-borghesi nelle file del partito.
Questo opportunismo di lunga durata ha poi portato ad approvare i crediti militari, a partecipare ai ministeri borghesi, a vincolarsi alla pace civile in caso di guerra, a rinunciare a istituire organizzazioni clandestine.
Tuttavia Lenin non si chiede come sarebbe potuto avvenire diversamente. Avrebbe dovuto dire che l'opportunismo era anche frutto del fatto che il socialismo scientifico non si era mai interessato alla questione contadina, se non per dire che la penetrazione del capitalismo nelle campagne andava considerata un fatto inevitabile, essendo lo sviluppo industriale (frutto di una grande rivoluzione tecnologica) prioritario su tutti i retaggi del passato. Il capitalismo doveva essere ammazzato dagli operai, almeno nella gestione privata dei mezzi produttivi, ma solo dopo essersi impadroniti dei segreti della tecnologia, per poterla sviluppare in maniera indefinita: nel frattempo avrebbero dovuto essere i contadini a pagare il prezzo dello sviluppo industriale. Si giudicavano male i contadini perché non li si vedeva capaci di liberarsi da soli dei retaggi feudali, anche perché troppo influenzati dalle idee religiose, troppo privi di cultura scientifica, troppo individualisti nella loro tipologia di lavoro... Sottovalutando l'importanza della questione contadina, si sottovalutò anche quella coloniale, dove i contadini erano ancora più presenti, spesso con tradizioni ancora più antiche di quelle feudali, e dove l'industria era praticamente inesistente.
Il socialismo scientifico voleva che l'industria si diffondesse in tutto il mondo, esattamente come lo volevano i capitalisti. La differenza doveva stare soltanto nella gestione della proprietà dei mezzi produttivi, che da privata doveva diventare sociale, pubblica. Come poteva sperare Lenin che i partiti socialisti europei avessero idee rivoluzionarie quando sulla questione contadina e coloniale non dicevano una sola parola “sensata”? quando l'industrializzazione europea conosceva un proprio impetuoso sviluppo pagato dai contadini e dalle colonie?
Di rilievo, nella sua analisi, era piuttosto un'altra cosa. Con la sua definizione di “aristocrazia operaia” sembrava essere diventato impossibile parlare di classi sociali in astratto, di proletariato qua talis. È certamente possibile, oggettivamente, distinguere tra chi è proprietario dei mezzi produttivi e chi è nullatenente, ma tutto il resto sembra dipendere dai comportamenti soggettivi. Non ci si può considerare “migliori” solo perché si appartiene a una classe piuttosto che a un'altra.
Dal punto di vista dell'imperialismo il proletariato occidentale è compartecipe (seppure in modo diverso) dello sfruttamento di risorse umane e materiali perpetrato dall'industria borghese nei confronti delle colonie. Sono le “briciole” dei grandi profitti realizzati dalla borghesia imperialistica che fanno diventare opportunisti molti dirigenti socialisti e una parte della classe operaia, poiché con quelle briciole si possono garantire salari e stipendi più alti. Insomma ci si vende per un piatto di lenticchie.
Se si è consapevoli di questo dramma, che obbliga l'operaio ad assumere, oggettivamente, un ruolo da sfruttatore, anche contro le proprie intenzioni, non è possibile, oggi, organizzare un partito rivoluzionario senza che abbia rapporti con partiti analoghi esistenti nelle colonie. Bisogna dimostrare al proletariato colonizzato che si è disponibili a compiere azioni comuni contro le medesime multinazionali. Occorre realizzare il più presto possibile, e con insistenza, una fiducia reciproca basata su azioni concrete (p. es. il sostegno reciproco in caso di sciopero, l'invio di generi alimentari di prima necessità e di medicine se vi è una situazione molto critica da affrontare, l'uso di petizioni o proteste pubbliche mondiali per denunciare abusi o violazioni dei diritti umani).
Questo per dire che occorre assolutamente sottrarsi all'egemonia dei mercati mondiali, che non permettono in alcun modo di sapere come le merci vengono prodotte. Occorre che i mercati ridiventino locali. Questo è l'unico modo che permette al consumatore di controllare il produttore; anzi, è l'unico modo che permetterà, in prospettiva, la coincidenza di produttore e consumatore.
Ma quali saranno le condizioni perché si possa verificare un'inversione di tendenza così radicale? Lenin si sentiva in grado di prevedere solo la seguente condizione: “Sarebbe impossibile metter fine al dominio del capitalismo, se a ciò non conducesse tutto lo sviluppo economico dei paesi capitalistici. La guerra ha accelerato questo processo, rendendo ormai impossibile il capitalismo. Nessuna forza distruggerebbe il capitalismo se la storia stessa non lo corrodesse e non lo minacciasse” (p. 276).
Parole difficili da accettare. Chiunque infatti avrebbe potuto obiettargli ch'era prematuro pensare di fare una rivoluzione socialista in Russia quando il resto del mondo capitalistico era, in quel momento, tutt'altro che in crisi. Quanto meno una rivoluzione del genere avrebbe avuto senso se fosse stata concertata all'interno di due grandi potenze capitalistiche mondiali (p. es. Germania e Russia), altrimenti le possibilità di successo sarebbero state minime. E forse la storia avrebbe dato torto a Lenin anche a prescindere dall'involuzione autoritaria dello stalinismo.
Inevitabilmente, vedendo una guerra mondiale, con tutti gli orrori annessi e connessi, Lenin aveva le sue buone ragioni nel ritenere imminente il crollo del capitalismo europeo e quindi mondiale, ma probabilmente lo diceva per indurre il suo uditorio ad avere più fiducia nelle possibilità di una rivoluzione socialista in Russia. Se i bolscevichi avessero avuto successo, egli pensava che sarebbero stati facilmente imitati.
Un'infinità di volte aveva detto che la guerra si sarebbe conclusa con la vittoria di uno dei due schieramenti in campo: anglo-francese da una parte, austro-tedesco dall'altra. Il vincitore avrebbe occupato gran parte dell'intero pianeta. Lenin sapeva benissimo che i livelli di maturazione delle crisi e di consapevolezza di un'alternativa erano molto diversi tra le nazioni più avanzate del mondo.
1Per una definizione più precisa della natura dell'Imperialismo bisogna leggersi il libro specifico che Lenin dedicò a questo argomento.
2Tra i più barbari dispotismi d'Europa Lenin mette al primo posto quello ottomano e al secondo quello russo.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube