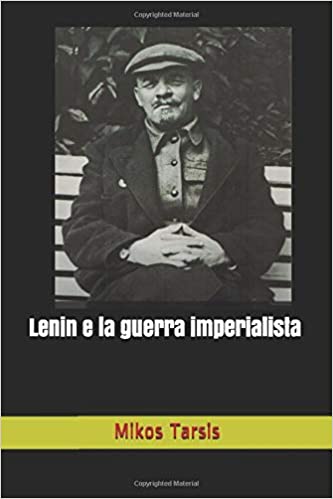
LENIN E LA GUERRA IMPERIALISTICA
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
Congressi e Conferenze della II Internazionale
(1889-1914)
- I Congresso (costitutivo), a Parigi, nel centenario della presa della Bastiglia (14-20 luglio 1889). Vi prendono parte 391 delegati provenienti da 22 paesi d'Europa (221 francesi, 81 tedeschi, 22 inglesi, 14 belgi, 8 austriaci, 6 russi, e delegazioni minori da Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Svizzera, Polonia, Romania, Italia, Ungheria, Spagna, Portogallo, Boemia e Bulgaria) e osservatori dagli Stati Uniti, Argentina e Finlandia. Fra i principali partiti coinvolti il Partito Socialdemocratico Operaio austrotedesco, la Sezione Francese dell'Internazionale Operaia, il Partito Socialista Italiano, il Partito Operaio Socialdemocratico Russo e il Partito Laburista inglese, ma il ruolo guida l'ebbe il Partito Socialdemocratico di Germania. L'Internazionale non aveva un'organizzazione centralizzata, ma si limitava ad essere la centrale di coordinamento fra i partiti collegati al movimento operaio nelle diverse nazioni.
Argomenti trattati: legislazione internazionale del lavoro; giornata lavorativa di 8 ore; divieto del lavoro dei fanciulli e misure atte a proteggere il lavoro dei ragazzi e delle donne; viene deciso di organizzare per il 1° maggio 1890 una manifestazione per la riduzione della giornata lavorativa a 8 ore, da tenersi simultaneamente in tutti i paesi. Vi partecipano W. Liebknecht, A. Bebel, E. Bernstein (non ancora “revisionista”), K. Zetkin, J. Guesde, E. Vaillant, Ch. Longuet e P. Lafaurge (questi ultimi due generi di Marx), C. de Paepe e E. Vandervelde (Belgio), V. Adler (Austria), L. Frankel (Ungheria), P. Iglesias e J. Mesa (Spagna), G. V. Plechanov (Russia), A. Costa e A. Cipriani (Italia). (Eleanor Marx, “Tussy”, è presente come delegata per la Francia.)
La prima fase della II Internazionale viene individuata nel periodo fra il 1889 e il 1896, mentre l'economia capitalistica mondiale, ancora in recessione in conseguenza della crisi del 1873, sembra stia per crollare. In questo clima Friedrich Engels, Karl Kautsky, Eduard Bernstein, Paul Lafargue, Georgij V. Plechanov, Antonio Labriola, Otto Bauer, Rudolf Hilferding e altri, elaborarono il cosiddetto “marxismo ortodosso”, secondo cui il crollo del capitalismo era inevitabile, ma poteva e doveva essere accelerato dalla lotta parlamentare (soprattutto per ottenere il suffragio universale e la giornata lavorativa di 8 ore). L'atteggiamento di questi socialisti era perciò di attendismo e di ottimismo.
- II Congresso, a Bruxelles (16-22 agosto 1891). Partecipano 337 delegati di 15 paesi europei e Stati Uniti. Punti principali: lotta al militarismo; questione sindacale e lavorativa (centralità dei sindacati e dello sciopero, abolizione del cottimo); rendere permanente il 1° maggio come giornata di lotta internazionale per le 8 ore1; parità diritti civili e politici alle donne.
- III Congresso, a Zurigo (6-12 agosto 1893). Oltre 400 delegati di 20 paesi. Risoluzioni: preclusione agli anarchici, assolutamente contrari al ruolo dello Stato (verranno definitivamente espulsi dall'Internazionale al Congresso di Londra del 1896); uso tattico del parlamento per la conquista rivoluzionaria del potere politico; lotta al militarismo, contro i crediti di guerra, per il disarmo e l'abolizione degli eserciti permanenti. Engels, eletto presidente, chiude il Congresso (morirà nel 1895).
- IV Congresso, a Londra (27 luglio-1 agosto 1896), con 476 delegati. Si dibatte del diritto delle nazioni all'autodeterminazione e sulla politica anti-coloniale. Nella risoluzione finale il Congresso prevede l'ineluttabile rivoluzione socialista e considera che lo sviluppo economico e industriale avanza con tale rapidità che una crisi si può verificare in un tempo relativamente breve. Il Congresso insiste dunque presso il proletariato di tutti i paesi sull'assoluta necessità di insegnare ai cittadini coscienti della loro classe ad amministrare i loro rispettivi paesi, nell'interesse comune. Undici partiti furono rappresentati da esponenti quali Bebel, Liebknecht, Singer, Adler, Plechanov ecc. Il 31 luglio si tenne anche una riunione privata delle delegate socialiste femminili.
- V Congresso, a Parigi (23-27 settembre 1900), forte delegazione russa (23) e polacca, la quale, con R. Luxemburg animò il dibattito sull'anti-militarismo (e contro il colonialismo). L'Internazionale era fondamentalmente una federazione di partiti, cassa di risonanza delle diverse problematiche nazionali. Per dare un coordinamento ai partiti nazionali nel 1900 fu costituito un ufficio permanente, il Bureau Socialiste International (BSI), composto da due delegati per Paese, convocato periodicamente in riunione plenaria, con sede a Bruxelles: disponeva di una Segreteria permanente, mentre la delegazione belga svolgeva la funzione di Comitato esecutivo. Il BSI terrà, dal 1901 al 1914, 16 riunioni plenarie (Lenin vi rappresentò il Posdr dal 1907 al 1914). A esso si aggiunse nel 1904 la Commissione Interparlamentare Socialista, che avrebbe dovuto coordinare l'attività parlamentare nei vari Paesi. Questi organi ebbero poca efficacia, soprattutto in occasione della Grande Guerra.
Intanto una seconda fase dell'Internazionale socialista si avviò alla fine dell'Ottocento, quando il capitalismo uscì dalla crisi riorganizzato e vitale: questo confutava la speranza in una prossima caduta del sistema. Inoltre si era creato un ceto piccolo-borghese benestante. Il fatto che il capitalismo non si fosse avviato alla crisi, ma fosse riuscito a superarla e a evitare il crollo era ritenuto da taluni un errore nella teoria marxiana. Da ciò nacque in alcuni esponenti socialisti l'esigenza di una riformulazione di alcune fondamentali teorie marxiste. Questa corrente, pur sempre minoritaria, fu detta “revisionismo” ed ebbe il suo maggior esponente in Eduard Bernstein. Per Bernstein in Marx c'erano ancora residui hegeliani nella dialettica che lo portavano a generalizzazioni eccessive, che non tenevano conto della realtà e creavano illusioni quali appunto il crollo del sistema capitalista, la caduta tendenziale del saggio di profitto, ecc. Constatata la vitalità del sistema borghese, i revisionisti sostennero un programma di riforme da attuarsi attraverso la sola lotta parlamentare.
- VI Congresso, ad Amsterdam (14-20 agosto 1904). Argomenti trattati: 1) tattica internazionale; 2) politica coloniale; 3) sciopero generale; 4) politica sociale e assicurazioni sociali per gli operai; 5) i trusts e la disoccupazione, ecc. Bebel e Kautsky giungono al Congresso vantando la loro lotta al revisionismo di Bernstein. Jaurès giudica il suddetto anti-revisionismo più formale che sostanziale, e rivendica maggior libertà di azione (riformistica) ai singoli partiti nazionali.2 La “risoluzione di Dresda” (che approvava la linea tedesca anti-revisionista) passa con 25 voti a favore, 5 contrari e 12 astensioni. Si decise, inoltre, che in ogni paese ci dovesse essere un solo partito socialdemocratico. Per la questione dello sciopero generale come arma di lotta del proletariato, fu approvata la risoluzione olandese proposta da Henriette Roland-Holst con 36 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astensioni. Durante la discussione sulla questione coloniale, fu approvata una risoluzione a firma di S. G. Hobson, della società Fabiana inglese, di denuncia del saccheggio britannico dell'India.
- VII Congresso, a Stoccarda (18-24 agosto 1907). Presenti 884 delegati di 25 nazioni, incluse Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Inghilterra, Germania, Italia, India, Giappone, Norvegia, Polonia, Russia, USA e un delegato dal Sud Africa. Furono approvati gli statuti e i regolamenti dei Congressi e del BSI.
La terza e ultima fase della Seconda Internazionale viene individuata nel periodo successivo alla rivoluzione russa del 1905. Questo evento rilanciò la prospettiva rivoluzionaria, che non negava l'utilità delle riforme, ma affermava ch'esse non erano sufficienti a ottenere l'emancipazione del proletariato. I gruppi rivoluzionari erano piccoli e molto divisi fra loro: si andava dalla sinistra radicale tedesca di Rosa Luxemburg ai bolscevichi di Lenin, dai tribunisti olandesi di Anton Pannekoek ai guesdisti francesi.
La corrente rivoluzionaria guidata da Rosa Luxemburg, Lenin e Martov, contrari a ogni patriottismo, si scontrò coi moderati, i quali, in caso di guerra, si proclamavano decisi, a determinate condizioni, a difendere il proprio paese. Questo era un punto chiave. Infatti lo scoppio della prima guerra mondiale comportò la fine della II Internazionale, poiché prevalsero, nella maggior parte dei partiti socialisti aderenti, l'istinto patriottico su quello internazionalista e la necessità di accorrere a difendere i rispettivi paesi impegnati nel conflitto.
Le mozioni sul tema della guerra furono quattro (Bebel, Guesde, Hervé e Vaillant-Jaurès): quella approvata fu una sorta di compromesso che impegnava i partiti aderenti a fare del loro meglio per impedire la guerra, ma, qualora questa fosse scoppiata, a fare il possibile per concluderla al più presto, approfittando dell'occasione per provocare la caduta del capitalismo.
Vennero discusse anche la questione coloniale; i rapporti tra i partiti socialisti e i sindacati; l'emigrazione e la questione femminile (voto alle donne). Si tenne anche una Conferenza internazionale delle donne socialiste, con 58 delegate di 13 paesi e numerose osservatrici, nella quale fu deciso di creare un Ufficio di informazione internazionale delle donne socialiste. Clara Zetkin fu eletta segretaria, e la rivista “Die Gleichhit” da lei redatta e edita a Stoccarda fu designata organo del movimento internazionale delle donne socialiste.
- VIII Congresso, a Copenhagen (28 agosto-3 settembre 1910). I paesi rappresentati sono 336, i delegati 896 (tra cui Lenin, mancava Bebel per malattia). Viene ripreso il dibattito sullo sciopero generale contro la guerra (che era stato taciuto nella risoluzione di Stoccarda), ma nella risoluzione finale ci fu solo la conferma delle tesi di Stoccarda, con in più uno slittamento a destra verso il pacifismo borghese e l'azione parlamentare (quest'ultima considerata come fulcro della propaganda contro la guerra). Si dibatterono, inoltre, i rapporti tra i partiti socialisti e il movimento cooperativo, nonché la legislazione industriale e sociale, ivi comprese delle misure a favore dei disoccupati. La risoluzione su quest'ultimo punto formulò una piattaforma rivendicativa che comprendeva: giornata di 8 ore; proibizione del lavoro dei minori di 14 anni e abolizione del lavoro notturno, salvo casi speciali; riposo settimanale continuato di almeno 36 ore; abolizione del truck-system; diritto di coalizione; ispezioni nei luoghi di lavoro insieme ai rappresentanti dei lavoratori; un sistema generale di assicurazione obbligatoria, la cui amministrazione dovrebbe essere affidata alle organizzazioni operaie e la cui spesa doveva essere a carico del padronato; ecc. Si tenne anche la seconda Conferenza internazionale delle donne socialiste, composta da 100 delegate di 17 paesi, la quale elesse ancora Clara Zetkin quale sua segretaria. Vennero discussi gli aspetti organizzativi, politici (suffragio universale femminile) e sociali (lotte per il miglioramento della donna lavoratrice).
- Congresso straordinario a Basilea (24-25 novembre 1912). Era stato convocato per discutere come affrontare la lotta contro il pericolo incombente di una guerra mondiale, la cui minaccia si era ancor più aggravata dopo l'inizio della prima guerra balcanica. Presenti 555 delegati (di cui 6 russi del Posdr). Nella seduta del 25 fu approvato un manifesto contro la guerra, in quanto guerra fra capitalisti, nel quale si raccomandava ai socialisti di sfruttare la crisi economica e politica provocata dalla guerra per battersi per la rivoluzione socialista. Promotori di questa posizione erano figure di riferimento della II Internazionale come Jean Jaurès, Édouard Vaillant, Karl Kautsky e August Bebel. Questa scelta si tradusse in pratica in Italia nelle manifestazioni contro la guerra di Libia organizzate nel 1911 a Forlì dall'allora esponente del socialismo massimalista Benito Mussolini.
Tuttavia emersero posizioni divergenti, sebbene minoritarie. Da un lato si ponevano quanti solidarizzavano con le ragioni che i propri Paesi portavano avanti sul tavolo diplomatico e che furono poi all'origine dell'esplosione del conflitto nel 1914. Si trattava dei revisionisti tedeschi (Gustav Noske e Georg von Vollmar) e austriaci, i cui partiti erano ormai inseriti nel sistema parlamentare, ma anche dei socialisti rivoluzionari italiani come p.es. Arturo Labriola, che aveva caldeggiato la conquista della Libia. Dall'altro lato vi erano coloro che ritenevano che la guerra avrebbe accelerato la crisi del sistema capitalistico, avvalorando la teoria di Marx e spianando la strada alla rivoluzione. Questa posizione era forte soprattutto fra i delegati russi e polacchi, i quali avevano verificato come la guerra russo-giapponese avesse portato alla rivoluzione russa del 1905. Fra i principali fautori vi erano perciò Rosa Luxemburg e Lenin, i quali ritenevano che i socialisti dovessero utilizzare la crisi economica indotta dalla guerra per agitare gli strati popolari e far crollare il capitalismo.
- 1914, nell'agosto a Vienna si sarebbe dovuto tenere il IX Congresso (X se si include quello straordinario di Basilea), che però non si tenne per lo scoppio della guerra (28 luglio). I partiti socialisti scelsero a maggioranza d'attuare una politica di tregua parlamentare e sindacale chiamata Union sacrée in Francia e Burgfrieden in Germania. Il culmine di questa politica si ebbe il 4 agosto 1914 quando quasi tutti i deputati socialisti ai parlamenti tedesco, austriaco, francese e inglese votarono i rispettivi crediti di guerra, cioè l'emissione di titoli di debito pubblico per finanziare le spese militari. Questo atto di fedeltà di ciascun partito socialista alla propria nazione contraddiceva alla radice l'esistenza dell'Internazionale Socialista, che perciò cessò di fatto di esistere.
- 1915 (5-8 settembre). I Conferenza Internazionale Socialista a Zimmerwald (vicino Berna), su iniziativa di Angelica Balabanoff, del socialista svizzero Robert Grimm e del socialista italiano Oddino Morgari, Erano presenti vari partiti socialisti con delegazioni ufficiali: il partito socialista italiano (Costantino Lazzari e Giacinto Menotti Serrati), il partito operaio socialdemocratico russo, il partito socialista rivoluzionario russo, il partito socialista rumeno, il partito socialista di Bulgaria, delegazioni ufficiali dalla Svezia e dalla Norvegia, dall'Olanda (il piccolo ma coraggioso partito legato alla rivista “De Internationale”), poi delegazioni dalla Polonia e dai Paesi Baltici. Dalla Francia poche presenze poiché sia il partito socialista che la CGT appoggiavano il governo belligerante. Dalla Germania due deputati socialisti rappresentanti la debole opposizione alla socialdemocrazia tedesca. Non poterono partecipare delegati dell'Indipendent Labourt Party e del British Socialist Party, poiché non avevano potuto ottenere i passaporti. Clara Zetkin e Rosa Luxemburg erano in carcere, e anche Karl Liebknecht, che nel dicembre del 1915 fu l'unico deputato al Reichstag a votare contro i nuovi crediti di guerra chiesti dal governo.
Secondo Liebknecht gli obiettivi di quella Conferenza dovevano essere tre: 1) denucia del fallimento definitivo della II Internazionale, 2) necessità di fondare al più presto la III Internazionale, 3) la nuova Internazionale avrebbe dovuto lavorare per la rivoluzione comunista mondiale.
L'appello di Liebknecht fu sottoscritto subito da Lenin, Trockij, Zinoviev e pochi altri. La maggioranza kautskiana (francesi, tedeschi, italiani...), capeggiata dal tedesco G. Ledebour, ebbe la meglio: la parola d'ordine di Lenin, "trasformare la guerra imperialista in guerra civile", non fu approvata (voti favorevoli 8, contrari 20). Prevalse, invece, la mozione di orientamento pacifista dei centristi: "né aderire né sabotare". Alla fine fu approvato un “Manifesto” elaborato da Trockij e firmato da tutti i congressisti. Lenin lo firmò senza essere convinto della sua efficacia operativa, anche perché la Commissione eletta a Zimmerwald non si poneva come compito la creazione di una nuova Internazionale.
- 1916 (24-30 aprile). II Conferenza Internazionale Socialista, a Kienthal. Presenti 7 delegati tedeschi, 7 italiani, 8 russi (tra cui Lenin e Inessa Armand), 5 polacchi, 4 francesi, 5 svizzeri (in tutto 43, di cui 12 appartenenti alla sinistra rivoluzionaria). Su proposta di Lenin, la Conferenza approvò una risoluzione di critica del socialpacifismo del BSI.
- 1917 (luglio-agosto 1917). III Conferenza Internazionale Socialista, a Stoccolma. Proposta dal comitato olandese-scandinavo, ma ben presto l'iniziativa passò nelle mani del Soviet di Pietrogrado, dove i bolscevichi, che si opponevano a una riunione di partiti favorevoli alla guerra, si trovavano ancora in minoranza. La conferenza avrebbe dovuto riunire tutte le componenti del socialismo e mirava alla ricostruzione dell'Internazionale ma non venne mai convocata, poiché molti partiti erano impegnati nella guerra ed esistevano già grandi divisioni tra le varie correnti della sinistra, che non sembravano risolvibili in quel periodo. Si decise pertanto di riproporre la conferenza alla fine del conflitto per inserire nelle condizioni di pace anche le richieste dei lavoratori.
In ogni caso la corrente zimmerwaldiana, avendo assunto fin da principio nella sua maggioranza una posizione esitante, centrista, era praticamente crollata, sul piano sia ideologico che politico. I possenti scioperi contro la guerra imperialista nei principali paesi capitalistici, le due rivoluzioni del febbraio e dell'ottobre 1917 in Russia, la rivoluzione tedesca del 1918, l'assassinio in Germania di Karl Liebknecht e di Rosa Luxemburg mentre era al potere un governo di socialpatrioti, che rivelava fino in fondo la sostanza classista della repubblica borghese, anche la più democratica, furono gli avvenimenti di portata storica attraverso i quali si giungerà infine, nel marzo 1919, al Congresso di fondazione della III Internazionale.
Al termine del conflitto si ripropose il problema della Conferenza; fu scelta Berna come luogo dove tenere la riunione, poiché si trovava in un paese neutrale. Gli inviti furono mandati a tutti i partiti di ispirazione socialista che non avessero tendenze estremiste, furono quindi esclusi i bolscevichi e tutte le formazioni comuniste. La Conferenza pertanto assumeva l'aspetto di una riunione di socialisti moderati, non comprendente tutte le correnti della sinistra che dovevano formare la nuova Internazionale. Dodici paesi inviarono le proprie delegazioni complete, mentre altri, tra cui l'Italia e la Russia, mandarono solo alcuni esponenti. Per prima cosa la Conferenza dovette stabilire a chi spettava la colpa di aver scatenato la guerra. Fu incolpato il vecchio regime tedesco e fu invece riconosciuto innocente il partito socialista tedesco, che non aveva avuto un ruolo attivo nel conflitto e pertanto poté partecipare alla riunione in piena eguaglianza con le altre formazioni.
La Conferenza di Berna si occupò poi del problema della democrazia e della dittatura. Una commissione elaborò due teorie: la prima, quella di Branting, sosteneva l'inseparabilità tra socialismo e democrazia, condannava in modo esplicito le dittature del proletariato e i bolscevichi e dichiarava ch'era necessaria la libertà di stampa; promuoveva, inoltre, la creazione di una commissione che andasse a verificare l’operato del governo in Russia.
La seconda risoluzione, quella di Adler-Longuet, invece, non si associava alla condanna dei bolscevichi, sostenendo che non esistevano elementi di valutazione dell'azione dei russi; proponeva poi un maggior dialogo con i partiti comunisti, che non erano rappresentati alla Conferenza, sostenendo ch'era necessaria l'unione della sinistra contro il sopravanzare del capitalismo.
La maggioranza dei delegati votò la prima delle risoluzioni, e ciò segnerà una rottura incolmabile tra socialisti e comunisti.
La Conferenza formulò poi le richieste da proporre durante le trattative di pace: istituire una Società delle Nazioni con grande potere e creare uno Statuto internazionale per i lavoratori. Fu stabilito, infine, che non era ancora il momento per fare una nuova Internazionale, poiché si dovevano ancora discutere i trattati di pace. La Conferenza si sarebbe rivista a Ginevra: cosa che avvenne nel luglio 1920. La sede definitiva fu stabilita a Londra, sotto l'egemonia dei laburisti inglesi.
Intanto nel luglio 1920 si tenne a Pietrogrado una nuova riunione dell'Internazionale Comunista. La partecipazione fu massiccia: centinaia di delegati che rappresentavano 37 paesi di tutto il mondo, dall'Africa all'Asia, anche se per lo più erano europei. Il partito comunista russo aveva quasi sconfitto le forze controrivoluzionarie e perciò si trovava in una buona situazione e cercava di espandere la rete dei partiti comunisti. Il Congresso della III Internazionale formulò i 21 punti, la cui totale accettazione era condizione necessaria per essere ammessi alla nuova organizzazione. All'interno dei punti vi era una forte critica al socialismo moderato e a tutti i partiti che non si schieravano apertamente con l'Internazionale Comunista. Si indicava la necessità di compiere azioni legali e illegali per dare il potere al proletariato e di allontanare dalla dirigenza dei partiti tutti i socialisti riformisti, accusati di tradire la causa dei lavoratori.
Nel febbraio 1921 i partiti che non avevano aderito a nessuna delle due Internazionali diedero vita alla cosiddetta “Unione di Vienna” o “Internazionale due e mezzo”, come la chiamavano spregiativamente i comunisti, a causa della sua posizione a metà strada tra quella socialista di Londra e il Komintern di Mosca. Protagonisti ne furono Friedrich Adler, Karl Kautsky, Otto Bauer, Jean Longuet, Robert Grimm e altri esponenti socialisti dell'area centrista. Questa unione aveva lo scopo di preparare la via a una nuova organizzazione sufficientemente ampia da comprendere tutte le componenti della sinistra, capace di ristabilire l'unità del proletariato sulla base della discriminante anticapitalista. Vi aderirono partiti di molte nazioni europee, molti dei quali erano ancora soggetti a lotte interne tra fazioni per la direzione da prendere; è il caso del Partito Socialista Francese, che si era trasformato nel 1920 in Partito Comunista e si era unito al Komintern: ciò aveva provocato la reazione dei minoritari, che se ne erano andati e avevano ricostruito la vecchia Comune socialista che ora aderiva all'Unione di Vienna.
La Conferenza di Vienna, che condannava la dittatura del proletariato, ripudiava la violenza e promuoveva la repubblica parlamentare come forma di governo, nonché lo sviluppo di cooperative di lavoratori, sosteneva che la proprietà privata poteva essere abolita solo riconoscendo un indennizzo ai proprietari. Inoltre si poneva solo come federazione dei vari partiti socialisti, rifiutandosi di dare indicazioni generali vincolanti. Tuttavia l'abisso tra comunisti rivoluzionari e socialisti riformisti era troppo profondo per essere colmato, per cui il tentativo dell'Unione di ricomporre le due Internazionali fallì.
La riunificazione delle varie tendenze socialiste (esclusi i comunisti) si ebbe nel congresso di Amburgo (1923). Furono eletti due segretari generali: l'inglese Tom Shaw e l'austriaco F. Adler. Questa Internazionale operaia socialista, con le sue diverse correnti socialiste, si proponeva come alternativa democratica al comunismo e al fascismo. La sede del segretariato si trasferì da Londra a Zurigo (1926-35) e quindi a Bruxelles. Solo una minoranza dei membri sosteneva l'idea del fronte popolare contro il nazifascismo. In difesa della pace l'Internazionale operaia socialista s'impegnò per un sistema di sicurezza collettiva, per il disarmo e in favore del tribunale arbitrale. Lo scoppio della guerra (1940) segnò la sua fine.
Dopo la seconda guerra mondiale i socialisti si limitarono dapprima a istituire un Comitato per la conferenza socialista internazionale (Cernisco), poi, nel 1951, venne costituita a Francoforte sul Meno l'Internazionale socialista, chiaramente ispirata alla cultura del riformismo socialdemocratico della II Internazionale, il cui primo presidente fu Willy Brandt.
Congressi dell'Internazionale Comunista
I: Mosca, 2–6 marzo 1919
II: Pietrogrado, 19 luglio e Mosca, 23 luglio–7 agosto 1920
III: Mosca, 22 giugno–12 luglio 1921
IV: Mosca, 5 novembre–5 dicembre 1922
V: Mosca, 17 giugno–8 luglio 1924
VI: Mosca, 17 luglio–10 settembre 1928
VII: Mosca, 25 luglio–20 agosto 1935
1La ricorrenza periodica del 1° maggio fu dettata dal fatto che in quella data, nel 1886, 400.000 operai avevano scioperato in tutti gli Stati Uniti, e 80.000 nella sola Chicago, che diventò il centro della protesta. Qui lo sciopero e le manifestazioni si protrassero fino al 4 maggio, quando scontri tra polizia e manifestanti causarono morti da entrambe le parti. Tra gli organizzatori della manifestazione del 4 maggio vi erano anche molti anarchici, alcuni dei quali furono addirittura condannati a morte.
2I “socialisti indipendenti” di Jean Jaurès, insieme ad altre componenti socialiste, fondarono il partito socialista francese nel 1902, il quale rappresentava le correnti moderate del socialismo francese, disposte a collaborare con i partiti borghesi.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube