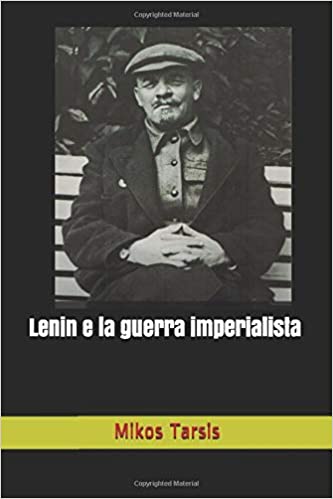
LENIN E LA GUERRA IMPERIALISTICA
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
L'ottimismo della volontà
Quando si legge l'articolo Esiste una via verso una pace giusta?, si resta un po' perplessi. Nel giugno del 1917 Lenin era convinto che “soltanto in Russia è possibile il passaggio del potere a organismi già pronti, i soviet, per via pacifica, senza insurrezione, poiché i capitalisti non possono opporre resistenza ai soviet dei deputati degli operai, dei soldati e dei contadini” (p. 305).
Strano che dica questo, perché ha pure sempre detto che i capitalisti e i grandi proprietari fondiari avrebbero opposto una durissima resistenza alla loro espropriazione. E a ben guardare, in effetti, avverranno entrambe le cose: la conquista del potere sarà relativamente facile, quasi senza spargimento di sangue; la conservazione del potere sarà invece incredibilmente complessa.
Un'altra cosa strana è che egli punti tutte le sue carte sulla rete dei soviet in cui i bolscevichi non avevano ancora, in quel momento, la maggioranza. Com'era possibile fare la rivoluzione senza avere un sicuro appoggio da parte di questi organi di democrazia diretta? Qui non si era in presenza di una classica democrazia parlamentare. Non a caso i bolscevichi parlavano di “dualismo del potere”: il potere ufficiale delle istituzioni, sempre più impotente, e il potere reale dei soviet, che però non aveva nulla di istituzionale.
Ma la cosa più strana, in quell'articolo, è un'altra ancora. Ad un certo punto scrive: “Solo dopo il passaggio del potere alle classi oppresse, la Russia potrebbe rivolgersi alle classi oppresse degli altri paesi...” (p. 305). In che modo avrebbe potuto o dovuto far questo? Esportando la rivoluzione? No, ma “indicando il proprio esempio e proponendo le chiare condizioni di una pace generale”. E se queste condizioni non venissero accettate dagli altri paesi? In tal caso la Russia dovrebbe forse dichiarare loro una guerra per venir incontro alle esigenze delle classi oppresse?
Se a una domanda del genere Lenin avesse risposto affermativamente, avrebbe offerto un buon motivo per considerare il suo paese una minaccia di occupazione dell'intera Europa occidentale. Non avrebbe fatto altro che favorire lo sfruttamento del proletariato in quest'area del continente. Dunque, cosa intendeva dire, esattamente, con l'espressione “guerra rivoluzionaria”? Qualcosa di “interno” alla Russia o anche qualcosa di “esterno”? Se si trattava di politica esterna, intendeva forse dire che il proletariato russo doveva tenersi pronto ad affrontare l'attacco delle potenze capitalistiche o intendeva dire che, subito dopo aver compiuto la rivoluzione, ci si doveva preparare per favorire le rivoluzioni negli altri paesi, congiungendo le forze proletarie? A giugno, infatti, Lenin era ancora convinto che le condizioni per una transizione socialista non fossero presenti solo in Russia, ma, per es., anche in Germania.
Ad un certo punto sembra voler far capire che nell'ambito di una pace giusta, qualunque annessione potrà essere messa in discussione dalla Russia sovietica. Le condizioni della pace verranno trattate coi popoli non coi governi e tanto meno coi capitalisti (come se i popoli – verrebbe da aggiungere – avessero qualcosa di più, nell'ambito del capitalismo, del semplice strumento referendario per far sentire la loro voce!). Il “bandito coronato Guglielmo” deve sapere che il prossimo governo proletario russo considererà illegali tutte le conquiste coloniali di tutti i paesi capitalisti, quindi anche quelle prussiane in Alsazia-Lorena, in Danimarca, in Polonia...
Dunque, che cosa aveva in mente di fare? Espressamente dice una cosa ben chiara: “le rivoluzioni non si fanno su ordinazione” (p. 306). Però era anche convinto che “l'esempio degli operai russi sarà inevitabilmente seguito dagli operai e dai lavoratori di almeno due grandi paesi: la Germania e la Francia, poiché entrambi vanno in rovina, il primo per fame, il secondo per spopolamento” (ib.).
Lenin era convinto che se due grandi paesi come questi avessero fatto la rivoluzione proletaria, il capitalismo sarebbe stato sconfitto in tutta Europa e quindi in tutto il mondo. Infatti, conclude dicendo che “se i capitalisti dell'Inghilterra, del Giappone, dell'America [li stava elencando in ordine d'importanza] cercheranno di opporsi a questa pace [senza annessioni], le classi oppresse della Russia e degli altri paesi non si lasceranno spaventare dalla prospettiva della guerra rivoluzionaria contro i capitalisti..., sconfiggeranno i capitalisti di tutto il mondo” (p. 306).
Questa la sua visione ottimistica delle cose. Peccato che né la Germania né la Francia avessero dei leader rivoluzionari al suo livello. Dunque come poteva pensare una cosa del genere quando i principali leader socialisti europei erano stati capaci di mostrare soltanto il loro riformismo prima della guerra, il loro tradimento al momento di farla scoppiare e il loro incallito sciovinismo mentre essa era in corso?
Chi era più ingenuo? Come poteva pensare che per i leader socialisti riformisti sarebbe bastato vedere i propri paesi andare in rovina a causa della guerra per sentirsi in dovere di mutare atteggiamento? Oppure diceva queste cose per indurre a credere che le rivoluzioni proletarie erano possibili anche negli Stati capitalistici più avanzati e che il caso della Russia non andava considerato una semplice eccezione? Lenin però qui non cita neanche un nome di leader socialista che avrebbe potuto seguire il suo esempio. Si appella alle masse proletarie, che però erano prive di “guide rivoluzionarie”.
*
Il mese di giugno è oltremodo importante, proprio perché il governo provvisorio, su richiesta degli imperialisti russi inglesi e francesi (Lenin, a p. 307, aggiunge anche quelli dell'Italia, del Giappone e dell'America), scatena quella che doveva essere l'ultima, decisiva, offensiva militare. Lenin arriva a dire, giustamente, che “il governo russo, nella persona dei suoi ministri 'socialisti', ha fatto ciò che non erano riusciti a fare i ministri imperialisti Guckov e Miljukov: ha messo l'esercito russo a disposizione degli stati maggiori e dei diplomatici che agiscono in nome e in base a trattati segreti non revocati...” (p. 308). E l'esercito russo ha creduto ingenuamente alle promesse di pace di Kerenskij, ha seguito le direttive piccolo-borghesi dei partiti socialista-rivoluzionario e menscevico.
Si era deciso di riprendere su tutti i fronti la guerra imperialistica dopo tre mesi di esitazioni. L'ultima offensiva era stata però la più catastrofica di tutte: solo sul fronte sud-occidentale le truppe russe avevano perso in dieci giorni circa 60.000 uomini. Lenin mostra di meravigliarsi alquanto che la ripresa della guerra sia stata voluta proprio dai partiti che meno avrebbero dovuto desiderarla. Il partito socialista-rivoluzionario e quello menscevico avevano la maggioranza nel Congresso dei soviet e in quello contadino. Niente e nessuno avrebbe potuto obbligarli ad appoggiare la volontà di Kerenskij. Il fallimento militare dell'offensiva li aveva screditati completamente: diventavano ancora di più “socialisti” a parole e “imperialisti” nei fatti. Lenin è durissimo contro di loro: hanno concesso al governo provvisorio il potere di confermare dall'alto le autorità locali elette direttamente dalla popolazione; hanno rinunciato all'idea di confiscare la terra ai grandi proprietari fondiari; condividono le idee antidemocratiche dei cadetti nei confronti dell'Ucraina e della Finlandia, alle quali non si vuole riconoscere alcuna autonomia. Insomma, hanno posto le condizioni per la loro rovina politica. Lenin era sempre più convinto che la rivoluzione avrebbe potuto essere fatta solo dal “proletariato urbano organizzato”, guidato dai bolscevichi.
Tuttavia a settembre Lenin è disposto, eccezionalmente, a scendere a compromessi con tali partiti, relativamente alla possibilità che tutto il potere venga dato ai soviet (anche a quelli periferici). La gestione del potere poteva anche essere affidata ai due suddetti partiti, a condizione però che non venisse spartito coi cadetti e che essi si dichiarassero “responsabili” di fronte ai soviet e non di fronte al parlamento nazionale (la Duma). Ritiene che una tale condizione potrebbe permettere il formarsi di un governo rivoluzionario “per via del tutto pacifica”. Uno sviluppo “pacifico” della rivoluzione viene considerato una “possibilità estremamente ed eccezionalmente rara nella storia ed estremamente preziosa”. I bolscevichi ovviamente non parteciperebbero al governo, né farebbero nulla per rovesciarlo, ma attenderebbero soltanto la convocazione dell'Assemblea Costituente. La proposta però fu rifiutata e i due suddetti partiti continuarono a collaborare con la borghesia.
Lenin non demorde, e sempre a settembre chiede ai menscevichi e ai socialisti-rivoluzionari che sono al governo di proporre a tutti i popoli belligeranti almeno un immediato armistizio della durata di tre mesi, al fine d'intavolare trattative su una pace democratica, in cui non solo si rinunci a ogni annessione, ma si riconosca anche a ogni nazionalità, a ogni colonia di decidere in autonomia “se erigersi in Stato indipendente o far parte di un altro Stato qualsiasi” (p. 313). Il governo dei soviet dovrà inoltre rendere pubblici i trattati segreti firmati dallo zar e dai suoi alleati, e riconoscere a ucraini e finlandesi la completa libertà “fino al diritto di separazione”, e dovrà ritirare le truppe russe stanziate in Armenia e in alcuni territori turchi.
Di fronte al rifiuto di anche questa proposta, Lenin pensò che non restava altro da fare che rovesciare il governo: cosa che avverrà il 24-25 ottobre, secondo il vecchio calendario giuliano.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube