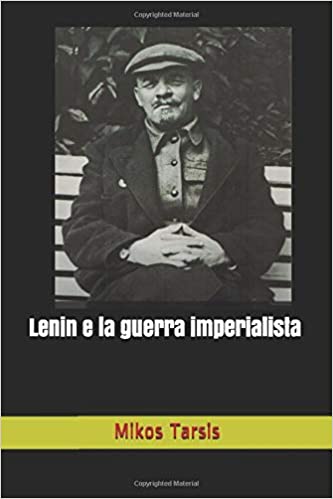
LENIN E LA GUERRA IMPERIALISTICA
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
La guerra e il socialismo traditore
Nel Discorso sulla guerra al I Congresso dei soviet dei deputati operai e soldati di tutta la Russia 9 (22) giugno 1917, Lenin è costretto ad ammettere che la posizione dei menscevichi e dei populisti (o socialisti rivoluzionari) “è profondamente radicata in quasi tutti gli operai e contadini” (p. 284).
Tuttavia si sforza di far capire che le posizioni dei socialisti (industriali e agrari, urbani e rurali) che collaborano col governo provvisorio sono piuttosto confuse e incoerenti. Da un lato appoggiano la guerra, dall'altro dicono di non essere interessati alle aspirazioni di conquista dei governi capitalisti. Neppure hanno detto qualcosa sul fatto che il governo provvisorio rivolga “brutali minacce alle istituzioni elettive locali”, tentando di “designare dall'alto o ratificare i funzionari eletti dalla popolazione locale” (p. 283). In pratica la borghesia, una volta impadronitasi del potere, era già diventata “controrivoluzionaria”. La subordinazione degli organi locali di autogoverno al potere centrale non ne era forse il sintomo più eloquente? E che dire del fatto che il governo voleva conservare la grande proprietà fondiaria e impedire la pubblicazione dei trattati segreti militari conclusi dallo zar?
Dichiarazioni del genere erano straordinarie a pochi mesi prima dello scoppio della più grande rivoluzione della storia. Fino all'ultimo momento Lenin era rimasto convinto che la situazione si sarebbe potuta rovesciare. Non conosceva la parola “rassegnazione”. La “confusione” dei socialisti riformisti russi dipendeva, per lui, dal fatto che non si conoscevano abbastanza i meccanismi economici dell'imperialismo delle maggiori potenze capitalistiche mondiali (Inghilterra, Francia, Germania e Stati Uniti): meccanismi o dinamiche assolutamente indipendenti dalla volontà di questo o quel governo politico. Lenin stava parlando delle “grandi banche” e dei “grandi capitalisti” (“non più di una mezza dozzina in ciascuno di questi paesi”), che si erano ripartiti in senso territoriale-coloniale l'intero pianeta.
I socialisti riformisti non avevano contezza delle dinamiche dell'imperialismo e quindi delle vere cause della guerra mondiale, cioè del fatto che quando entrano in scena nuovi competitori del capitale, che vogliono imporsi a livello mondiale, le guerre sono inevitabili.1 Ecco perché Lenin affermava che “la lotta contro la guerra imperialistica è possibile soltanto come lotta delle classi rivoluzionarie contro le classi dominanti su scala mondiale” (p. 287). E per “classi dominanti” egli non intendeva tanto i proprietari fondiari, quanto piuttosto “i più grandi magnati della finanza e della banca” (ib.). Lenin aveva una concezione dell'imperialismo prevalentemente finanziaria. Aveva capito che i grandi monopoli industriali non avrebbero potuto muoversi agevolmente a livello mondiale senza il decisivo appoggio delle banche. La Germania beneficiava anche dell'intervento diretto dello Stato nell'economia produttiva.
Che cosa mancava al proletariato internazionale? La consapevolezza di una resistenza collettiva, concertata tra i lavoratori delle singole nazioni. La guerra sembrava avere lo scopo d'impedire tale resistenza di classe a livello mondiale. È costretto a dire, con grande rammarico, che “gli operai e i contadini dell'Europa occidentale non sanno che in Russia la massa operaia è veramente insorta e che condanna sinceramente le aspirazioni di conquista dei capitalisti di tutti i paesi...” (ib.).
La guerra fa vedere le cose in bianco e nero, in alleati e nemici, senza fare distinzioni tra le classi. In pratica Lenin stava chiedendo che si formasse un'organizzazione diversa dalla II Internazionale, prima ancora d'aver fatto la rivoluzione comunista. Quello che più lo sconcertava era che gli operai e i contadini russi, in possesso di organizzazioni democratiche senza precedenti storici (come i soviet), e già debitamente armati, permettessero ai socialisti riformisti di partecipare attivamente al governo borghese (che di democratico non aveva nulla), invece di abbatterlo.
Lenin non si accontentava di “una pace senza annessioni né indennizzi”. Voleva la fine della collaborazione di classe tra movimento operaio e capitalisti russi. Non voleva tornare allo status quo ante-guerra, anche perché ciò avrebbe favorito le grandi potenze capitalistiche mondiali. Voleva che queste potenze cominciassero ad aver paura di una rivoluzione autenticamente proletaria: cosa che in Russia si poteva fare, e forse anche in Germania, se il governo fosse uscito sconfitto dalla guerra.
Voleva far capire che “la vittoria dell'imperialismo è il principio dell'inevitabile, irrevocabile scissione dei socialisti di tutti i paesi in due campi” (p. 291). Infatti i socialisti favorevoli alla difesa della patria o quelli che partecipano nei ministeri dei governi borghesi, stanno oggettivamente dalla parte dell'imperialismo, cioè dalla parte dello sfruttamento delle colonie, e fanno questo proprio mentre dicono di voler tutelare gli interessi degli operai nelle loro rispettive nazioni.
Lenin stava chiedendo agli operai e ai contadini dei soviet se volevano essere rappresentati dai traditori del socialismo più democratico o se volevano rovesciare il governo provvisorio, obbligando i socialisti riformisti a mutare atteggiamento. In tutto il mondo capitalistico la guerra aveva messo in evidenza una profonda spaccatura tra i socialisti: da un lato, in grande maggioranza, gli opportunisti, i revisionisti, i socialsciovinisti; dall'altro i rivoluzionari, nettamente minoritari, ma intenzionati a non cedere, a non tacere. Lenin li stava invitando a insorgere. In nome della coerenza rivoluzionaria era assurdo in Russia che i socialisti chiedessero al proletariato delle altre nazioni di non appoggiare la propria borghesia o di opporsi alle annessioni, quando in politica interna si appoggiavano di fatto i propri capitalisti. Non sono le intenzioni o le dichiarazioni solenni che decidono i rapporti di classe. Lenin li stava accusando d'essere “ingenui” e “incoerenti”. “Invitate gli altri popoli a rovesciare i banchieri, ma appoggiate i vostri!” (p. 292).
Naturalmente egli negava la possibilità di uscire da soli dalla guerra, sia perché il governo provvisorio non l'avrebbe mai fatto, sia perché i nemici se ne sarebbero subito approfittati. Per lui l'unica possibilità di uscire dalla guerra era quella di rovesciare il governo di Kerenskij, dimostrando al mondo intero che il socialismo era una vera alternativa al capitalismo e all'imperialismo. Un popolo che insorge è in grado di difendere la patria meglio di un popolo costretto a farlo da un governo borghese. Dopodiché si potevano fare proposte di pace a tutti i paesi belligeranti o anche solo a quelli con cui la Russia era in guerra.
Astrattamente a Lenin non interessava l'idea di rompere l'intesa con Francia e Inghilterra per poter fare una pace coi tedeschi. Questa sarebbe stata una soluzione in extremis, come poi in effetti avverrà in occasione della pace bilaterale di Brest-Litovsk. L'avrebbe considerata insufficiente se il governo provvisorio fosse rimasto in carica, quanto meno perché tale governo non aveva intenzione di riconoscere alle varie nazionalità russe alcuna vera autonomia. La pace avrebbe dovuto sottostare a condizioni ben più impegnative nei confronti delle colonie e delle nazionalità oppresse. E in ogni caso per il suddetto governo, dopo quasi tre anni di guerra, che aveva già comportato per i russi milioni di morti, sarebbe stato impossibile rinunciare agli obiettivi riportati nei trattati segreti, a meno che appunto non ci fosse stata una svolta radicale di tipo anticapitalistico. Per uscire da questo stallo l'unica soluzione era quella d'insorgere contro il governo provvisorio. E se proprio si fosse stati costretti a continuare la guerra, lo si sarebbe fatto per un obiettivo davvero democratico, non imperialistico. In fondo la storia ha sempre insegnato che “nessuna classe rivoluzionaria può sottrarsi alla guerra rivoluzionaria senza condannarsi a un pacifismo ridicolo. Non siamo tolstoiani” (p. 295). Il che voleva dire che, fatta la rivoluzione, il proletariato deve aspettare d'essere attaccato da tutti gli altri paesi capitalistici, che vorranno privarlo dei suoi territori, delle sue risorse, delle sue conquiste politiche.
Ma potrebbe anche voler dire che attorno alla Russia “crescono alleati formidabili”, intenzionati a imitare l'esempio del proletariato russo. E qui ricorda cos'era successo con la rivoluzione del 1905. “All'inizio essa era terribilmente debole... Ma dopo il 17 ottobre 1905 a Vienna e a Praga cominciarono grandi dimostrazioni nelle vie e si eressero barricate. Dopo il 1905 arrivò il 1908 in Turchia, il 1909 in Persia, il 1910 in Cina” (p. 296). In effetti in Turchia ci fu la rivoluzione borghese di Atatürk; in Persia fu deposto lo shah; in Cina Sun Yat-Sen combatté i feudatari interni e gli imperialisti stranieri, creando la repubblica borghese. Solo in Russia nel 1907 vi fu una terribile reazione dell'autocrazia zarista.
1Oggi le guerre potrebbero scoppiare anche per altri motivi: 1) le risorse energetiche non rinnovabili tendono a esaurirsi; 2) dopo mezzo millennio di colonialismo, il Terzo Mondo vuole riscattarsi, in senso capitalistico o socialistico; 3) i governi sono sempre più accusati di non fare abbastanza per tutelare l'ambiente (come se l'ecologia potesse essere compatibile con l'economia capitalistica!).
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube