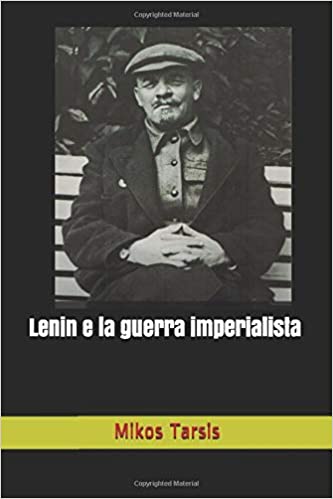
LENIN E LA GUERRA IMPERIALISTICA
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
Caratteristiche della guerra imperialistica
Quando scrive I compiti della socialdemocrazia rivoluzionaria nella guerra europea (settembre 1914) la guerra era già scoppiata. In una conferenza clandestina, a causa di “persecuzioni senza precedenti da parte del governo zarista”, Lenin fa il punto sul significato della guerra mondiale, cui aggiungeremo altre considerazioni.
La guerra serve per affermarsi sui mercati mondiali, per sottomettere quanti più paesi stranieri, trasformandoli in colonie; serve anche per stroncare i tentativi rivoluzionari del proletariato industriale, aizzando gli operai di una nazione contro quelli di un'altra, in nome della difesa della patria.
I più importanti leader del partito socialdemocratico tedesco o, altrimenti detto, “centro kautskyano” (il più significativo nella II Internazionale), han tradito la causa del socialismo, come la maggior parte dei partiti socialisti europei: per difendere la loro patria, han rinunciato alla lotta di classe, han votato a favore dei crediti di guerra, han condotto una politica nazional-liberale, partecipando p. es. ai ministeri borghesi o approvando la politica coloniale.1
La rottura col centrismo kautskyano avvenne solo in occasione della guerra, in quanto, a parere di Lenin, il kautskysmo rappresentava “il riconoscimento soltanto verbale del marxismo”, quello che lo condusse a trasformarsi in “struvismo” e in “brentanismo”.2 Kautsky ammetteva la rivoluzione come obiettivo finale o strategico, ma la negava sul piano tattico, svolgendo un'attività meramente parlamentare. In questo assomigliava a Plechanov. “Del marxismo si ammetteva tutto, tranne i mezzi rivoluzionari di lotta, la loro propaganda e preparazione, l'educazione delle masse in questa direzione” (p. 149). Gli rimproverava soprattutto di aver firmato il manifesto di Basilea (che chiedeva la trasformazione della guerra imperialistica in guerra civile), senza averne tratto alcuna conseguenza, e di aver giustificato il socialsciovinismo.
Lenin chiede di rompere con la politica della “pace civile” (“bloc national”, “burgfrieden”); considera una grande iattura il socialismo riformista, poiché indebolisce la resistenza dei socialisti russi, repressi dallo zarismo grazie anche ai capitali di Francia e Inghilterra.
Sulla questione del “tradimento” Lenin era piuttosto esplicito: “I partiti socialisti non sono circoli di discussioni, ma organizzazioni del proletariato militante, e quando alcuni battaglioni passano dalla parte del nemico, bisogna chiamarli traditori...” (p. 114). In questa stessa pagina cita i nomi di Kautsky e Cunow, che in quel momento erano da lui bollati come “sciovinisti”. “Il capitalismo non sarà mai studiato a fondo in tutte le manifestazioni della sua pirateria e nemmeno in tutte le più minute ramificazioni del suo sviluppo storico e nelle sue particolarità nazionali”. Era questo un modo (indiretto) di dire che chi si limita a proseguire le ricerche economiche sulla base del metodo del Capitale non arriverà mai a compiere la rivoluzione comunista. Lenin diceva che la politica andava considerata un “concentrato” dell'economia. E, nonostante questo, scrisse un importantissimo volume sull'Imperialismo, colmando le lacune del Capitale, o comunque aggiornandolo rispetto alle problematiche del capitalismo finanziario.
Le sue parole avevano lo scopo di evitare il nozionismo astratto di chi vuol fare l'economista socialista. Infatti, poi aggiunge: “Sui particolari gli scienziati (e specialmente i pedanti) non smetteranno mai di discutere. 'Su questa base' sarebbe ridicolo rifiutarsi di prendere parte alla lotta socialista contro il capitalismo, rifiutarsi di contrapporsi a coloro che hanno tradito questa lotta” (p. 114).
Detto altrimenti: non ha alcun senso, in nome di studi teorici sul capitalismo o in nome dell'idea che l'analisi del capitalismo non ha ancora raggiunto un livello alto di scientificità, evitare di svolgere una politica rivoluzionaria. Non solo perché questi atteggiamenti nozionistici sono astratti, intellettualistici, incapaci di vivere il presente, ma anche perché il capitalismo mondiale è una realtà così complessa che è impossibile decifrarlo in maniera esaustiva. La politica rivoluzionaria prescinde da un'analisi particolareggiata delle contraddizioni del sistema da abbattere. È sufficiente prendere atto che le sue antinomie di fondo solo assolutamente evidenti e inconciliabili, proprio per gli interessi opposti che le caratterizzano.
Il fatto che alcuni leader socialisti del Belgio e della Francia abbiano accettato di dirigere alcuni ministeri nei governi borghesi, non significa che la guerra sia scoppiata per colpa dei socialisti, anche se non si può negare che il socialismo opportunistico vi ha contribuito non poco. Non dimentichiamo che solo i socialisti russi e serbi si erano opposti decisamente ai crediti di guerra richiesti dal loro governo. Quelli italiani se n'erano usciti con una formula ambigua: “Né aderire (prima che la guerra scoppi) né sabotare (dopo che sia scoppiata)”, pur sapendo che l'Italia aveva mire espansionistiche sulla riva opposta dell'Adriatico.
Secondo Lenin “la lotta tra il socialismo rivoluzionario e il socialismo opportunista riempie tutto il periodo che va dal 1889 [nascita della II Internazionale] al 1914” (p. 186) e ha portato al fallimento dell'Internazionale. La politica piccolo-borghese ha comportato la sostituzione della rivoluzione socialista col riformismo borghese; la lotta di classe è diventata una collaborazione tra le classi; ci si rifiuta di trasformare la guerra imperialistica in guerra civile; l'accettazione dello sciovinismo borghese avviene sotto l'aspetto del patriottismo o della difesa della patria; il militarismo viene contestato soltanto da un punto vista etico o sentimentale in senso cristiano-piccolo-borghese; non si capisce che quando la borghesia impone lo stato d'assedio, abolendo le libertà costituzionali, è indispensabile creare delle organizzazioni o strutture illegali; non si può trasformare il parlamentarismo borghese in un feticcio, quando in realtà esso è, dal punto di vista degli interessi del socialismo, niente di più che un semplice strumento di propaganda; è assolutamente necessaria una guerra rivoluzionaria di tutti i proletari del mondo contro la borghesia imperialistica di tutto il mondo. Insomma con lo scoppio della I guerra mondiale, mentre il socialismo europeo era ufficialmente diventato una variante etico-sociale dell'ideologia cristiano-liberal-borghese dominante, il bolscevismo era invece diventato (molto probabilmente perché la Russia era il paese capitalistico più arretrato d'Europa) l'unica vera alternativa al socialismo riformistico e nazionalistico dell'Europa occidentale.
In questo punto e in quello successivo Lenin denuncia le ipocrisie di quegli Stati europei che hanno scatenato la guerra. Infatti la borghesia tedesca ha dichiarato di voler la guerra contro la Russia per abbattere lo zarismo, quando in realtà i grandi proprietari terrieri (junker) e la monarchia che li tutela han sempre condotto una politica in difesa dello zarismo. Ora non vogliono fare altro che impadronirsi di alcuni territori dell'impero russo, per non parlare del fatto che opprimono i danesi e i polacchi, i francesi in Alsazia-Lorena, vogliono conquistare il Belgio e sottomettere la Francia.
La stessa Francia ha mire espansionistiche in Germania e in Austria. La borghesia austriaca vuole impadronirsi della Serbia. La Russia opprime la Polonia, l'Ucraina e altri popoli asiatici.
La valutazione che Lenin fa delle forze belligeranti in campo era piuttosto chiara: “se la Germania è meglio preparata ed è ora la più forte [lo dice nell'agosto 1915], la Quadruplice Intesa (Russia, Inghilterra, Francia e Italia) possiede più uomini e più denaro, e inoltre riceve liberamente materiale bellico dal paese più ricco del mondo, gli Stati Uniti d'America” (p. 156). Secondo lui il sorpasso economico dei tedeschi sugli inglesi era avvenuto negli ultimi 50 anni, quando il grande capitalismo tedesco si era “congiunto con la burocrazia” (p. 351), e benché gli inglesi avessero un impero coloniale di 400 milioni di abitanti.
Lenin insomma si aspettava che la Germania, alla lunga, avrebbe perso la guerra, e sarà probabilmente questa convinzione a indurlo ad accettare, a condizioni durissime per la Russia, il cui esercito zarista era del tutto disgregato e quello comunista si stava appena formando, la pace di Brest-Litovsk nel marzo 1918, che gli servì per sconfiggere l'interna controrivoluzione.
Lenin chiede di svolgere un'ampia propaganda antimilitaristica nell'ambito dell'esercito e sul teatro delle operazioni belliche; chiede anche ai militari di abbattere i governi borghesi dei loro rispettivi paesi, e di non ascoltare i leader della II Internazionale quando mostrano idee nazionalistiche. I popoli oppressi vanno lasciati liberi di decidere il loro destino.
Chiede anche di confiscare le terre ai latifondisti e di pretendere una giornata lavorativa che non superi le otto ore.
*
Sul rapporto Lenin/Kautsky si possono qui aggiungere alcune cose.
Kautsky non era solo un politico marxista (riformista), ma anche un teorico a tutto tondo, cioè uno studioso anche della storia passata (monumentale è p. es. la sua storia del cristianesimo primitivo).
Lenin invece era un “politico puro”, che anche quando svolgeva un'analisi teorica di alcuni problemi (p. es. quelli filosofici), partiva sempre da necessità di chiarezza sorte sul momento. Egli usava la teoria per risolvere i problemi del suo presente storico. Non è mai stato un intellettuale in senso classico, né ha mai disgiunto l'analisi teorica (economica, storica, filosofica...) dalla concretezza della politica, che è l'arte di risolvere le questioni dell'antagonismo sociale, e di farlo in maniera definitiva, almeno sul piano formale (p. es. la socializzazione della proprietà privata fu risolta dalla rivoluzione, anche se la gestione sostanziale fu poi tradita o, quanto meno, travisata dallo stalinismo).
Lenin era un politico rivoluzionario per definizione, che non partecipò mai ad alcun parlamento e che non scrisse mai dei testi storici sulle rivoluzioni borghesi. Neppure il suo testo sulla Comune di Parigi può essere definito di tipo “storico”, nel senso classico del termine. Esaminò quella esperienza rivoluzionaria sulla scia del lavoro già compiuto da Marx, ma solo per mostrare quali errori politici non si dovevano ripetere in occasione della prossima rivoluzione socialista. “Mezzo secolo fa – così scrive – il proletariato era troppo debole, le condizioni obiettive del socialismo non erano ancora maturate, il collegamento e la collaborazione dei movimenti rivoluzionari in tutti i paesi belligeranti non potevano esistere” (p. 150).
Un'idea, questa, vera se ci si riferisce alle condizioni della classe operaia. Ma le condizioni per realizzare un “socialismo agrario” esistevano da un pezzo, sin dai tempi della rivoluzione francese (in Inghilterra addirittura un secolo prima e in Germania ai tempi dell'anabattismo). Quello che mancava era la presenza di intellettuali chiaramente orientati a difendere la causa dei contadini oppressi. In fondo – se ci pensiamo bene – che cosa sono state le rivoluzioni borghesi se non la conseguenza dei fallimenti delle rivolte contadine compiute contro l'aristocrazia terriera? L'antifeudalesimo si era trasformato da contadino a borghese, ma in questa trasformazione perse qualunque aspetto di vera uguaglianza sociale.
Il marxismo non fece altro che prendere atto della sconfitta storica dei contadini, puntando sulla riscossa sociale degli operai industrializzati, che in fondo provenivano dal mondo contadino. In questa maniera però si assunse nei confronti della rivoluzione tecnico-scientifica un atteggiamento feticistico. La tecnologia industriale non poteva più essere messa in discussione, proprio perché con essa era stata creata una nuova classe sociale, il proletariato aziendale. A partire da questo momento i contadini, se volevano emanciparsi dalla loro condizione servile, dovevano allearsi con la classe operaia, ch'era più determinata a compiere la rivoluzione politica, almeno in teoria, poiché nella pratica ciò avvenne, in maniera vittoriosa, solo in Russia (in Cina per es. la rivoluzione maoista del 1949 verrà fatta coi contadini).
Resta il fatto che a tutt'oggi non si è ancora capito che l'unica esperienza democratica ed egualitaria di socialismo può essere soltanto quella della comunità locale che vive di autoproduzione e quindi di autoconsumo, a stretto contatto con la natura, che va scrupolosamente rispettata nelle sue esigenze riproduttive, per cui qualsiasi uso della tecnologia va seriamente meditato e discusso dall'intera comunità. Per due secoli e mezzo il macchinismo, a prescindere dalla sua gestione individualistica o collettivistica, è stato il principale strumento della devastazione ambientale, progressivamente estesasi all'intero pianeta, comportando persino modificazioni strutturali di tipo climatico.
Il marxismo e il leninismo sono state due ideologie di capitale importanza in riferimento alla situazione della classe operaia, che esprimeva l'inconciliabile contraddizione tra capitale e lavoro, ma oggi, alla luce dei grandi limiti del macchinismo in sé, esse hanno bisogno di una profonda revisione, non nell'analisi economica, non nella strategia politica, ma proprio nell'obiettivo finale che si vuole raggiungere, soprattutto nei mezzi che si devono usare per realizzarlo. Qui non ci potrà rifare ad altro che alle esperienze del comunismo primitivo.
Sotto questo aspetto bisogna dire che lo stalinismo è stato una deviazione soggettivistica della democraticità del leninismo, ma sul piano oggettivo ne è stato una logica conseguenza, in quanto il leninismo non riuscì mai a porre le basi per il superamento di se stesso.
1Qui forse è il caso di sottolineare che nel 1912 la socialdemocrazia tedesca aveva conseguito 4.250.000 voti, pari a circa il 35%; il che la portava a essere, coi suoi 397 deputati, il maggior partito del Reichstag. Nel 1914 contava più di un milione di iscritti, possedeva 89 quotidiani e riviste con un milione e mezzo di abbonati.
2P. Struve predicò in Russia il “marxismo legale”, passando poi su posizioni cadette, cioè filo-monarchiche. L. Brentano era un socialista cattedratico e un economista borghese che propagandò la “pace sociale” tra operai e imprenditori nel quadro del capitalismo, per mezzo dei sindacati e di leggi aziendali.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube