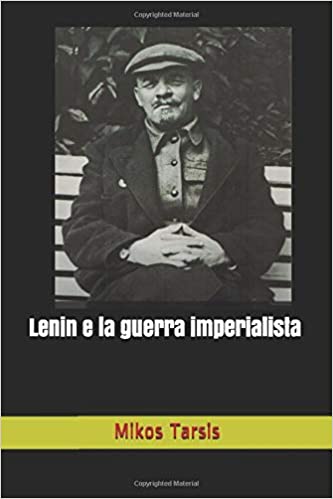
LENIN E LA GUERRA IMPERIALISTICA
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
Guerra e rivoluzione: divergenze interpretative
Nel maggio del 1917 Lenin tiene una Conferenza nella sala del corpo dei cadetti di marina, avente per tema i rapporti tra guerra e rivoluzione (pp. 255-80). Erano presenti duemila persone. È un testo molto importante, valido, sotto tutti i punti di vista, ancora oggi, a dimostrazione che la verità non viene logorata dallo scorrere del tempo.
Lenin esordisce lamentandosi che quando si parla della guerra “la maggior parte dei malintesi nasce dal fatto che noi [sottinteso: i marxisti] parliamo spesso lingue completamente diverse” (p. 255). Probabilmente sarebbe così anche se tutti si attenessero al metodo interpretativo che lui aveva già indicato poco prima: esaminare “il carattere di classe della guerra, le ragioni per cui essa è scoppiata, le classi che la conducono, le condizioni storiche e storico-economiche che l'hanno provocata” (ib.). Soprattutto sul primo punto (quello del “carattere di classe”) molti storici e politici storcerebbero il naso. Infatti, in luogo di “classe” preferirebbero parlare di “nazione”. La borghesia ci tiene a non apparire una classe “particolare”, ma la rappresentante di interessi “generali” e quindi “nazionali”. Tutti, in teoria, possono diventare “borghesi”: a nessuno, vigendo il principio della libertà giuridica universalmente valida, viene impedito. Chi non vi riesce è solo per motivi soggettivi. La proprietà privata dei mezzi produttivi non c'entra nulla: chiunque può acquisirla.1 È facile quindi rendersi conto che, stante le cose in questi termini, il dialogo con la borghesia può essere fatto solo fino al punto in cui non si inizia a parlare di “proprietà privata”, che per la borghesia è fonte primaria della libertà.2
Il lato drammatico di queste osservazioni preliminari è che, molto probabilmente, Lenin non aveva di fronte a sé un pubblico che professava esplicitamente idee “borghesi”, ma un pubblico “marxista” come lui. A un certo punto infatti dice: “Noi marxisti non siamo avversari incondizionati di ogni guerra” (p. 256). Sembra che lo dica per differenziarsi dai piccolo-borghesi di cultura cristiana, dando cioè per scontato che il pubblico “marxista” possa capirlo molto facilmente. Invece le incomprensioni sulla natura della guerra dipendevano da interpretazioni opposte che si davano all'interno della stessa ideologia marxista, cui tutti i socialisti dicevano di ispirarsi, anzi di volersi attenere scrupolosamente.
Ormai, al tempo di Lenin, era possibile anche questo, e la sconcertante involuzione borghese della II Internazionale stava lì a dimostrarlo in maniera eloquente. Lenin si stava rivolgendo a un pubblico di idee socialiste, con le qualiu si interpretava il fenomeno della guerra imperialistica in maniera del tutto opposta.
I suoi ragionamenti erano sì difficili da digerire, perché non consueti, ma erano logici e svolti all'interno di un linguaggio semplice, accessibile a chiunque. Anche in questo stava la sua grandezza. E la prima cosa che voleva far capire era la differenza tra “guerra tra le classi” e “guerra tra le nazioni”, tra “guerra rivoluzionaria” e “guerra imperialistica”. In teoria i marxisti non dovrebbero essere come i cristiani o gli idealisti astratti, gli utopisti..., gli “avversari incondizionati di ogni guerra”. E non dovrebbero neppure essere come i liberal-borghesi, che dicevano di voler la guerra solo come extrema ratio. Invece purtroppo oscillavano tra le due posizioni.
Tra le classi esiste una lotta a causa di interessi oggettivi contrapposti. Lo scontro tra le classi è inevitabile e, poiché si tratta di uno scontro tra un'esigua minoranza di possidenti e una grande maggioranza di nullatenenti, dovrebbe essere la minoranza che si adegua alla volontà della maggioranza. Tuttavia, siccome ciò non succede mai spontaneamente, le guerre civili diventano inevitabili.
Lenin anzitutto si stupisce che vi siano molti marxisti che, quando si tratta di parlare di guerra, predicano la “non violenza ad oltranza”, come se in questa maniera pensassero di costituire una valida alternativa al comportamento imperialistico della borghesia. In realtà – egli afferma – se negli ultimi 125-135 anni vi sono state molte guerre reazionarie, una di sicuro è stata rivoluzionaria, quella che la Francia di fine Settecento condusse contro “la coalizione dell'Europa monarchica, retrograda, feudale e semifeudale” (p.. 256).
Un giudizio, secondo noi, generoso, in quanto una cosa fu, per i francesi, difendersi dalla suddetta coalizione; tutta un'altra invece quella di vedere Napoleone che esportava con la forza delle armi il diritto borghese. Non esistono guerre rivoluzionarie quando determinati princìpi vengono imposti con la forza a popoli stranieri. Il che non vuol dire che la coalizione anti-napoleonica avesse più ragioni di vincere. Diciamo che in quel frangente storico nessuna forza in campo aveva contezza di cosa davvero fosse la verità democratica, la democrazia politica.
Nondimeno Lenin aveva ragione quando distingueva le varie tipologie di guerra. Sicuramente quella della rivoluzione americana fu giusta contro gli inglesi, ma neppure per un momento si disse, in quel frangente, qualcosa che non fosse pienamente “borghese”. Anzi, affermazioni proto-socialiste furono dette, da parte dei Livellatori, durante la rivoluzione inglese di un secolo prima, benché subito dopo furono affossate dalla borghesia calvinista rappresentata da Cromwell, che pur era progressista rispetto alla nobiltà anglicana. Questo per dire che tutte le guerre della borghesia, anche quelle più rivoluzionarie e democratiche, contengono elementi che fanno presagire uno sviluppo decisamente reazionario.
Con ciò ovviamente non si ha intenzione di dire che il socialismo debba rinunciare a qualunque guerra per potersi affermare. Semplicemente bisogna fare attenzione al fatto che quando si entra in guerra tutto viene semplificato al massimo: il diritto è subordinato alla violenza, e chi pensa di possedere la verità delle cose si ritiene autorizzato a comportarsi come meglio crede.
Lenin però sembra fare un altro ragionamento. La sua intenzione è quella di mostrare che l'idea di compiere una rivoluzione politica socialista in Russia è giusta anche nel caso in cui ciò comportasse l'uso della violenza, come furono giuste non poche rivoluzioni borghesi. Se ha ragione Clausewitz quando afferma che “la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi” – e per Lenin sicuramente ne ha contro chi ritiene la guerra un evento improvviso, casuale, avulso dalla politica dei governi e di certe classi sociali –, bisognerebbe anche specificare che ciò è vero solo nei regimi antagonistici, e non è detto che con la guerra si riescano a risolvere quei problemi in cui la politica ha fallito.
Se c'è una cosa che non aiuta il formarsi della fiducia reciproca, questa è proprio la guerra. L'unica guerra sensata è quella in cui si è costretti a ricorrere quando la gestione della proprietà privata dei mezzi produttivi porta a sviluppare contraddizioni assolutamente insopportabili. La minaccia di una guerra civile dovrebbe servire per far vedere alle classi dominanti che se non si arrendono, rischiano di scomparire anche fisicamente. Nel mondo animale spesso basta la minaccia di uno scontro diretto per regolare una questione territoriale o riproduttiva o alimentare.
Gli esseri umani, invece, poiché si ritengono “onnipotenti”, spesso e volentieri preferiscono sterminarsi a vicenda, almeno finché la resa di qualcuno non viene imposta dall'evidenza dei fatti. In tal senso dovremmo dire che l'Europa occidentale, dal tempo della civiltà cretese, è quasi sempre stata in guerra. Non è mai stata la pace a essere intervallata dalle guerre, ma il contrario.
A tale proposito Lenin scrive, assai giustamente: quando abbiamo avuto l'impressione che la pace regnasse in Europa, era solo “perché la dominazione dei popoli europei sulle centinaia di milioni di abitanti delle colonie veniva realizzata attraverso guerre continue, incessanti, ininterrotte, guerre che noi europei non consideriamo come tali, poiché troppo spesso somigliano piuttosto a un selvaggio massacro, allo sterminio di popolazioni inermi” (p. 258).3 Sterminare gli indigeni per noi europei non vuol dire compiere una guerra, ma una semplice “violenza”, resa necessaria dal fatto che la nostra civiltà è troppo superiore alla loro; e se gli indigeni non ci fanno spazio per poterci sviluppare al massimo, il loro destino è segnato. Il genocidio è giustificato dall'evoluzione del progresso umano.
Lenin, tuttavia, non arriverà mai a dire che lo stile di vita di quegli indigeni costituiva l'ultima alternativa rimasta sulla Terra alle civiltà antagonistiche. Però aveva capito che la ricchezza degli europei si reggeva sullo sfruttamento delle colonie. Lenin era uno dei pochi leader della II Internazionale che collegava lo scoppio della guerra europea alla volontà delle maggiori potenze europee di dominare l'intero pianeta. Lui stesso scrive che “nessun giornale può dare una definizione del concetto di annessione che valga tanto per la Germania quanto per la Russia e che possa essere applicato a ogni paese” (p. 263). E non perché la definizione sarebbe astratta, essendo di carattere generale, quanto perché nessuno vuole ammettere che “tutta la guerra in corso è la continuazione della politica di annessioni...” condotta in precedenza, il che rende a un marxista del tutto indifferente la questione di sapere chi ha attaccato per primo.
Le rivalità non riguardavano il solo continente europeo, ma erano divenute internazionali. Il colonialismo delle singole nazioni capitalistiche si era trasformato in imperialismo, cioè non si trattava più di capire come accaparrarsi singole colonie da sfruttare, ma, partendo da tale sfruttamento, il problema era diventato quello di come imporsi sul mondo intero, attraverso le proprie industrie multinazionali, o anche solo mediante i propri capitali, capaci di attraversare gli oceani in men che non si dica. L'imperialismo doveva diventare un sistema da gestire a livello internazionale tra le maggiori potenze capitalistiche, le quali dovevano decidere una volta per tutte come ripartirsi l'intero pianeta.
Lenin delinea molto chiaramente la sua analisi interpretativa della guerra imperialistica. Da un lato vede l'Inghilterra, “lo Stato che possiede la maggior parte del globo, lo Stato che è al primo posto per la sua ricchezza, acquisita non tanto col lavoro dei suoi operai, quanto invece, principalmente, con lo sfruttamento delle sue innumerevoli colonie, con la forza smisurata delle sue banche” (p. 260).
Dall'altro lato vede il nuovo capitalismo emergente, quello tedesco, “ancora più rapace, ancora più brigantesco, un gruppo che si è presentato al banchetto del capitalismo quando i posti erano ormai occupati, ma che ha introdotto nella lotta nuovi metodi di sviluppo della produzione capitalistica, una tecnica superiore, un'organizzazione incomparabile... [grazie a cui] il capitalismo dell'epoca della libera concorrenza diventa il capitalismo dei trust, dei sindacati e dei cartelli giganteschi. Questo gruppo ha introdotto il principio della statizzazione della produzione capitalistica, della fusione di forze gigantesche, come il capitalismo e lo Stato, in un meccanismo unico...” (p. 261).
In Germania, ma si potrebbe dire anche in Italia e in Giappone, il capitalismo era potuto nascere grazie all'appoggio decisivo dello Stato, il quale, in luogo di una funzione neutrale, equidistante, che non privilegia nessuno, aveva assunto la fisionomia del principale supporter di una forma di capitalismo che, pur essendo imberbe, voleva imporsi a livello mondiale.
Praticamente per Lenin il capitalismo inglese rappresentava qualcosa di obsoleto, in quanto eminentemente individualistico, che aveva saputo ridurre la potenza di altre due nazioni capitalistiche basate sulla libera concorrenza: l'Olanda e la Francia, ma che avrebbe avuto grandi difficoltà a vincere la concorrenza tedesca, benché partisse enormemente avvantaggiato grazie appunto al proprio apparato coloniale e naturalmente alla flotta navale.
Tuttavia, in quel momento era la Francia a rappresentare la maggiore potenza militare sul continente europeo, a livello di forze terrestri. Aveva deciso questo suo ruolo sin dalla guerra dei Cent'anni contro gli inglesi, e l'aveva confermato nella guerra dei Trent'anni contro l'impero germanico. La Francia non aveva sviluppato una grande potenza navale neppure sotto Napoleone, che pur aveva conquistato mezza Europa. Preferiva il dominio su terra, anche se disponeva di grandi risorse coloniali, soprattutto in Africa.4
*
Vi sono altri argomenti trattati nel testo di quella importante conferenza. Uno è il cosiddetto “difensismo rivoluzionario”. Esso “consiste nel giustificare la guerra col pretesto che abbiamo fatto la rivoluzione [di febbraio]... Abbiamo rovesciato Nicola II”. Queste le sue parole, cui però subito dopo aggiunge che il potere è stato preso dai capitalisti e dai grandi proprietari fondiari. “In Europa queste rivoluzioni sono avvenute cento anni or sono...”. Ma “se alcuni popoli selvaggi non si piegano alla nostra banca civilizzata, noi inviamo subito l'esercito per restaurare la civiltà, l'ordine e la cultura, come ha fatto Liakhov in Persia...” o la Francia repubblicana in Africa.
Qualcuno avrà sicuramente pensato che Lenin era un incontentabile, che voleva correre troppo in fretta, ch'era un utopista a pensare che il capitalismo in Russia potesse essere abbattuto così facilmente, ch'era un ingenuo a voler rendere pubblici dei trattati militari segreti... Qualcun altro invece avrà pensato ch'era un pacifista a oltranza contro la guerra imperialistica, in quanto neanche per un momento aveva voluto dissociare la guerra dall'imperialismo.
Molte volte Lenin disse di non essere contrario alla “guerra rivoluzionaria”. Tuttavia con questa espressione egli intendeva soltanto la “guerra civile”, al massimo una guerra in difesa delle conquiste rivoluzionarie contro gli Stati esteri nemici del socialismo: di sicuro non aveva mai inteso una guerra di conquista. Ripeteva che, di fronte a una guerra imperialista, è del tutto indifferente sapere chi ha sparato il primo colpo.5 Ci teneva anche a precisare che dopo aver fatto, in politica interna, una guerra contro i capitalisti russi, lui non avrebbe mai accettato di fare, subito dopo la rivoluzione, una guerra contro gli Stati capitalisti. Sarebbe stato un suicidio compiere una guerra in un momento di debolezza. Ecco perché voleva la pace ad ogni costo con gli altri Stati, proprio per portare a compimento la rivoluzione, assestando un colpo demolitore alle forze reazionarie che sicuramente avrebbero cercato di reagire all'esproprio dei loro beni.
In pratica stava facendo capire al suo uditorio che una guerra difensiva non può essere fatta quando al governo vi sono i capitalisti. Ogni loro promessa di non annettere territori altrui andava considerata una menzogna, serviva solo per ingannare i pacifisti a oltranza. “Nei due mesi seguiti alla rivoluzione [di febbraio] gli industriali hanno saccheggiato tutta la Russia...” (p. 273). “Solo il popolo può esercitare il controllo” (p. 274). Ingenui, semmai, erano i socialisti presenti nel governo provvisorio, i quali fingevano di non sapere che “l'esperienza delle repubbliche parlamentari insegna che non si può prestar fede alle dichiarazioni che rimangono sulla carta” (p. 273).
In pratica era come se avesse detto: “Se dobbiamo morire in guerra, facciamolo per dei motivi decisi dal proletariato e non da chi detiene le leve del potere economico e politico. Dal punto di vista del capitale non esiste alcuna vera differenza tra l'autocrazia zarista e il governo borghese, poiché entrambi vogliono condurre la guerra per annettersi qualcosa”.
Quale socialista di spicco della II Internazionale, nel corso della guerra, era così interessato a tutelare gli interessi dei popoli colonizzati? Anche se Lenin l'avesse fatto solo per contestare l'operato dei paesi occidentali, chi avrebbe potuto dirgli ch'era contrario al diritto all'autodeterminazione dei popoli? Oggi sembra pacifico accettare un diritto del genere, ma quella volta non lo era affatto nell'ambito del socialismo, in quanto si temeva che in tale maniera la borghesia avrebbe avuto la meglio sui popoli più deboli, sulle tradizioni più primitive. Neppure Rosa Luxemburg, la più rivoluzionaria in Europa occidentale, riusciva ad accettare un diritto del genere, preferendo di gran lunga l'esportazione forzata della rivoluzione proletaria.
Le intenzioni di Lenin erano democratiche sino in fondo. Non erano una maschera, una facciata di comodo... In quella conferenza si stava rivolgendo a dei socialisti, rimproverandoli di non essere abbastanza democratici, cioè di guardare la guerra sulla base di considerazioni politiche che contraddicevano l'etica (il divieto di fare annessioni) o, al contrario, di guardare l'etica senza fare considerazioni politiche di livello superiore (quelle favorevoli alla rivoluzione socialista). Se il capitalismo è il nemico n. 1 del socialismo, non gli si possono fare concessioni quando esistono le possibilità concrete d'impedirgli di esistere.
Lenin stava dicendo queste cose nel maggio 1917. Dopo pochi mesi avrebbe dimostrato ch'erano fattibili. Per lui tutti i ministri che partecipavano a un governo borghese erano “pseudo-socialisti”; erano ministri che non avevano assolutamente capito che il vero potere politico non stava nel governo istituzionale, ma nella rete dei soviet operai, militari e contadini, sviluppatasi spontaneamente in tutta la Russia. Il vero potere non stava nella democrazia parlamentare ma in quella sociale, non in quella delegata ma in quella diretta. “La rivoluzione russa [di febbraio] non ha modificato la guerra, ma ha creato organismi che non hanno riscontro in nessun altro paese, e che non sono esistiti nella maggior parte delle rivoluzioni occidentali” (p. 271).
Qualcuno avrebbe potuto obiettargli: “Se la Russia ha davvero un'organizzazione sociale sconosciuta agli altri Stati borghesi, vincerà di sicuro contro la Germania. Perché non continuare la guerra?”. Chi avesse posto una domanda del genere avrebbe mostrato di non capire che, agli occhi di Lenin, una guerra condotta in nome degli interessi dei capitalisti è immorale per definizione. Quella non era una guerra per liberarsi del feudalesimo reazionario, ma per poter avere il privilegio esclusivo di opprimere popoli e nazioni ancora fermi allo stadio del comunismo primitivo, assolutamente incapaci di difendersi. Neppure se quei popoli si fossero trovati allo stadio dello schiavismo o del servaggio feudale, una guerra sarebbe stata giusta.
Un'altra obiezione che veniva mossa alle sue proposte è lui stesso a formularla: “Ci si obietta: noi vogliamo che il potere passi nelle mani dei soviet, ma i soviet non lo vogliono. Replichiamo che l'esperienza suggerirà ai soviet, e tutto il popolo lo vedrà, che non c'è altra soluzione. Noi non vogliamo 'impadronirci' del potere, poiché tutta l'esperienza delle rivoluzioni ci insegna che stabile è soltanto quel potere che poggia sulla maggioranza della popolazione” (p. 277).
Lenin sapeva bene che impadronirsi del potere con un semplice colpo di stato sarebbe stato avventuristico. Ecco perché voleva una democrazia assolutamente popolare, un socialismo assolutamente democratico. La dittatura doveva servire per reprimere la reazione borghese, ma non doveva essere gestita da un potere superiore agli stessi soviet (come invece accadrà sotto lo stalinismo).
*
Lenin esprime dei giudizi anche sugli Stati Uniti d'America.
“La guerra scatenata a causa della schiavitù si è conclusa nel 1865. Da quel tempo laggiù sono nati i miliardari, che tengono nel loro pugno finanziario tutta l'America, che preparano il soffocamento del Messico e inevitabilmente faranno guerra al Giappone per spartirsi il Pacifico. Questa guerra viene preparata già da qualche decennio” (p. 275).
In effetti era così. Nelle grandi democrazie borghesi del XX sec., quelle che devono mobilitare milioni di persone, le guerre vanno preparate con largo anticipo. È possibile che non vengano neppure fatte da chi ha iniziato a prepararle. Nell'ambito del capitalismo è del tutto irrilevante se, nel momento di far scoppiare una guerra, al governo si trova un democratico, un repubblicano o un socialista. Le leggi o le esigenze del capitale sono spesso del tutto indipendenti dalla volontà dei governi politici.
Quando scoppiò la guerra civile americana, al nord si era contrari alla schiavitù solo perché le industrie avevano bisogno di manodopera salariata in grande quantità, non perché si fosse contrari alla schiavitù in sé. In fondo erano schiavisti anche i principali leader della rivoluzione americana contro gli inglesi. La schiavitù serviva proprio per fronteggiare meglio la concorrenza europea, almeno finché non fu sviluppata una industrializzazione di pari livello. Più che una lotta contro la schiavitù, in nome della libertà personale, fu una guerra civile tra il capitalismo industriale emergente e il capitalismo agricolo tradizionale, privo di una vera industrializzazione, che gli inglesi, al tempo della loro colonizzazione americana, non potevano permettere per ovvi motivi.
Lenin conclude le sue osservazioni con queste parole: “I capitalisti americani son dovuti intervenire in questa guerra per avere un pretesto con cui, invocando gli alti ideali della difesa dei diritti delle piccole nazionalità, creare un forte esercito permanente” (p. 276). Cosa che sarebbe stata impossibile puntando sull'individualismo americano, refrattario a un “servizio militare obbligatorio”.
Ma i giudizi più significativi sugli Stati Uniti li esprime nella Lettera agli operai americani (pp. 343-49), scritta nell'agosto 1918, mentre gli inglesi, pur avendo i tedeschi ottenuto molti territori col trattato di Brest-Litovsk, non solo si sono tenuti tutte le loro colonie, ma hanno anche “saccheggiato tutte le colonie tedesche in Africa, depredato la Mesopotamia e la Palestina [a danno dei turchi], strangolato la Grecia e cominciato a depredare la Russia”.
Nella Lettera, pur mancando qualunque riferimento al genocidio dei nativi pellerossa, si fa iniziare la storia del popolo americano con la lotta di liberazione contro gli inglesi. Egli fa notare agli operai che, nonostante tale liberazione, i miliardari americani, moderni proprietari di schiavi6, danno il loro consenso “all'intervento armato delle belve anglo-giapponesi che mirano a strangolare la prima repubblica socialista” (p. 343). Non solo, ma gli stessi capitalisti statunitensi sono entrati in Russia “con la scusa di 'difenderla dai tedeschi'”, così come avevano occupato le Filippine nel 1898 con la scusa di 'emanciparle' dalla Spagna. Non a caso anche quei capitalisti avevano rifiutato tutte le proposte di pace dei bolscevichi. Anzi accusavano quest'ultimi di aver permesso alla Prussia, col trattato di pace, di concentrare le sue truppe verso occidente, e si rifiutavano di capire perché Lenin, per difendere la rivoluzione, fosse disposto a fare delle trattative di pace separata col nemico. Stessa posizione era tenuta dalla borghesia anglo-francese.
Egli non chiede agli operai da dove siano spuntati fuori questi miliardari; anzi, sembra quasi dare per scontato ch'essi sono emersi dalla guerra di liberazione nazionale contro gli inglesi. Possibile – vien da chiedersi – che una ex colonia abbia potuto favorire in così poco tempo la formazione di una classe di magnati dell'industria e della finanza? Secondo lui si erano arricchiti in maniera così spropositata perché “disponevano della posizione geografica più sicura” (p. 345), nel senso che il continente era protetto da due oceani. Erano inoltre favoriti dalla enorme vastità del loro territorio nazionale.
Lenin non ha mai messo in discussione le esigenze dell'industrializzazione, ma solo le dinamiche della proprietà privata. Giudicava gli Stati Uniti al primo posto “per il grado di sviluppo delle forze produttive del lavoro umano associato, per l'impiego delle macchine e di tutte le meraviglie della tecnica moderna” (p. 344). Sotto questi aspetti li giudicava superiori agli stessi tedeschi. Rispetto ai tedeschi e agli americani vedeva i russi incredibilmente arretrati. E tuttavia ci teneva a sottolineare che ciò non aveva impedito alla Russia di compiere la prima rivoluzione socialista della storia. Ora non le restava che copiare il meglio dei paesi capitalisti. Ma davvero il capitalismo era in grado di offrire delle indicazioni positive?
1Inutile dire che questo principio è vero finché non tutta la proprietà dei mezzi produttivi è stata privatizzata dalla borghesia. In questi casi, se si vuole restare sul piano della mentalità borghese, le strade diventano due: o si dimostra di possedere una competenza superiore su un qualche aspetto della conoscenza umana (oggi p. es. i grandi capitalisti si sono formati grazie all'info-telematica), oppure ci si organizza sul piano criminale. Alcuni invece si sono arricchiti in maniera significativa allestendo un'impresa in quei paesi ex-socialisti statali, dove è possibile sfruttare una manodopera sottocosto, ma questa è stata una opportunità inaspettata, offerta dal caso. Altro modo di arricchirsi, tra il casuale e l'illecito, è il gioco in borsa.
2Attenzione che con l'aggettivo “privata” non s'intende la proprietà “personale” degli oggetti di consumo o di lavoro, ma proprio il possesso esclusivo, sancito giuridicamente, di mezzi e strumenti produttivi, senza i quali nessuna società umana potrebbe esistere, quindi ci si riferisce alla terra, alle falde acquifere, alle aziende, ai capitali, alle miniere, alle ricchezze del sottosuolo, a ciò che di regola viene considerato appartenente al demanio pubblico.
3Si noti con quanta disinvoltura Lenin, ch'era russo, si considerasse “figlio del continente europeo”. Lo stesso si può dire di tanti altri dirigenti della III Internazionale. Probabilmente la percezione in Europa che la Russia non fosse più un paese “europeo” è sorta solo dopo la rivoluzione d'Ottobre. Il pregiudizio è stato così radicato per 70 anni che ancora oggi, a distanza di quasi 30 anni dal crollo del cosiddetto “socialismo reale”, permane inalterato, anche in considerazione del fatto che gli Stati Uniti cercano di ostacolare in tutti i modi qualunque rapporto tra Unione Europea e Russia.
4Oggi esiste una nuova potenza mondiale, il cui capitalismo assomiglia a quello tedesco, ma col vantaggio d'appoggiarsi a un'ideologia socialista, superiore a quella liberal-borghese: la Cina. La quale si trova a fronteggiare la più grande potenza capitalistica mondiale, erede della tradizione individualistica inglese, cui è stato tolto, con la rivoluzione americana, ogni residuo aristocraticismo: gli Stati Uniti, la cui smisurata forza è dovuta alla grande estensione del proprio territorio, che ha permesso a questo paese, con le proprie risorse umane e materiali, di vincere ben due guerre mondiali e di sottomettere tutte le esperienze di capitalismo, ivi incluse quelle statalizzate.
5Oggi invece sarebbe importante, visti gli arsenali nucleari a disposizione di non pochi Stati, che tutti loro assumessero l'impegno a non usare per primi, in caso di conflitto, armi del genere.
6Qui col termine “schiavi” bisogna sottintendere quelli “salariati”, non gli schiavi veri e propri dei piantatori del sud, in quanto la guerra di Secessione aveva giuridicamente abolito la schiavitù fisica.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube