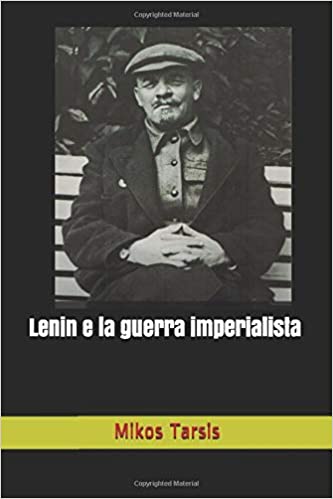
LENIN E LA GUERRA IMPERIALISTICA
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
Le prime crepe interne
Con l'articolo Strano e mostruoso, del febbraio 1918, Lenin deve presto rendersi conto che anche all'interno del suo partito, che pur si trova già al potere, vi sono degli elementi che non vogliono la pace e che rischiano di compromettere i risultati fin lì raggiunti. Sono i cosiddetti “comunisti di sinistra” di Mosca, capeggiati da Bucharin, i quali rifiutano il trattato di pace separata con la Germania firmato a Brest-Litovsk il 3 marzo 1918. Avevano intenzione di separarsi dal partito se non fosse stato rinnovato completamente il Comitato centrale.
In effetti quel trattato era stato particolarmente oneroso per la Russia: la Germania aveva ottenuto la Polonia (gestita prima dallo zarismo, poi dal governo provvisorio), quasi interamente le terre Baltiche, tutta l'Ucraina, la Georgia (che diventava un protettorato tedesco) e le erano stati promessi forti contributi di guerra. D'altra parte gli Stati dell'Intesa avevano rifiutato tutte le proposte di pace contenute nel suddetto Decreto e la controrivoluzione interna era piuttosto agguerrita, per non parlare dell'interventismo straniero che la supportava in varie maniere.1 Lenin era convinto che la neonata Russia socialista non ce l'avrebbe fatta e che la Germania avrebbe potuta occuparla. Era però anche convinto che la Germania avrebbe perso la guerra. E infatti nel novembre del 1918, dopo la fuga del kaiser, il trattato di Brest-Litovsk fu immediatamente revocato. Rimase quindi in vigore pochi mesi, quelli sufficienti per tenere in piedi una rivoluzione molto traballante, che comunque dovette affrontare ancora per qualche anno la reazione degli anticomunisti.
Nel suo suddetto articolo Lenin non minaccia alcuna “scomunica”, alcuna ritorsione contro i comunisti di sinistra; anzi, ritiene sia “un diritto legittimo” dissentire sulle decisioni del CC del partito.2 Tuttavia, siccome egli è un “filologo” nelle questioni di politica, nel senso che su ogni singola parola o frase dal sapore equivoco o contraddittorio è capace di scriverci lunghi articoli, anche questa volta non può esimersi dall'intervenire in maniera molto circostanziata.
Una cosa infatti è “dissentire” su decisioni che vengono prese; un'altra, molto diversa, è minacciare una scissione che comporti la perdita del potere politico. Nella risoluzione dei comunisti moscoviti era stato annesso un testo esplicativo che Lenin giudicò “strano e mostruoso”. In esso si diceva a chiare lettere che i firmatari, “nell'interesse della rivoluzione internazionale ritenevano opportuno ammettere la possibilità di perdere il potere sovietico, che stava diventano puramente formale”. Cioè non volevano soltanto un rinnovo integrale del CC, ma preventivavano anche, con fare vagamente minaccioso, la fine del potere sovietico. Questo perché secondo loro la decisione di accettare la pace separata coi prussiani indicava un atteggiamento moderato, opportunista. E siccome questo atteggiamento, secondo loro, era nettamente prevalente nel CC di Pietrogrado, si dichiaravano disposti a lottare anche contro chi lo sosteneva, “nell'interesse della rivoluzione internazionale”, col rischio di perdere un potere statale faticosamente conquistato.
A Lenin non ci volle molto per capire che erano parole prive di senso. Non ci poteva essere alcun legame “tra i postulati [il rifiuto della pace separata coi tedeschi] e la deduzione [la fine del potere sovietico]” (p. 322). Se questo era il livello di coerenza logica dei compagni di partito, forse Lenin avrebbe davvero dovuto chiedersi se non sarebbe stato meglio che Kerenskij continuasse a governare.
Al massimo, infatti, i moscoviti avrebbero potuto dire il contrario, e cioè che, nonostante il suddetto trattato di pace, si sarebbe fatto in modo di rendere ai prussiani la vita difficile; cosa che poi fecero i socialisti-rivoluzionari di sinistra, usando però degli attentati terroristici contro alcune autorità tedesche presenti in Russia e Ucraina, in conseguenza dei quali i bolscevichi ruppero con loro ogni rapporto.3
Una cosa, infatti, era rifiutare, nel merito, il suddetto patto di pacificazione, rispettandolo però integralmente e scrupolosamente nella forma, in tutte le sue clausole, visto che la maggioranza del partito l'aveva accettato. Un'altra, del tutto diversa, era quella di servirsene come pretesto per rovesciare il governo sovietico in carica. Eliminare una rivoluzione nazionale già compiuta in nome di una rivoluzione internazionale ancora da farsi era davvero “mostruoso”. Per arrivare a una conclusione del genere doveva esserci una profonda rivalità tra i compagni di Mosca e quelli di Pietrogrado, la quale forse rifletteva una rivalità tra le due stesse città.
Questi estremisti non avevano capito che se ci fosse stata anche solo una possibilità di continuare la guerra contro gli imperialisti tedeschi, salvaguardando completamente gli obiettivi della rivoluzione, Lenin non avrebbe esitato sulla scelta da fare. Evidentemente però quella possibilità mancava: ecco perché, con grande senso realistico delle cose, egli aveva scelto il male minore. In fondo ai tedeschi venivano sì concesse molte terre da occupare, ma con l'assicurazione che non avrebbero cercato di occupare Pietrogrado. D'altra parte che bisogno ne avrebbero avuto? Con la pace di Brest-Litovsk essi avevano ottenuto infinitamente di più di quanto sperato vincendo la guerra. Con tutte quelle terre avrebbero avuto tante di quelle risorse da poter continuare la guerra per ancora molti mesi contro la Francia. Non dimentichiamo che la definitiva sconfitta dei tedeschi avvenne solo dopo lo sbarco degli americani in Europa, senza il quale la situazione sembrava in perfetta parità. La guerra di posizione, in trincea, impediva a chiunque di vincere con decisione. Si poteva dunque dissentire dalle direttive degli organi superiori del partito bolscevico, ma non sino al punto da volere la fine del governo sovietico, mettendosi oggettivamente dalla parte del nemico prussiano e non solo prussiano.
Lenin non può che divertirsi a ironizzare sull'incongruenza di questi comunisti moscoviti, molto vicini, nel loro estremismo, ai socialisti-rivoluzionari di sinistra: “i nostri autori pensano che sia opportuno, nell'interesse della rivoluzione internazionale, ammettere la possibilità di una sconfitta militare che porterebbe alla perdita del potere sovietico, cioè alla vittoria della borghesia in Russia” (p. 322). In sostanza stavano ammettendo, seppur “indirettamente”, che “il rifiuto delle condizioni di pace proposteci dalla Germania avrebbe portato la Russia alla sconfitta e all'abbattimento del potere dei soviet” (p. 323).
Quei comunisti di sinistra non avevano in realtà intenzione di dire questo, ma qui Lenin ha buon gioco nel rivoltare la frittata e nel dimostrare che quella pace era giusta proprio nell'interesse della rivoluzione, e che se non l'avessero firmata, di sicuro avrebbero perso la guerra con la Germania. In tale maniera faceva passare quei comunisti estremisti per dei complici di una eventuale disfatta del socialismo, per degli alleati della borghesia russa e dei militaristi prussiani, a prescindere dalle loro intenzioni soggettive. Non si rendevano conto che se la Russia avesse perso la guerra con la Germania, i bolscevichi non sarebbero riusciti a conservare il potere.
*
Nello stesso articolo, a p. 325, vi sono considerazioni dal contenuto politico piuttosto alto, che potrebbero essere utilizzate per comprendere tantissimi avvenimenti politici della storia del genere umano. Lenin, in pratica, fa capire che gli interessi della rivoluzione internazionale non possono essere “stimolati” dalla guerra. Le guerre tra Stati non sono inevitabili. Non si può dare per scontato che nell'epoca dell'imperialismo debbano per forza esserci, o che esse siano il solo strumento o quello principale che può far scoppiare delle rivoluzioni.
Lenin stava qui facendo un discorso di “pedagogia politica”. Non dobbiamo infatti dimenticare ch'egli ha sempre detto che nell'imperialismo le guerre sono inevitabili quando in scena entrano nuovi competitori che vogliono avere rilevanza mondiale. Ma questo non accade tutti i giorni. Quanto alle rivoluzioni, esse “si sviluppano a mano a mano che si inaspriscono le contraddizioni di classe che le generano” (p. 325). Cioè vanno interpretate come un fenomeno interno alle singole popolazioni. “Il marxismo ha sempre negato la possibilità di 'stimolare' le rivoluzioni”. “L'insurrezione armata non è una forma di lotta obbligatoria sempre e in qualsiasi condizione”. Incredibile che questo venisse detto da un leader che riteneva impossibile in Russia una vera rivoluzione senza armare tutto il popolo. Evidentemente sapeva guardare le cose a 360 gradi.
“In realtà gli interessi della rivoluzione internazionale esigono che il potere dei soviet... aiuti questa rivoluzione4, ma scegliendo una forma di aiuto corrispondente alle sue forze” (ib.). Diceva questo per evitare il pericolo dell'avventurismo, tipico delle forme estremistiche o anarcoidi del fare politica; e anche perché non escludeva l'eventualità che in uno scontro aperto con la Germania, la Russia ne uscisse sconfitta. Una eventualità che gli ultrasinistri di Mosca non volevano neppure prendere in considerazione.
Leggendo queste parole ci si chiede, a volte, come abbia potuto Lenin fare una “rivoluzione” così epocale. Era circondato, spesso e volentieri, da compagni di partito inaffidabili, poco intelligenti, a volte addirittura, come per es. Stalin, privi di scrupoli. Ma la risposta di Lenin la conosciamo già: non è possibile scegliere i compagni migliori con cui fare le rivoluzioni.
Poi arriva a prendere in giro questi compagni di partito, evidenziando, con una domanda retorica, la loro pochezza intellettuale (e, si badi bene, non erano compagni qualunque, ma leader di primo piano, come Bucharin, Pjatakov, Radek...). “Gli autori della risoluzione ritengono forse che la rivoluzione in Germania sia già cominciata... e che noi dobbiamo dedicare le nostre forze ad aiutare gli operai tedeschi, dobbiamo perire noi stessi (perdita del potere sovietico) salvando la rivoluzione tedesca...?” (ib.). Stava ponendo una domanda dal sapore religioso. Anche nei vangeli infatti è detto che il sacrificio di Cristo avrebbe salvato l'umanità.
“Noi, soccombendo [in una guerra tra Stati], distrarremmo una parte delle forze della controrivoluzione tedesca e così salveremmo la rivoluzione tedesca” (p. 326). Eliminare una rivoluzione già fatta per salvarne un'altra ancora da fare. Si poteva essere più stupidi? Eppure Lenin aveva fatto la rivoluzione con questi leader!5 Possibile che solo lui si rendesse conto che la Germania era “ancora ben lontana dallo scoppiare, dall'arrivare alla guerra civile” (ib.)? Possibile che non capissero che, ammettendo la possibilità di perdere il potere, i sovietici non avrebbero aiutato ma ostacolato la maturazione della rivoluzione tedesca? Anzi, tutto il proletariato mondiale si sarebbe demoralizzato. Tutti si sarebbero “spaventati dalla disfatta della Russia sovietica, come la disfatta della Comune nel 1871 spaventò gli operai inglesi” (ib.).
Dunque, gli illogici ragionamenti degli estremisti moscoviti potevano esser mossi – scrive ancora Lenin – soltanto da “uno stato d'animo caratterizzato dal più profondo e desolato pessimismo, da un senso di assoluta disperazione” (ib.). Neppure “i francesi nel 1793 avrebbero mai detto che le loro conquiste, la repubblica e la democrazia stavano diventando puramente formali, che bisognava ammettere l'eventualità di perdere la repubblica” (p. 327).
“Agli inizi del XIX sec., durante il periodo delle guerre napoleoniche, la Prussia e vari altri paesi si trovarono di fronte a disfatte, invasioni, umiliazioni e oppressioni incomparabilmente e infinitamente più dure e più gravi che non la Russia del 1918. Ciononostante i migliori uomini della Prussia... non si disperavano affatto e non parlavano di un significato 'puramente formale' delle loro istituzioni politiche nazionali” (ib.). Anzi, alla fine “tornarono a sollevarsi e si liberarono” dei francesi “non senza sfruttare le discordie esistenti tra i più forti invasori in concorrenza tra loro” (p. 328).
Forse era stato proprio questo giudizio impietoso, del tutto fuori luogo, ingeneroso, a ferire l'amor proprio di Lenin, che aveva speso l'intera sua vita a realizzare qualcosa che avrebbe potuto riscattare decine di milioni di proletari russi. Poteva accettare la critica su talune decisioni del CC, ma gli sembrava una cosa “mostruosa” che dei compagni di partito ritenessero la rivoluzione compiuta una cosa avviata a diventare “formale”. Lenin si sentiva tradito, e negli ultimi anni della sua vita lo sarà ancor più da parte di Stalin. Questi intellettuali ingrati volevano forse trasferire a Mosca tutti i poteri del partito e dello Stato? Volevano salire sul carro dei vincitori, togliendo di mezzo il principale cocchiere? Era questa la loro riconoscenza?
Il proletariato “sa che bisogna sottomettersi se non ci sono le forze e, nondimeno, sa poi risollevarsi” (p. 328). Non è forse questa la tattica di un qualunque militare assennato? È ben strana questa perspicacia da parte di un leader che non aveva neppure fatto il servizio militare e che parlava del proletariato come se avesse fatto il mestiere dell'operaio. D'altra parte chi mai tra gli intellettuali di partito aveva fatto l'operaio o il contadino o il militare? Anche se non erano capitalisti o possidenti agrari, appartenevano comunque alla piccola borghesia, non perché svolgessero un mestiere artigianale o commerciale, ma semplicemente perché erano intellettuali che vivevano sulle spalle degli operai (i tesserati del partito e del sindacato) o perché ricevevano diritti d'autore sulle loro pubblicazioni, o perché erano mantenuti dai loro parenti o genitori.
In che cosa Lenin si distingueva dagli altri compagni? Che cosa lo autorizzava a dire – lui che era un figlio della piccola borghesia – che i suoi compagni di partito non ragionavano come autentici proletari? Che cosa rendeva “proletario” il suo modo di fare politica? i suoi ragionamenti tattici e strategici? Quando si riferisce a questi ultrasinistri moscoviti gli viene in mente “la mancanza di carattere del piccolo borghese” (p. 328). Tuttavia, siccome non li vuole offendere, essendo un fine pedagogista, attribuisce questa mancanza di carattere ai “socialisti rivoluzionari di sinistra”, anch'essi fermamente ostili alla pace di Brest-Litovsk. I quali, secondo lui, avevano “battuto il primato della frase sulla guerra rivoluzionaria” (ib.). Con la parola “frase” egli intendeva sempre l'ampollosità stucchevole delle frasi roboanti, che nella concretezza non vogliono dire nulla, poiché, non avendo il polso della situazione, non sanno cogliere il senso della realtà.
Quei compagni non riuscivano a capire che se anche i tedeschi avessero occupato una parte dei territori russi, prima o poi ne sarebbero stati cacciati, in quanto qualunque “invasione straniera non avrebbe fatto altro che rafforzare le simpatie del popolo per il potere dei soviet” (p. 329). Sarebbe bastato soltanto aspettare il momento più favorevole per passare alla controffensiva. “Il rifiuto di firmare la più obbrobriosa delle paci quando non si ha un esercito, è un'avventura...” (ib.), è l'estremismo come malattia infantile del comunismo. I trattati vergognosi temprano il popolo, insegnano “la scienza dura e difficile di preparare un esercito serio anche in condizioni disperatamente difficili...” (ib.).
La cosa strana è che i compagni di partito avevano già vissuto condizioni molto dure (carcere, esilio...): non erano alle prime armi, non erano degli sprovveduti e conoscevano Lenin da almeno 15 anni. Che cosa li spingeva a non riconoscerlo come loro punto di riferimento privilegiato? Possibile che in Russia l'individualismo fosse così esasperato? Se erano così individualisti da dove veniva fuori ai bolscevichi l'idea di affermare un “collettivismo produttivo”? Forse dall'esperienza della comune agricola?
Nell'articolo successivo Lenin scrive che “il predone tedesco schiaccia e soffoca e dilania la Russia con una rabbia tanto maggiore quanto più minaccioso gli si erge dinanzi lo spettro della rivoluzione operaia nel suo stesso paese” (p. 331). Lenin ci contava su questa rivoluzione. Era convinto che i prussiani, visto ch'erano riusciti a liberarsi di Napoleone, non avrebbero avuto grandi difficoltà a liberarsi del kaiser, che appariva molto più debole, non essendo riuscito a vincere la guerra in tempi brevi, come i suoi generali avevano preventivato.
Lenin aveva stima dei tedeschi. Anche se non aveva ricevuto alcun aiuto per compiere la rivoluzione (se non il permesso di tornare a Pietrogrado usando un loro treno), contava, una volta conquistato il potere, di imitarli in alcune loro caratteristiche fondamentali, che li avevano resi potenti in poco tempo: “la disciplina, l'organizzazione e la collaborazione armonica sulla base dell'industria moderna meccanizzata, dell'inventario e del controllo più rigoroso” (p. 334). “Proprio quello che a noi manca”, diceva (p. 335). Forse stava esagerando, forse stava dicendo queste cose per timore che gli ultrasinistri moscoviti potessero allargare il loro consenso.
Se la rivoluzione fosse avvenuta in Germania, il trattato di pace sarebbe stato immediatamente annullato. Lenin aveva “ceduto spazio per guadagnare tempo” (p. 333) contro la reazione dei capitalisti e degli agrari del proprio paese, e per curare le ferite di un esercito disgregato e demoralizzato. Ecco perché andava considerata “puerilmente ingenua l'idea secondo cui in qualsiasi condizione una pace durissima è un abisso di perdizione e la guerra è la via dell'onore e della salvezza” (ib.).
1Scrive Lenin nell'agosto 1918: “Tutta la borghesia, tutti gli ex Romanov, tutti i capitalisti e i grandi proprietari fondiari..., non riuscendo a trovare un sostegno in Russia, l'hanno trovato nei cecoslovacchi” (p. 354). E nel febbraio 1920: “Il governo capitalistico francese incita la Polonia (e probabilmente anche la Romania) ad attaccarci” (p. 356). Questi sono solo alcuni piccoli esempi di un intervento straniero che durò circa un biennio.
2Sotto lo stalinismo non verrà mai permesso a nessuno di criticare le direttive del CC, tant'è che la prima generazione di dirigenti politici e militari che aveva compiuto la rivoluzione verrà quasi completamente sterminata.
3Unico partito a far causa comune coi bolscevichi per compiere la rivoluzione, i socialisti-rivoluzionari di sinistra si erano staccati dai socialisti-rivoluzionari nel 1917, non appoggiando il governo provvisorio di Kerenskij. Guidati da Mark Natanson e Maria Spiridonova, ritenevano che la Russia avrebbe dovuto ritirarsi immediatamente dal conflitto, ed erano delusi dal fatto che il governo provvisorio intendeva rinviare la questione dell'assegnazione delle terre dopo la convocazione dell'Assemblea Costituente, anziché confiscare immediatamente i latifondi ai grandi proprietari per redistribuirli ai piccoli contadini. Il partito collassò definitivamente nel 1922. La Spiridonova ebbe un ruolo significativo nella gestione della politica agraria bolscevica nei primi anni della rivoluzione. Fu giustiziata nel 1941 sotto il terrore staliniano e riabilitata nel 1992.
4Attenzione che qui “aiutare” non vuol dire “provocare” o “stimolare”. L'aiuto presuppone che la rivoluzione sia stata già avviata a livello nazionale.
5Curiosamente anche Rosa Luxemburg sosteneva la stessa posizione dei moscoviti. Di qui il suo netto rifiuto per la pace di Brest-Litovsk.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube