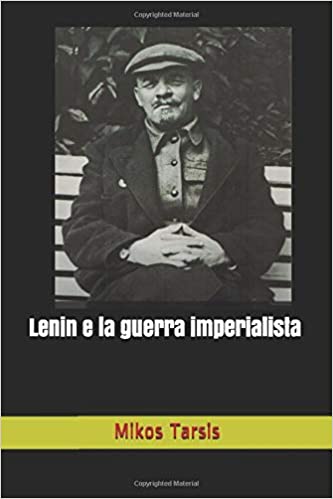
LENIN E LA GUERRA IMPERIALISTICA
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
Il socialismo in Europa
Agli inizi del Novecento, in tutta Europa, sia orientale che occidentale, le idee del socialismo avevano fatto presa su decine di milioni di persone. E con questa forza politica si poteva influire enormemente sulle politiche dei governi borghesi.1 Il motivo di questa enorme popolarità del socialismo dipendeva dal fatto che quello “scientifico” di Marx ed Engels si era dimostrato infinitamente più robusto, sul piano teorico, del socialismo utopistico, i cui esperimenti pratici, circoscritti nello spazio geografico, erano falliti miseramente. L'esperienza politica più significativa del socialismo utopistico, che in quell'occasione assomigliò a un tentativo insurrezionale del socialismo marxista, fu la Comune di Parigi, tenuta da Lenin sempre in grande considerazione nel momento in cui il suo partito andrà al potere, soprattutto per non ripeterne gli errori.
La superiorità ideologica del marxismo veniva avvertita con preoccupazione dai governi borghesi, anche se dai tempi della Comune sino al 1914 il capitalismo europeo aveva vissuto un periodo di sviluppo relativamente tranquillo. Tutte le tensioni causate dal rapporto squilibrato tra capitale e lavoro venivano scaricate all'esterno, nelle conquiste coloniali.
La sua involuzione riformistica
Pur di essere riconosciuto come erede naturale del capitalismo, il socialismo euroccidentale aveva ridimensionato di molto le proprie pretese rivoluzionarie, a tutto vantaggio di una scelta politica di tipo riformistico, cioè sindacale, cooperativistica e parlamentare. Alcuni dirigenti (p. es. in Francia e in Belgio) non solo avevano appoggiato la politica imperialistica dei loro rispetti governi borghesi; ma avevano addirittura accettato di partecipare alla gestione ministeriale di tali governi.
Nell'articolo Una pacifica manifestazione degli operai inglesi e tedeschi, scritto a Ginevra alla fine del 1908, Lenin si lamenta che la stampa socialista non esprime adeguatamente “la volontà della classe operaia”. Infatti era impegnato alla pubblicazione illegale dell'organo centrale, “Proletarij”, del suo partito, la cui redazione era composta, oltre che da lui, da Kamenev. Zinov'ev, Bogdanov e Innokenty (Dubrovinsky), benché i rapporti con Bogdanov fossero già tesi a causa delle posizioni filosofiche di quest'ultimo. Plaude però al fatto che una delegazione degli operai inglesi si sia incontrata a Berlino con una degli operai tedeschi. Insieme, in una gigantesca assemblea di 5.000 persone, hanno dichiarato che “la soluzione del problema della guerra e della pace è nelle mani della classe operaia”, i cui iscritti ai sindacati dei due paesi ammontano a 4,3 milioni. Le direttive da seguire sono quelle del Congresso di Stoccarda (1907).
A tale Congresso Rosa Luxemburg, Lenin e altri delegati russi presentarono alcuni emendamenti alla risoluzione di F. A. Bebel, con cui si era già in grado di mettere in evidenza la tendenza opportunistica della gran parte dei partiti socialisti della II Internazionale. Infatti si sottolineava che la “socialdemocrazia” (questa la denominazione prevalente del socialismo di allora) ha il compito di lottare non solo contro lo scoppio delle guerre o per la più rapida cessazione di quelle già iniziate, ma anche di utilizzare la crisi creata dalla guerra al fine di affrettare la caduta della borghesia. Cioè il compito non era solo quello parlamentare di svolgere una politica di opposizione ai governi liberali, ma anche quello di organizzare al di fuori del parlamento dei metodi di azione eversiva per abbattere i governi in carica. Difficile non vedere in questa richiesta lo “zampino” di Lenin, ch'era maestro nell'approfittare delle debolezze del nemico.
Gli altri due emendamenti riguardavano i giovani e il militarismo: i primi andavano convinti a non prendere le armi contro il proletariato di altre nazioni, o comunque a rifiutarsi di opprimere i lavoratori in lotta nei loro rispettivi paesi (questo emendamento venne accettato solo in una formulazione piuttosto generica, che non avrebbe impensierito alcun governo borghese); il secondo andava considerato non come un aspetto secondario o eccezionale dell'oppressione di classe, ma, in quel momento, come lo strumento principale. Cosa che, in effetti, poteva essere dimostrata abbondantemente dalla pratica imperialistica.
Con questi emendamenti si poteva avere l'impressione che Lenin fosse un estremista. Invece nei suoi articoli risulta ch'egli criticava l'atteggiamento di Gustave Hervé, che chiedeva di rispondere a qualsiasi guerra con lo sciopero e l'insurrezione, senza capire che “l'impiego di questo o quel mezzo di lotta dipende non da una preliminare decisione dei rivoluzionari, bensì dalle condizioni oggettive della crisi, sia economica che politica, che la guerra porterà con sé” (p. 13). Ecco un esempio di grande realismo politico, con cui però non ci si voleva certo porre al servizio di quello che lui chiamava “cretinismo parlamentare”.
In altre parole Hervé sosteneva che il proletariato, siccome non ha patria, a qualsiasi dichiarazione di guerra deve replicare con la diserzione in massa, se già arruolato, e con lo sciopero dei riservisti, i quali, unendosi con gli operai, dovrebbero scatenare l'insurrezione. Lenin definisce questa posizione con l'espressione “verbalismo anarchico”. Secondo lui, infatti, se passassero queste idee, il proletariato si opporrebbe di più alla guerra che al capitalismo, cioè si comporterebbe in maniera istintiva a qualcosa di spregevole, quando invece occorre organizzare una rivoluzione in grado di abbattere il sistema.
Non si tratta soltanto d'impedire una guerra. Non si può rischiare che sia la stessa borghesia a convincere il proletariato a insorgere sulla base di idee sciovinistiche. Siamo sul filo del rasoio in questa esegesi del socialismo in tempo di guerra (o nell'imminenza dello scoppio di un conflitto). Sembra qui di leggere una profezia relativamente alla nascita del fascismo e del nazismo, che ambivano a porsi in maniera “rivoluzionaria”, al fine di opporsi all'imperialismo anglo-francese. Dunque, ecco perché il proletariato deve decidere da solo quando e come insorgere: non può sentirsi obbligato a farlo immediatamente dopo una “qualunque” dichiarazione di guerra, solo perché la guerra è in sé qualcosa di ripugnante. Su questo le posizioni di Lenin e Kautsky coincidevano.
A proposito del suddetto militarismo e della gioventù che viene chiamata sotto le armi, Lenin era abbastanza preoccupato. Così scrive: “l'esercito non sia più un cieco strumento nelle mani delle classi dirigenti, di cui esse dispongono a proprio arbitrio e che possono ad ogni istante scatenare contro il popolo” (p. 16). Come fare ad affrontare un argomento del genere? Il socialismo riformista europeo non ne ha mai voluto sapere. Si dava per scontato che il soggetto militare fosse, per sua natura, impermeabile alle idee del socialismo. Ancora Lenin non sta parlando del “popolo in armi” come requisito fondamentale per compiere la rivoluzione. Si sta semplicemente limitando a dire che se “è eccezionalmente difficile, e talvolta addirittura impossibile, svolgere il lavoro di propaganda tra i soldati che si trovano in servizio effettivo” [e qui vi è l'elenco delle motivazioni], tuttavia si possono ottenere “ottimi risultati” nei confronti dei “giovani in età di leva, che vivono ancora nell'ambito della famiglia e degli amici cui sono strettamente legati da interessi comuni” (pp. 16-17).
Le unioni della gioventù operaia socialista vanno educate alle idee del socialismo e dell'antimilitarismo ben prima che scoppino le guerre.2 Lenin lo spiegherà un milione di volte che senza la propaganda socialista nell'ambito delle forze armate è impossibile fare alcunché di eversivo a favore del popolo. Occorre soprattutto mettere il soldato contro l'ufficiale (quest'ultimo, in genere, proveniva da ambienti borghesi, se non addirittura aristocratici) e tenere saldamente unite tali unioni giovanili coi giovani che vanno al fronte. Non a caso in Germania – lo scrive in un articolo del 1908 – il governo, consapevole che la gioventù si può facilmente manipolare, aveva deciso di sciogliere tutte le organizzazioni giovanili e di impedire, a chi non avesse compiuto vent'anni, di partecipare a riunioni politiche.
Che cosa vuol dire una politica opportunistica?
Nell'ottobre 1908 Lenin partecipa, e lo riassume, all'incontro dell'Ufficio socialista internazionale (organo esecutivo della II Internazionale), avvenuto a Bruxelles. Qui, a maggioranza, si accetta l'ingresso del partito laburista inglese nell'Internazionale, in quanto, pur non riconoscendo in modo chiaro la lotta di classe, esso rappresentava politicamente le Trade-Unions.
Anche Lenin è favorevole, ma vorrebbe aggiungere un emendamento alla risoluzione di Kautsky, in cui venga detto che l'ammissione dei laburisti è vincolata alla loro volontà di diventare un vero partito operaio socialista. Kautsky vi si oppone, col pretesto che non si potevano prendere decisioni in base alle aspettative. È il primo screzio tra i due. Non dimentichiamo che per Lenin i due socialisti più autorevoli in Europa, almeno sino allo scoppio della guerra, erano Kautsky e Plechanov.
Stranamente l'Ufficio non aveva approvato la proclamazione dell'indipendenza della Bulgaria, né la proposta inglese di convocare regolarmente lo stesso Ufficio almeno due volte all'anno. Venne invece rifiutata, giustamente, la richiesta di aderire all'Internazionale da parte dei socialisti sionisti della Russia, in quanto avevano una posizione nettamente “territorialistica”, cioè sarebbero stati disposti a realizzare il socialismo in una specifica area geografica, che loro stessi poi avrebbero amministrato. Inoltre, e in maniera piuttosto incredibile, vi erano posizioni (olandese, belga e tedesca) favorevoli alla colonizzazione oltreoceanica da parte dei loro rispettivi paesi; tuttavia erano state messe in minoranza, sulla base della motivazione che il capitalismo va combattuto anche nelle colonie.
Lenin si era accorto da un pezzo di questa tattica opportunistica nelle file della II Internazionale (non è vero che Rosa Luxemburg l'aveva denunciata prima di lui).3 Solo che, di fronte a una maggioranza così schiacciante di opportunisti, si sentiva isolato, anche perché era costretto a vivere in esilio. Non era facile rinunciare a un'organizzazione così potente e ramificata, in grado d'influenzare i governi borghesi con le proprie rivendicazioni, anche parziali. Senza l'appoggio dei socialisti la guerra, probabilmente, sarebbe stata impossibile o non sarebbe stata “mondiale” o sarebbe finita prima.
È sufficiente qui ricordare che i menscevichi e i socialisti-rivoluzionari ebbero un gran peso in Russia, di molto superiore a quello dei bolscevichi. La rivoluzione del 1905 fu opera loro; in parlamento ebbero sempre la maggioranza sui bolscevichi e anche nei soviet e nella Costituente. Eppure non fecero nulla per impedire la guerra. Il loro improvviso crollo si ebbe quando, con Kerenskij al governo, appoggiarono esplicitamente la controrivoluzione. L'inizio della crisi irreversibile di questi partiti fu determinato dal fatto che Kerenskij non ebbe mai alcuna intenzione di por fine alla guerra, né di distribuire la terra ai contadini. Lenin approfittò di queste gravi manchevolezze e riuscì a prevalere con relativa facilità.
Dunque che cosa vuol dire una “politica opportunistica”? “L'opportunismo esprime la politica borghese nel movimento operaio, esprime gli interessi della piccola borghesia e l'unione di un'infima parte di operai imborghesiti con la 'propria' borghesia...” (p. 146). “L'opportunismo trasforma l'utilizzazione della legalità borghese in un atteggiamento servile dinanzi ad essa, creando un piccolo strato di burocrazia e di aristocrazia della classe operaia, attirando nelle file dei partiti socialdemocratici molti 'compagni di strada' piccolo-borghesi” (p. 147). L'aristocraticismo operaio consiste in una situazione privilegiata, conseguente al fatto che talune categorie di lavoratori (p. es. i chimici, i metalmeccanici) possono beneficiare di più alti salari grazie allo sfruttamento delle colonie. Così scrive Lenin. E poi ancora: “prima della guerra l'opportunismo era considerato, non di rado, una 'deviazione', un''ala estrema', ma pur sempre una parte integrante, legittima del partito socialdemocratico” (p. 148).
Strano però ch'egli parli di “un'infima parte di operai imborghesiti” quando, di fatto, l'opportunismo era la tattica politica assolutamente prevalente nell'ambito del socialismo europeo. Quando si afferma soltanto per l'obiettivo finale la necessità di una svolta rivoluzionaria, ma nella tattica ci si comporta in maniera “riformistica”, il riformismo è a 360 gradi. Strano che Lenin non veda come cosa assolutamente normale che l'abitudine al rispetto della legalità conduca inevitabilmente all'opportunismo. In queste condizioni l'opportunismo non è una scelta o un tradimento, ma una logica conseguenza della politica parlamentare.
È vero, Lenin dirà, durante le fasi della guerra, che i partiti socialisti dovevano svolgere un'attività illegale, se volevano organizzare una rivoluzione. Ma avrebbe anche dovuto aggiungere che i leader di un movimento rivoluzionario non dovrebbero mai accedere in un parlamento borghese. Cioè essi dovrebbero far vedere che in qualunque momento, con la loro attività extraparlamentare, sarebbero in grado di rovesciare il governo. Un leader dovrebbe starsene fuori, proprio per sentirsi più libero di agire come e quando meglio crede. In parlamento ci può andare una sparuta rappresentanza, a turno, che riferisce al partito gli interventi dei deputati e che riporta in parlamento alcune decisioni prese dal partito.
Un partito rivoluzionario deve essere esigente nei confronti dei propri militanti; deve saperli selezionare, addestrare, mettere alla prova. Non può essere un “grande” partito sul piano numerico; è sufficiente che sia “esperto” nella propaganda, nell'agitazione, nel coinvolgimento emotivo delle masse popolari, basato sulla chiarezza delle motivazioni di principio, che si riferiscono a condizioni reali della vita, quelle condizioni che servono per giudicare di inadempienza, di incoerenza il governo in carica.
Le masse devono poter capire qual è il momento giusto per ribellarsi. Un partito rivoluzionario non può mandarle allo sbaraglio, non può aspettare che siano loro a fare il primo passo. Un partito di professionisti della politica eversiva deve anzitutto dare l'esempio su come ci si deve comportare quando la situazione generale di un paese ha raggiunto un livello di criticità assolutamente insopportabile. Dopodiché, quando è venuto il momento di agire, le masse vanno armate, perché lo scontro, durissimo, sarà con le forze dell'ordine costituito, le quali, per quanto numericamente inferiori al popolo, sono sempre ben armate e ben addestrate. Ecco perché Lenin diceva sempre che la propaganda a favore del socialismo andava fatta anche nelle file degli eserciti, rivolgendosi ai soldati semplici, più che agli ufficiali.
Quando la situazione sociale a livello nazionale è notevolmente critica e la preparazione dell'insurrezione è sufficientemente pronta, ci si deve dirigere nella capitale dello Stato, cioè là dove lo Stato emana gli ordini alle proprie periferie. Poiché il consenso va cercato tra gli elementi marginali, oppressi, diseredati di tutta la nazione, la propaganda rivoluzionaria può anche partire dalle periferie e dirigersi verso il centro. Ma l'attacco decisivo va sferrato nella capitale, proprio per dimostrare all'intero paese che è giunto il momento di reagire e di prepararsi a difendere l'ideale rivoluzionario contro chi, da quel momento in poi, vorrà sabotarlo. L'attacco al sistema può essere compiuto da un certo numero di persone armate (che non devono certamente aspettare di avere la “maggioranza” in parlamento); ma la difesa del nuovo governo che si vuole realizzare, deve essere fatta da un numero enorme di persone, sparse sia nelle città che nelle periferie.
Poiché l'idea fondamentale è quella di espropriare tutti coloro che possiedono mezzi di produzione e proprietà private che servono a garantire la sopravvivenza dell'intera popolazione, è bene aspettarsi, da parte di questi privilegiati, una reazione durissima, spietata, che non si farà scrupolo a compiere qualunque crimine, né a chiedere l'intervento di potenze straniere. Se queste forze vinceranno, non ci sarà alcuna pietà, alcuna amnistia nei confronti degli insorti. Le carneficine nei confronti dei rivoltosi sconfitti sono un classico nella storia del genere umano.
Queste cose possiamo dirle grazie allo stesso Lenin. Quello che non si capisce è il motivo per cui ci abbia messo così tanto tempo a dirle in seno all'Internazionale. Le idee apertamente revisioniste, in Germania, furono elaborate da Bernstein solo una decina d'anni dopo che si era costituita la II Internazionale, dietro la spinta delle correnti opportunistiche. Bernstein non fu mai espulso dal partito socialista tedesco. Già nel 1907, al Congresso di Stoccarda, Lenin era costretto ad ammettere che l'ala opportunistica dei partiti socialdemocratici era nettamente favorevole alla politica imperialistica dei governi borghesi.
La guerra non fece altro che accelerare il passaggio dall'opportunismo al socialsciovinismo (socialismo in teoria e nazionalismo nei fatti). Tutti accettarono lo stato d'assedio proclamato dalle autorità militari. Un atteggiamento del genere non andava considerato “incredibile” ma del tutto “naturale”, dopo oltre 40 anni di politica riformistica. La guerra aveva soltanto reso evidente ciò che da tempo era implicito. Nessun partito socialista, dopo aver appoggiato l'imperialismo del proprio Stato per un tempo così lungo, avrebbe mai potuto opporsi a una guerra condotta per motivi imperialistici. I quali motivi, per quanto camuffati da idee relative alla difesa della patria, sono sempre stati due: o conquistare nuove colonie o conservare a tutti i costi quelle che già si possiedono. Gli Stati capitalisti non hanno mai fatto delle guerre per “liberare” le colonie, se non per sostituirsi agli Stati che le opprimevono (come fecero per es. gli Stati Uniti nelle Filippine in mano spagnola). Chiodo scaccia chiodo.
L'opportunismo di quella parte di classe operaia europea che beneficiava di salari più alti grazie allo sfruttamento coloniale, avrebbe dovuto essere considerato assolutamente indegno; invece mai nessuno vi si oppose. Anzi, quei privilegi, inizialmente riservati a una certa categoria di lavoratori specializzati, finirono con l'estendersi a tutte le categorie, poiché lo sfruttamento imperialistico delle colonie aveva ricadute economiche sull'intera madrepatria occidentale, seppure in forme e gradi diversificati.
Non ha senso parlare di “gruppo piccolissimo di operai privilegiati”, anche perché lo stesso Lenin è sempre stato convinto che gli operai, in genere, tendono alla mera lotta sindacale, a prescindere dal fatto che siano divisi in gruppi privilegiati e gruppi ordinari. La convinzione che si può fare una rivoluzione che ribalti il sistema a favore del socialismo, va data all'operaio dall'esterno, veniva detto in Che fare?. Non solo, ma perché l'operaio arrivi a impegnarsi sino in fondo nella preparazione della rivoluzione, occorre che esca dalla fabbrica e si metta a disposizione del partito a tempo pieno.
Prendiamo, a titolo esemplificativo, le risoluzioni approvate alla Conferenza socialista internazionale di Zimmerwald in Svizzera, del 5-8 settembre 1915 (11 paesi europei erano rappresentati). Lenin era presente. Dall'inizio della guerra era già passato un anno. Eppure, pur avendo approvato un manifesto contro i governi imperialisti, si condannarono in modo abbastanza mite gli opportunisti e i socialsciovinisti. Lenin lo dice chiaramente: il manifesto “pecca d'inconseguenza e di reticenza” (p. 170); “non si parla francamente, apertamente, risolutamente dei mezzi rivoluzionari di lotta” (p. 173), così come si fece nel 1848 e nel 1905. Né viene detto qualcosa sul fatto che la guerra ha posto le basi per una insurrezione nazionale; né sul fatto che la vera disgrazia per il socialismo è stato l'appoggio che gli opportunisti hanno dato alle menzogne dei capitalisti; né, tanto meno, sulla necessità di trasformare la guerra imperialistica in guerra civile. A Zimmerwald non capirono che l'Internazionale era fallita e che doveva essere sostituita da un'altra organizzazione. L'opportunismo aveva fatto bancarotta nel mondo intero, ai suoi massimi livelli rappresentativi e istituzionali.
Fu in quella occasione che gli elementi della minoranza dell'Internazionale protestarono contro le risoluzioni ufficiali dei loro rispettivi partiti. Lenin stesso e altri delegati4 scrissero un opuscolo da aggiungere alla risoluzione del suddetto Congresso, dal titolo Il socialismo e la guerra, giudicato male sia dai socialisti tedeschi che da quelli italiani. I primi sostenevano che parlare di guerra civile, di fraternizzazione nelle trincee, di scioperi politici durante la guerra o anche solo di dimostrazioni di protesta erano semplici “ragazzate”, “fuochi di paglia”. I secondi erano del tutto contrari all'uso della violenza. A loro rispose Lenin: “nessun capo influente della II Internazionale ha mai negato l'uso della violenza e, in generale, di metodi di lotta direttamente rivoluzionari. Tutti hanno sempre affermato che la lotta legale, il parlamentarismo e l'insurrezione sono connessi e devono inevitabilmente trasformarsi l'uno nell'altra, secondo il mutare delle condizioni del movimento” (p. 179).
Gli italiani, in sostanza, qualificati spesso da Lenin come “socialisti latini” (al pari dei francesi), incapaci di vera teoria politica, non riuscivano a capire che per compiere una rivoluzione occorreva prepararla a tempo debito con una grande propaganda. Per quella del 1905, in Russia, si partì dalla fine del 1900. Gli italiani pensavano che le rivoluzioni scoppiassero da sole, quando l'esasperazione delle masse raggiungeva livelli insopportabili. Erano influenzati da posizioni anarco-sindacaliste.
A p. 202, a proposito della violenza, Lenin aggiunge: “ogni guerra sostituisce al diritto la violenza aperta e immediata”, benché siano esistite delle guerre democratiche e rivoluzionarie che hanno “giovato, per il loro contenuto sociale e per le loro conseguenze, alla causa della democrazia e, quindi, del socialismo”.
D'altra parte “la guerra è la continuazione della politica. Bisogna studiare la politica che precede la guerra” (p. 212), se non si vuole essere astratti, generici, cioè se si vuole capire quando una guerra è giusta o ingiusta, democratica o imperialistica, di liberazione nazionale o di asservimento di territori altrui. Non è importante sapere chi attacca per primo, ma “per quale motivo si combatte, con quali classi e per quale fine politico” (ib.).
“La guerra civile contro la borghesia – scrive ancora – è una guerra organizzata e condotta democraticamente dalle masse povere contro una minoranza di possidenti... La violenza esercitata in nome degli interessi e dei diritti della maggioranza della popolazione... conculca i 'diritti' degli sfruttatori, della borghesia, e non può essere realizzata senza l'organizzazione democratica dell'esercito e delle 'retrovie'. La guerra civile espropria con la forza, di colpo e prima di tutto, le banche, le fabbriche, le ferrovie, le grandi aziende agricole, ecc. Lo scopo della guerra civile è... l'annientamento di qualsiasi possibilità di resistenza della borghesia, l'eliminazione del suo esercito. Ma proprio per realizzare tutte queste espropriazioni bisogna far eleggere tutti i funzionari e gli ufficiali da parte del popolo, bisogna attuare la completa fusione dell'esercito... con la massa della popolazione, bisogna introdurre una democrazia integrale nella gestione delle risorse alimentari, nella loro produzione e distribuzione, ecc.” (p. 206).
E poi ancora, a testimonianza che Lenin (siamo nel settembre 1916) aveva le idee molto chiare su come condurre una guerra civile, a differenza di tutti gli altri leader dell'Internazionale: “La guerra attuale unisce e 'fonde' i popoli in coalizioni per mezzo della violenza e della dipendenza finanziaria. Nella nostra guerra civile contro la borghesia uniremo e fonderemo i popoli... col libero consenso, con la solidarietà dei lavoratori contro gli sfruttatori. La proclamazione della parità di diritti per tutte le nazioni è uno strumento d'inganno nelle mani della borghesia; per noi sarà invece una verità che faciliterà e accelererà il passaggio di tutte le nazioni dalla nostra parte. Senza un'organizzazione realmente democratica dei rapporti tra le nazioni – e quindi senza la libertà di costituire uno Stato separato –, la guerra civile degli operai e delle masse lavoratrici di tutte le nazioni contro la borghesia non può essere combattuta” (p. 207).
Con frasi del genere siamo sul filo del rasoio. L'obiezione principale che si può muovere è infatti la seguente: la democrazia è data solo dal fatto che viene espressa la volontà di una grande maggioranza? È fuor di dubbio che la minoranza deve adeguarsi alla volontà della maggioranza, ma è anche vero che la maggioranza deve saper porre le condizioni che permetta l'inversione dei ruoli. Non è possibile sostenere che la maggioranza, solo perché tale, non possa mai diventare minoranza o debba per forza aver sempre ragione.
Il socialismo deve impedire lo sfruttamento del lavoro altrui, cioè il lavoro salariato, poiché questo è una forma di prostituzione; deve anche disarmare chi vorrebbe imporre lo sfruttamento con la violenza, ma nella costruzione della democrazia reale non può impedire il libero confronto delle opinioni, la libertà di coscienza, di parola, di associazione... La democrazia, nell'ambito del socialismo, deve potersi giustificare da sola, non perché esiste una “maggioranza”. La verità delle cose non sta sempre, necessariamente, nella maggioranza delle persone. Lo stesso partito di Lenin, all'interno della II Internazionale, non fu mai un partito che poteva esercitare una volontà condivisa da una maggioranza.
Resta indiscutibile che una guerra civile, condotta da una larga maggioranza di nullatenenti, contro un'esigua minoranza di possidenti, difficilmente potrebbe non essere democratica. Tuttavia il fatto che una guerra civile si giustifichi per il suo fine democratico, non implica ch'essa debba essere condotta senza rispettare alcuna forma di democrazia. Il fine non può essere contraddetto dai mezzi, altrimenti non vi sarà alcuna garanzia della sua riuscita. Il che non vuol dire che alla violenza degli oppressori gli oppressi non debbano rispondere con pari violenza. Vuol semplicemente dire che l'uso della violenza non può essere indiscriminato, non può essere sproporzionato rispetto al danno ricevuto o all'effettivo pericolo che si deve affrontare.
Compito del socialismo non è eliminare “fisicamente” il nemico (come fecero lo stalinismo, il maoismo, ecc.), ma metterlo in condizioni di non nuocere. E la prima cosa che bisogna fare è disarmarlo. Il disarmo generale, oltre alla confisca della proprietà privata dei principali mezzi produttivi, costituisce una garanzia sufficiente per rendere inutile l'eliminazione fisica dell'avversario. Il socialismo ha il compito di rieducare tutti i cittadini al valore della democrazia, quella vera, che è molto diversa da quella formale della borghesia.
Certo è che quando Lenin parla di “completa fusione” dell'esercito con la popolazione sta ponendo le basi per il disarmo generale. In assenza di proprietà privata, non ha più senso che tutti siano armati. Se non c'è più nessuno da reprimere a livello patrimoniale, tutti dovrebbero andare in giro disarmati: ciò non diminuisce, ma aumenta la sicurezza personale.
Diciamo che la vera democrazia, nell'ambito del socialismo, si realizza non solo quando la borghesia viene espropriata della proprietà privata dei mezzi produttivi che servono alla sopravvivenza della collettività; non solo quando le vengono tolti i mezzi con cui può pagare eserciti mercenari al suo servizio, ma anche e soprattutto quando si procede con la “democrazia integrale” nella gestione diretta, dal basso, della produzione e distribuzione di tutte le risorse. Qui si sta parlando di mezzi produttivi “fondamentali”, non tanto di quell'ettaro di terra a uso personale (per il proprio orto), e neppure di quel lotto agricolo che permette di sopravvivere a una famiglia rurale. Non è in questione la cooperativa di produzione o di consumo tra soci paritetici, in cui tutti fanno tutto (o quasi), o in cui nessuno può essere costretto a fare ciò che non vorrebbe (in quanto nessuno, pur essendo nullatenente, può essere sottoposto a un lavoro salariato). Non ci si riferisce neppure a quei lavori artigianali condotti a livello familiare o individuale, domestico, o tra soci di un laboratorio, di un'officina..., in cui il lavoro o il reddito è equamente ripartito, o comunque il reddito è unicamente fornito dal proprio lavoro.
Qui si sta parlando di grandi aziende produttive, di notevoli proprietà agricole, di enormi disponibilità finanziarie a disposizione di banche e capitalisti privati, di indebite appropriazioni di beni del demanio pubblico (come le miniere, le foreste, i boschi, le spiagge, i laghi, le risorse energetiche, le fonti del sottosuolo, ecc.). Tutte queste risorse vanno gestite autonomamente dall'intera popolazione. E qui si potrebbe aggiungere, visto che il socialismo scientifico parla di “estinzione dello Stato”, che per “popolazione” si deve intendere anzitutto e soprattutto quella locale o municipale, quella suddivisa in comunità territoriali, in enti locali territoriali.
Bisogna mettere i cittadini nelle condizioni di sentirsi pienamente, direttamente, collettivamente e individualmente responsabili di una determinata porzione di territorio. Solo a livello locale, nella gestione delle risorse territoriali, una comunità diventa davvero responsabile. Solo così la collettività è in grado di capire cosa significa rispettare le esigenze riproduttive della natura, al di fuori delle quali nessuna esistenza umana è possibile.
Ci vorrà comunque ancora un anno prima che qualcosa delle idee di Lenin venissero recepite in qualche Congresso socialista. Egli tuttavia avrebbe dovuto ammettere che quanto più si sviluppa il capitalismo, tanto meno forte diventa nelle aree metropolitane l'esigenza di abbatterlo. Non poteva ammetterlo semplicemente per due ragioni: aveva sempre giudicato positivamente il capitalismo contro il feudalesimo; riteneva che una “democrazia agraria” (quella per es. della comune agricola russa) non avrebbe avuto la forza sufficiente per opporsi alla diffusione del capitalismo industriale. La storia però s'incaricherà di dimostrare, paradossalmente proprio a partire dall'esperienza bolscevica, che dei tentativi rivoluzionari possono venir fuori solo dalle periferie di questo gigantesco “impero economico” che divide il mondo in borghesi e proletari, e solo a condizione che vi siano dei soggetti consapevolmente rivoluzionari, che rifiutano di emigrare verso le grandi città del capitalismo occidentale, quelle che possono garantire un minimo di reddito.
In una situazione del genere bisognerebbe chiedersi che tipo di socialismo sia possibile realizzare nelle periferie dell'impero capitalistico. Un socialismo industrializzato, che devasti l'ambiente? O un socialismo statalizzato, che elimini la libertà di pensiero? Un socialismo mercantile di tipo cinese, che di autenticamente “sociale” non ha quasi nulla? L'unica speranza di realizzare un socialismo davvero democratico è quella di agganciare le idee del socialismo alla pratica del comunismo primitivo, antecedente alla nascita dello schiavismo. Esiste oggi la possibilità di un tale aggancio? Esiste la possibilità d'impedire che un'istanza di liberazione sociale produca degli esperimenti fallimentari, dovuti al fatto che non è più possibile fare riferimento ad alcuna memoria storica concreta, antecedente alla formazione dell'antagonismo sociale?
Le eccezioni eversive del socialismo europeo
Il 4 novembre 1914 si chiude il processo contro cinque membri del gruppo operaio socialista russo (i deputati bolscevichi presenti nella Duma), più altri sei che avevano tenuto una conferenza contro la guerra in corso, scoppiata il 28 luglio con la dichiarazione di guerra dell'impero austro-ungarico al regno di Serbia. Privati dell'immunità parlamentare, i deputati erano stati processati per la loro attività antimilitarista. Su di loro pendeva la minaccia della pena di morte. Nel processo del febbraio 1915 fu deciso di deportarli a vita in Siberia.
In Europa occidentale il parlamentarismo non veniva usato in chiave rivoluzionaria. Quasi tutti i deputati socialisti erano sciovinisti, cioè nazionalisti. Viceversa, i suddetti deputati russi avevano abbandonato nell'ottobre 1913 il gruppo socialdemocratico perché non condividevano la politica opportunistica dei menscevichi, e avevano costituito nella Duma il gruppo autonomo del Partito Operaio Socialdemocratico Russo (bolscevico). L'organo di stampa di tale partito, il “Sotsial-Demokrat”, uscito con intervalli dal febbraio 1908 al gennaio 1917, era totalmente illegale (dal 1911 fu diretto da Lenin).
Bisogna ammettere che, di fronte al pericolo dell'opportunismo, Lenin non ha mai sostenuto il principio “L'unione fa la forza”. Non ha mai voluto sacrificare all'unità del partito la verità. Lenin non era uno scissionista di maniera, un estremista à tous prix. Sapeva sfruttare i momenti migliori per far capire ai leader socialisti riformisti ch'era giunto il momento o di cambiare atteggiamento o di dividersi. Lenin non si faceva porre condizioni dai riformisti, anche se non rifiutava i compromessi dignitosi. Se non avesse rotto i ponti con gli opportunisti durante la guerra, difficilmente sarebbe riuscito a compiere la rivoluzione. Infatti voleva approfittare delle sconfitte del suo governo, che sicuramente in quel momento era molto debole; e voleva servirsi del fatto che il popolo era armato e ben organizzato nei soviet.
Oggi dovremmo riprendere le idee del leninismo e svolgerle in maniera ancora più radicale. Infatti occorre tornare al comunismo primordiale, rinunciando a una tecnologia che su questo pianeta non fa che devastare l'ambiente, e opponendosi risolutamente a quelle entità esterne che condizionano pesantemente l'autonomia decisionale, come gli Stati e i mercati. Non è possibile scendere a trattative con chi è contrario alla socializzazione dei mezzi produttivi fondamentali, all'autoconsumo (si consuma ciò che si produce), al baratto delle eccedenze, alla democrazia diretta, all'uguaglianza di genere, alla tutela ambientale più rigorosa. Chi è contrario a questi princìpi, che rendono davvero democratica una qualunque società, andrebbe espulso dalla comunità o rieducato coattivamente.
1Non dimentichiamo che i due partiti che Lenin considerava maggiormente rivali al suo non erano quelli liberali o monarchici della grande borghesia, ma i menscevichi e i socialisti-rivoluzionari, entrambi ampiamente edotti circa le idee del socialismo.
2Ancora Lenin non fa alcun riferimento alla “gioventù contadina”, pur essendo questa largamente utilizzata nelle file degli eserciti degli Stati capitalisti, inclusa la Russia.
3Anche la Luxemburg deciderà di uscire dall'Internazionale, ma solo dopo la fine della guerra, quando ormai era troppo tardi per organizzare una rivoluzione comunista.
4La corrente bolscevica era ben presente non solo in Russia, ma anche in Polonia, Lettonia, Germania, Svezia, Norvegia, Svizzera e Olanda.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube