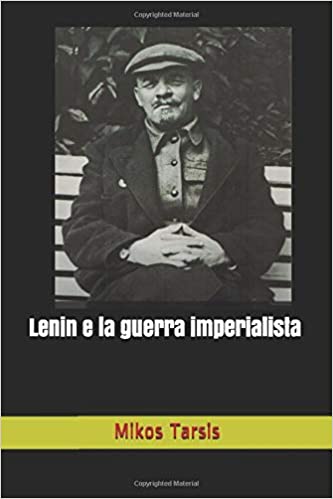
LENIN E LA GUERRA IMPERIALISTICA
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
Le cause della I guerra mondiale
Già al VII Congresso della II Internazionale, a Stoccarda, del 18-24 agosto 1907, si era capito che il capitalismo europeo si stava preparando a un conflitto di ampie proporzioni, a causa del fatto che la Germania, col proprio impetuoso sviluppo economico, ampiamente sostenuto dallo Stato, aveva superato, in alcuni settori produttivi strategici, le altre potenze europee, pur essendo giunta tardi all'unificazione nazionale e ad abbracciare il capitalismo industriale. La Prussia, politicamente monarchica e imperiale, non accettava più la ripartizione delle colonie decisa, già alla fine dell'Ottocento, dalle due massime potenze capitalistiche mondiali: Francia e Inghilterra.
Questo porterà a escludere che la I guerra mondiale sia stata causata da un evento fortuito: l'eccidio di Sarajevo, il quale fu solo una miccia che servì da pretesto. Nell'epoca dell'imperialismo le guerre sono inevitabili quando entrano in scena nuovi competitori o quando avvengono rivoluzioni comuniste o quando le colonie vogliono emanciparsi in maniera significativa o quando le risorse da cui dipende il benessere di una nazione cominciano a scarseggiare. Ovviamente non tutte le guerre sono “mondiali”.
Sotto questo aspetto, non fa alcuna differenza che uno Stato sia monarchico o repubblicano. Scrive Lenin contro chi considerava maggiormente responsabili del conflitto i paesi retti da una monarchia: “tra le repubbliche più democratiche e le monarchie più reazionarie non sussiste, dall'inizio della guerra, e non si scorge intorno a noi la benché minima differenza” (p. 202). Non per questo, tuttavia, si deve da ciò “dedurre la necessità di respingere la repubblica o assumere, quanto meno, un atteggiamento di disprezzo nei suoi confronti: non ci si deve far spaventare dalla guerra...” (p. 203). Se si permette alla guerra di “annientare la nostra capacità di pensare” non potremo neppure parlare – scriveva con acume Lenin – di “utilizzazione rivoluzionaria dell'esercito o della milizia”, visto che “il militarismo compie dappertutto i suoi mostruosi crimini” (ib.).
Bisogna ammettere che a quel tempo, caratterizzato da situazioni altamente drammatiche, era difficile incontrare una persona che sapesse ragionare in maniera così lucida. Lenin sapeva vedere di ogni cosa sempre due aspetti contrapposti. Anche quando dice delle frasi generiche o filosofiche, offre spunti di riflessione. Come p. es. questa: “La guerra – come, del resto, ogni crisi nella vita del singolo o nella storia dei popoli – abbatte e spezza alcuni, tempra e illumina altri” (p. 201). Si faccia ora attenzione all'uso di questo sillogismo politico, che deve portare a una conclusione evidente: “L'imperialismo è il capitalismo che ha raggiunto un alto grado di sviluppo; l'imperialismo è progressivo; l'imperialismo è la negazione della democrazia; e 'quindi' la democrazia è 'irrealizzabile' in regime capitalistico” (p. 203). Una cosa negativa diventa positiva, se si guarda il risultato finale, ma è anche vero il contrario. Se non è dialettico questo modo di ragionare, che cos'è? Qui siamo ai limiti del cinismo, eppure ne siamo lontanissimi, proprio perché Lenin vuole costruire un'alternativa globale all'intero sistema. E per dimostrare la necessità della transizione non si fa scrupolo a utilizzare qualunque argomentazione. Dire che “l'imperialismo è progressivo” può apparire assurdo (soprattutto alle colonie che lo subiscono), e tuttavia, a causa degli orrori che provoca, può indurre a credere che nel capitalismo la democrazia non sia possibile. Anche le persone più refrattarie o estranee al socialismo dovranno ammetterlo. Lo faranno in maniera spontanea? No, ma lo faranno se si farà capire loro che “l'unica via d'uscita” è il socialismo (p. 204). È l'imperialismo stesso, con le guerre che si porta dietro, che impedisce di “formulare parole d'ordine democratiche nel programma minimo” (ib.).
Di fronte a tragedie del genere, cui ci si è arrivati a causa di atteggiamenti profondamente sbagliati, l'alternativa dev'essere netta. “Il capitalismo in generale e l'imperialismo in particolare trasformano la democrazia in un'illusione; nello stesso tempo il capitalismo... inasprisce l'antagonismo fra l'imperialismo, che nega la democrazia, e le masse, che aspirano alla democrazia. Il capitalismo e l'imperialismo non possono essere rovesciati con le riforme democratiche, nemmeno con le più 'ideali', ma soltanto con la rivoluzione economica; e il proletariato, se non si viene educando nella lotta per la democrazia, è incapace di compiere questa rivoluzione” (ib.).
Lenin stava dicendo che il proletariato, cioè il lavoratore sfruttato, deve “convincersi da solo” che bisogna evitare qualunque illusione riformistica. “Non si può battere il capitalismo senza impadronirsi delle banche, senza abolire la proprietà privata dei mezzi di produzione, ma queste misure rivoluzionarie non possono essere attuate se non si organizza la gestione democratica, da parte di tutto il popolo, dei mezzi di produzione strappati alla borghesia...” (ib.).
*
Nell'articolo Una pacifica manifestazione degli operai inglesi e tedeschi, scritto alla fine del 1908, Lenin non ha dubbi nel ritenere che il conflitto maggiore sia tra inglesi e tedeschi. Infatti quest'ultimi pensano di poter approfittare del fatto che “il primato dell'Inghilterra e il suo incontrastato dominio sul mercato mondiale sono ormai cose del passato”. La Germania vuole più colonie, anche se sa benissimo di avere una potenza navale assai più debole di quella inglese. D'altra parte, per recuperare il tempo perduto sulla strada del capitalismo industriale, ha dovuto avviare un grande sfruttamento del lavoro, sicché la lotta di classe si è notevolmente inasprita e una guerra potrebbe servire come “arma di distrazione di massa”.
E comunque quando il militarismo è in fase crescente (e in quel momento lo era in tutta Europa), era facile supporre ch'esso rappresentasse l'anticamera di un conflitto di grandi proporzioni. Il socialismo riformistico, però, tendeva a sottovalutare tale pericolo, ritenendo che il militarismo servisse soltanto per acquisire colonie extraeuropee.
A riguardo del crescente militarismo Lenin si mostrava invece alquanto preoccupato, e non riusciva a capacitarsi del fatto che su un argomento del genere le esitazioni o i dissensi tra i socialisti europei fossero così evidenti. Anche perché vi erano già state, prima del Congresso di Stoccarda, in altri Congressi (Parigi 1889, Bruxelles 1891, Zurigo 1893, Chemnitz 1912), risoluzioni molto chiare in proposito. “Il militarismo moderno è un prodotto del capitalismo”; viene utilizzato dagli Stati capitalisti “nei loro conflitti esterni... e come arma di cui le classi dominanti si servono per reprimere ogni specie di movimento (economico e politico) del proletariato” (p. 21).
Esistevano risoluzioni esplicite, benché non applicate ad alcuna tattica antimilitaristica, constata amaramente Lenin, il quale afferma che ciò era del tutto contraddittorio al fatto che “si sono accumulate a sufficienza delle sostanze infiammabili, che aumentano sempre di più” (p. 20). Qui si riferisce alla rivoluzione in Persia, scoppiata nel 1905, con cui i contadini s'erano impadroniti delle grandi proprietà agrarie, obbligando lo shah a dimettersi nel 1909. Due anni dopo però la controrivoluzione monarchico-feudale delle truppe anglo-russe ebbe la meglio.1 Ma Lenin si riferisce anche al movimento rivoluzionario dei Giovani Turchi, che negli anni 1908-1909 depose il sultano e proclamò una monarchia costituzionale. In quel momento Lenin pensava, giustamente, che tali insurrezioni avrebbero tolto la possibilità ai “predoni capitalistici d'Europa” d'impadronirsi di quei territori.
Tratta così estesamente gli avvenimenti dei Balcani e della Persia (nell'ottobre 1908) che conviene riportare un suo brano: i paesi europei “temono il trionfo della rivoluzione in Turchia, perché questo successo significherebbe senza meno, da un lato, lo sviluppo delle aspirazioni all'autonomia e alla democrazia reale in tutti i paesi balcanici e, dall'altro lato, la vittoria della rivoluzione persiana, un nuovo impulso al movimento democratico in Asia, l'intensificazione della lotta per l'indipendenza in India...” (p. 35), sino alla possibilità di una nuova rivoluzione in Russia dopo quella del 1905.
Le potenze occidentali (Austria, Germania, Italia, Francia, Inghilterra) e la Russia esaltano la moderazione della rivoluzione dei Giovani Turchi, non avente un carattere “proletario” ma solo “borghese”. Tuttavia, nel contempo, si chiedono come ripartirsi la maggior parte dell'ex impero ottomano, la cui disgregazione era iniziata da quando i sultani dovettero riconoscere l'indipendenza della Grecia. Tali potenze avevano già deciso di attribuire la Bosnia e l'Erzegovina all'Austria (in funzione anti-serba e anti-russa); ora si trattava di stabilire come ripartirsi i Balcani e il Medioriente (che Lenin chiama sempre Asia Minore). La Turchia, nei loro piani, doveva essere ridotta a uno Stato del tutto insignificante. Anche la Russia zarista ambiva a occupare la vecchia Costantinopoli, per avere accesso agli stretti del Mar di Marmara; e qui Lenin osserva che sarebbe stato impossibile impedirglielo, visto che proprio lo zar si era assunto il compito di soffocare la rivoluzione contadina in Persia. Stando all'analisi leniniana la Russia zarista conduceva “da decenni una politica di rapina contro la Cina, la Persia, l'Armenia e la Galizia” (p. 195).
Ma perché i socialisti europei non riuscivano a capire delle realtà così evidente? Secondo Lenin i motivi erano due: 1) ritenevano che “se il militarismo è figlio del capitalismo..., allora non è necessaria alcuna specifica attività antimilitaristica”; 2) non erano contrari all'idea di partecipare a una “guerra difensiva”, in cui la patria si difende dal nemico che vuole attaccarla. In altri testi aggiungerà che lo sviluppo relativamente pacifico in Europa del capitalismo, dalla Comune di Parigi alla I guerra mondiale, aveva rammollito l'energia rivoluzionaria dei partiti socialisti. Oltre a ciò andava considerato che coi profitti ottenuti dalle colonie, i capitalisti erano in grado di corrompere economicamente il proletariato industriale e i suoi rappresentanti sindacali e politici.
Dunque, “l'unico angolo visuale da cui è possibile guardare e risolvere il problema dell'atteggiamento della socialdemocrazia verso l'uno o l'altro aspetto delle relazioni internazionali non è quello del carattere offensivo o difensivo della guerra, ma quello degli interessi della lotta di classe del proletariato, o meglio, quello degli interessi del movimento internazionale del proletariato” (p. 29). Su queste parole, straordinariamente profonde, bisognerebbe scrivere un libro intero, esaminando caso per caso, dal 1848 ad oggi. Si noti, peraltro, la differenza ch'egli pone tra gli interessi di classe di un proletariato nazionale e quelli di un proletariato internazionale. Nessun partito di sinistra, ancora oggi, è in grado di fare una differenza del genere.
La decisione di partecipare a una guerra tra nazioni non può essere presa, da parte del proletariato, nell'ambito di una singola nazione, proprio perché il proletariato non ha “patria”. Anzi, se vogliamo, neppure la borghesia oggi ha una patria specifica, diversa da quella del suo capitale, che si trova sparso, o sul piano finanziario o su quello produttivo, in qualunque parte del pianeta.
Ecco perché gli organismi internazionali del proletariato dovrebbero essere costantemente presenti, proprio per poter prendere decisioni comuni in qualunque momento, sulle vicende più gravi e urgenti, al di là degli ambiti meramente nazionali. L'imperialismo del capitale (oggi chiamato, eufemisticamente, “globalismo”) deve sapere di avere a che fare con un nemico di rilevanza internazionale, in grado di opporsi a qualunque ingerenza militare o economica o finanziaria da parte dei capitalisti nei territori che usano come “colonie” o “semicolonie”. Oggi una rivoluzione socialista dovrebbe essere concertata sul piano internazionale. I proletari agricoli e industriali di tutto il mondo, unitamente a coloro che non dispongono di mezzi produttivi essenziali alla sopravvivenza dei popoli, dovrebbero essere rappresentati da organismi internazionali, in grado di prendere decisioni in autonomia.
Ovviamente una guerra mondiale non scoppia solo perché aumenta il militarismo. Per spiegarne le cause Lenin si rifà al manifesto del Congresso di Basilea, del novembre 1912, accettato all'unanimità da tutti i partiti socialisti del mondo, anche se non applicato praticamente. Esso è riferito a una possibile guerra tra Germania, Inghilterra e Francia per la conquista dell'Asia Minore; tra Austria e Russia per l'egemonia nei Balcani; tra Austria e Italia per la conquista dell'Albania e di altri territori dell'Adriatico. Le risoluzioni approvate vietavano agli operai di sparare ad altri operai stranieri, di combattere per il profitto dei capitalisti e di soddisfare l'orgoglio delle dinastie. La difesa della patria poteva essere ammessa nel periodo 1789-1871, quando il capitalismo lottava contro il feudalesimo.
In quel manifesto “non vi è una parola – scrive Lenin – né sulla difesa della patria, né su ciò che distingue una guerra offensiva da una guerra difensiva” (p. 181). Questo perché non ha alcun senso difendere una patria quando essa ha mire colonialistiche o imperialistiche. “Il manifesto di Basilea fissa, proprio per questa guerra, la tattica della lotta rivoluzionaria degli operai su scala internazionale contro i propri governi. Esso ripete le parole della risoluzione di Stoccarda, e cioè che, in caso di guerra, i socialisti devono sfruttare la 'crisi economica e politica' che ne deriva, per 'affrettare il crollo del capitalismo'... ai fini della rivoluzione socialista” (p. 144).
Le motivazioni della guerra imminente per Lenin erano abbastanza chiare:
Inghilterra e Francia vogliono prendere le colonie alla Germania (col pretesto di liberare il Belgio, occupato da quest'ultima) e, insieme all'Italia e alla Russia, vogliono ripartirsi due imperi: austro-ungarico e soprattutto ottomano; la Francia vuole anche l'Alsazia e la Lorena e perfino la riva sinistra del Reno, ed è convinta di prenderle se la Germania perde il confronto con la Russia;
se la Germania perde le proprie colonie, cercherà di rifarsi non solo con l'occupazione del Belgio, ma anche con quella della Serbia, della Romania e di una parte dell'impero ottomano; in ogni caso cercherà, a sua volta, di rapinare alcune colonie all'Inghilterra (p. es. l'Egitto), alla Francia, al Belgio (il Congo); quindi è chiaro che “la guerra è provocata dal conflitto tra due gruppi potentissimi di miliardari, il gruppo anglo-francese e il gruppo tedesco, per una nuova spartizione del mondo” (p. 221);
l'Italia non vuole solo l'Albania ma anche alcuni territori in Asia Minore;
la Russia non si accontenterà di alcune terre della Turchia orientale (p. es. l'Armenia) e di Costantinopoli (per la questione degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli), ma vorrà impadronirsi anche della Galizia, occupare la Mongolia e la Manciuria, asservire la Persia insieme agli inglesi e portar via ai tedeschi tutta la Polonia e la Prussia orientale; se i russi facessero la pace subito avrebbero soltanto l'Armenia e una parte della Galizia;
anche la Bulgaria, la Romania e l'impero austro-ungarico vogliono spartirsi l'ex-impero ottomano (anzi l'Austria vuol soffocare completamente i Balcani);
il Giappone vuole saccheggiare la Cina.
Giudica l'imperialismo russo di tipo feudale-militare, benché i “grandi-russi” rappresentino soltanto il 43% di una popolazione di 170 milioni di abitanti. Lo sfruttamento semi-feudale degli allogeni rappresenta la fonte maggiore del profitto dei “grandi-russi”.
Sulla Germania così scrive: “Gli imperialisti tedeschi avrebbero subito liberato il Belgio ecc., se gli inglesi e i francesi avessero 'cristianamente' diviso con loro le proprie colonie” (p. 140).2
Sull'impero austro-ungarico scrive: “Sotto l'Austria gli slavi oppressi godono di una maggiore libertà che non in quella vera 'prigione dei popoli' che è la Russia zarista” (ib.).
Sembrano – quelle di Lenin – delle affermazioni di un'evidenza lampante; eppure i dirigenti della II Internazionale fingevano di non capirle. Perché? Il motivo principale sta nel fatto che quando, in nome del progresso tecnico-scientifico e del benessere economico, si accetta lo sfruttamento delle colonie, è poi difficile, quando scoppiano delle guerre tra le nazioni che praticano il colonialismo, non mettersi dalla parte della propria nazione. Il tradimento avvenuto nell'agosto del 1914, con la concessione dei crediti militari, era già stato consumato molti anni prima, con l'atteggiamento acquiescente nei confronti del colonialismo europeo. Tutte le rivalità tra le nazioni europee avevano come denominatore comune la questione coloniale. Se ognuna si fosse accontentata di ciò che aveva, non sarebbe scoppiata una guerra mondiale, ma, al massimo, una guerra tra coppie di nazioni, come quella p. es. tra Inghilterra e Olanda per l'egemonia in Sudafrica.
Questa “guerra di schiavisti” – scrive Lenin – tende “a rafforzare la schiavitù delle colonie con una più 'giusta' ripartizione e con un ulteriore e più 'concorde' sfruttamento di esse”; tende anche “a consolidare l'oppressione sulle nazionalità allogene nelle 'grandi' potenze stesse” (Austria e Russia in primis); tende infine “a consolidare a prolungare la schiavitù salariata”.
“Nel corso di quasi mezzo secolo i governi e le classi dominanti in Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Austria e Russia hanno condotto una politica di depredazione delle colonie, di oppressione di altre nazioni, di soffocamento del movimento operaio” (p. 141). Ora, non è certamente “compito dei socialisti aiutare il brigante più giovane e più forte (la Germania) a depredare i briganti più vecchi e più nutriti. I socialisti devono servirsi della lotta tra i briganti per abbatterli tutti” (p. 140). Né ha senso voler entrare in guerra in base all'atteggiamento dei socialsciovinisti della Quadruplice Intesa (Inghilterra, Francia, Russia e Italia), i quali “amano riferirsi soprattutto all'esempio del Belgio” (p. 141), occupato dalla Germania, nonostante la dichiarata neutralità dello stesso Belgio.
Lenin guardava le cose dal punto di vista della classe operaia industrializzata. In realtà il colonialismo era iniziato sin dal primo decennio del XV secolo, quando il Portogallo si era unificato come nazione cattolico-feudale, con spirito commerciale, eliminando la presenza islamica. La Spagna e il Portogallo si erano già spartite il mondo in due parti, stabilendo un confine immaginario che nessuna delle due poteva violare: era la cosiddetta “raja”, sanzionata dal papato. Fu proprio con lo sfruttamento delle loro colonie che si favorì lo sviluppo di un capitalismo meramente commerciale, che poi in Europa porterà, grazie alla riforma protestante, a uno sviluppo manifatturiero (in Olanda) e industriale (in Inghilterra) vero e proprio.
Mentre la Spagna e il Portogallo andarono nelle colonie per permettere a una classe feudale spiantata di rifarsi una vita schiavizzando a fini commerciali le popolazioni indigene, l'Olanda invece puntò decisamente non solo sul commercio delle spezie ma anche sulle manifatture tessili, diventando un modello da imitare per Francia e Inghilterra. Gli inglesi, dopo la loro rivoluzione politico-calvinistica, eliminarono la concorrenza olandese, affermandosi su tutti i mari del mondo. Neanche Spagna e Portogallo potevano impedire loro di commerciare dove volevano. Anzi i portoghesi preferiranno sottomettersi agli inglesi pur di non essere occupati dagli spagnoli.
Queste cose vanno dette quando si parla di colonialismo, poiché il colonialismo commerciale (quello del cacao, delle spezie, del tabacco, della canna da zucchero, del cotone...) precede lo sviluppo del capitalismo industriale. Il capitalismo commerciale inizia almeno 500 anni fa, anzi, se vogliamo, con le stesse crociate medievali.
In ogni caso da quando esistono colonialismo e capitalismo le guerre tendono a mondializzarsi, proprio perché entrano continuamente in scena nuovi competitori, che per stare appunto “in scena”, devono darsi un respiro internazionale. Per poter sussistere il capitalismo deve diffondersi il più possibile, ma così facendo svela i segreti tecnologici del suo successo al mondo intero. Crea una situazione per cui gli ultimi arrivati non hanno bisogno di ripercorrere tutto il tragitto dei paesi che li hanno preceduti. Se sono in grado di farlo, partono dalle conquiste tecnologiche più recenti e iniziano a competere da subito, rivendicando una nuova spartizione delle colonie.
Lenin anzi avrebbe dovuto dire che dal 1789 al 1871 il capitalismo europeo non aveva nulla di progressista, in quanto praticava già largamente il colonialismo. Nessun paese europeo può essere qualificato “progressista” a partire dal colonialismo portoghese in Africa e, tanto meno, a partire dalla conquista spagnola del continente sudamericano. Dal punto di vista del colonialismo i paesi europei, fossero feudali o capitalisti, sono sempre stati colonialisti, sin dal tempo delle crociate, anzi, sin dal tempo dello schiavismo greco-romano.
Forse si potrebbe addirittura dire il contrario di quanto affermato da Lenin: e cioè che i due imperi feudali, ottomano e russo, sono stati gli unici ad aver saputo frenare l'espansione verso est dell'Europa occidentale. Tutti gli imperi e gli Stati nazionali dell'Europa occidentale, fossero feudali o capitalisti, hanno sempre fatto pagare il peso della loro espansione sulle spalle dei contadini e dei lavoratori da sottomettere nelle colonie.
È indubbiamente vero che “il carattere relativamente 'pacifico' del periodo 1871-1914 ha alimentato l'opportunismo, stato d'animo dapprima, tendenza in seguito e, infine, gruppo o strato composto dalla burocrazia operaia e dai compagni di strada piccolo-borghesi”.3 Lenin avrebbe dovuto specificare che quel periodo era “relativamente pacifico” solo in Europa occidentale, non nel resto del mondo. Anzi, era “pacifico” in Europa proprio perché nel resto del mondo si affermava un violento colonialismo occidentale.
“Questi elementi potevano sottomettere il movimento operaio soltanto riconoscendo a parole i fini rivoluzionari e la tattica rivoluzionaria; potevano cattivarsi la fiducia delle masse soltanto giurando che il lavoro 'pacifico' non era che la preparazione della rivoluzione proletaria” (p. 184). Il fatto che questo comportamento si sia manifestato in tutti i partiti socialisti di tutti i paesi europei è indicativo di una tendenza storica ineludibile, quasi indipendente dalle singole personalità politiche che guidavano i suddetti partiti socialisti. Tale tendenza doveva per forza essere la conseguenza di un atteggiamento già ampiamente diffuso, consolidatosi nel tempo: l'atteggiamento di chi non si preoccupa di sapere da dove proviene il benessere socioeconomico di cui fruisce.
I socialisti europei, al massimo, chiedevano alla borghesia di venire incontro alle richieste del proletariato industriale, minacciando, in caso contrario, scioperi, manifestazioni, occupazioni di fabbriche, rivoluzioni... Ma non hanno mai fatto nulla per impedire la pratica del colonialismo. Non hanno mai chiesto agli operai di non contribuire allo sviluppo del colonialismo praticato all'estero dai loro imprenditori.
1Questo spiega il motivo per cui uno dei trattati segreti, stipulati dallo zar per entrare nella I guerra mondiale, fu quello di spartirsi la Persia con gli inglesi.
2A dir il vero la Germania non era affatto sprovvista di colonie: già possedeva vasti territori nell'Africa sud-ovest e orientale e nella Nuova Guinea.
3Per “compagni di strada” Lenin intende sempre gli iscritti a partiti o sindacati privi di vera coscienza di classe, sostanzialmente piccolo-borghesi, e quindi non necessariamente disponibili a compiere una rivoluzione.
Translate:
Info | Note legali | Contatto | Facebook | Twitter | Youtube