LA TRAGEDIA DELLE
BACCANTI
|
|
IL TEATRO GRECO: DECLINO DELLA TRAGEDIA
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
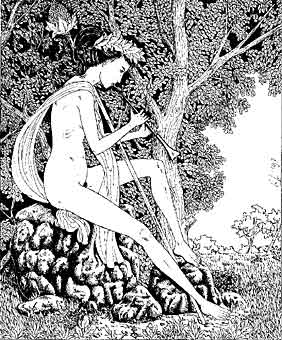
Dal IV secolo a.C. la tragedia subisce una forte decadenza, che si prolunga anche durante l'era ellenistica, perdendo l'originale carattere religioso e sociale: infatti l'organizzazione degli spettacoli passava di carica in carica, dapprima all'interno della compagnia, poi addirittura ad impiegati statali. Così la tragedia si ridusse, povera di cariche emotive, alla letteratura o, per un processo di progressiva profanizzazione, si trasformò nella commedia nuova, il cui poeta più rappresentativo fu Menandro. Le interpretazioni teatrali diventano solo un semplice divertimento riservato alle corti ellenistiche.
Nel corso del III secolo a.C. la tragedia greca fu importata a Roma. L'età arcaica vide un enorme successo di questo genere teatrale, molto lodato da Cicerone e da Quintiliano.
I romani portarono sulla scena sia i personaggi dei miti greci (fabulae coturnatae), soprattutto relativi al ciclo troiano e modellati spesso su Euripide, sia gli avvenimenti e i personaggi propri del mondo romano (fabulae praetiextae).
I primi autori tragici romani furono Andronico, Nevio ed Ennio, che si ispirarono a modelli ed esemplari greci. Con Pacuvio e Accio, invece, la produzione accrebbe di originalità, sia per i vari accorgimenti scenici utilizzati, sia per la rigorosa rappresentazione delle passioni e dei motivi patetici.
La tragedia però non divenne mai così popolare come in Grecia e fu tralasciata durante l'ultimo secolo repubblicano e durante l'era imperiale. Il teatro lasciò sempre più posto alle rappresentazioni del mimo. Subì inoltre la concorrenza degli spettacoli del circo e dei giochi dei gladiatori.
A noi restano solo due versi della Medea di Ovidio, tutto lo sconcertante teatro di Seneca, probabilmente destinato alla lettura invece che alla rappresentazione teatrale, ed infine l'Ottavia, presumibile opera di un suo imitatore.
