LA GRECIA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Storia ed evoluzione della Grecia classica
STRUTTURA ECONOMICO-SOCIALE DEGLI STATI ELLENISTICI
SVILUPPI IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI DEL MONDO GRECO ED ELLENISTICO
Introduzione - Le esigenze degli Stati ellenistici - Caratteri dell'ellenismo nelle regioni asiatiche - L'affermazione dell'economia occidentale in Asia, la nascita di un'economia "mista" - Introiti statali ed economia ellenistica - Conclusioni sintetiche - Gli Stati ellenistici occidentali - Il mondo egeo e mediterraneo: Grecia e Rodi - I nuovi centri di potere del Mediterraneo orientale: Rodi - La decadenza del mondo ellenistico. Roma. Bisanzio - La dominazione romana dell'Oriente - La rinascita dell'Oriente e il declino dell'Impero romano occidentale - Conclusioni sintetiche e bibliografia
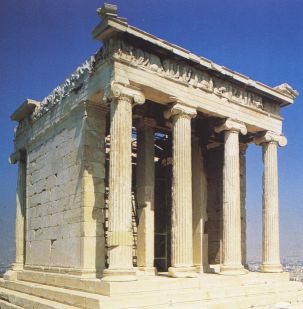
A partire già dal VII secolo, con il formarsi di rotte commerciali stabili tra le colonie e la madrepatria (e tra le prime e gli abitanti delle regioni circostanti) si era andato affermando in Grecia, e più in generale nelle città-stato di cultura ellenica, un nuovo tipo di economia, basata sugli scambi di mercato e su una produzione (dapprima soprattutto cittadina e artigianale, poi anche agricola) orientata, oltre che a un consumo interno e 'familiare', anche e sempre di più agli scambi commerciali.
Vari fattori, tra i quali la produzione per il mercato (che rispetto al passato alimentava, e al tempo stesso presupponeva, una maggior capacità produttiva, dovendo il produttore soddisfare non solo le proprie esigenze di consumo (autarchia), ma anche quelle dei propri acquirenti), la concorrenza commerciale (che, seppure in grado molto minore rispetto all'odierno capitalismo, già esisteva e stimolava una maggior efficienza produttiva) ed un certo avanzamento nelle tecniche di produzione (risultato appunto dell'esigenza di una sempre maggior efficienza del lavoro, che portava a una maggior divisione e specializzazione delle diverse fasi della produzione, e a conseguenti progressi sul piano produttivo), avevano determinato una notevole crescita della quantità dei prodotti - tanto di quelli agricoli, quanto di quelli artigianali - in circolo nella società, e causato di conseguenza il ribasso dei loro prezzi e, quindi, una loro maggiore accessibilità a tutte le fasce sociali.
La produzione orientata ai mercati dunque, assieme ai mercati stessi (fonti, attraverso le rotte internazionali, di approvvigionamento di merci di scarsa o nulla disponibilità nelle proprie regioni), aveva determinato rispetto all'economia fondamentalmente agraria e fondiaria dei secoli precedenti un innalzamento delle condizioni di vita medie della popolazione.
Si era inoltre formata, come logica conseguenza di tutto ciò, una classe imprenditoriale soprattutto cittadina (già in qualche modo definibile come "borghese") che possedeva le leve finanziarie di tali attività produttive e di mercato, che spesso peraltro esercitava anche direttamente. Una tale classe, similmente alla moderna borghesia, ricercava - seppure in modi meno razionali rispetto a quest'ultima - il profitto commerciale, anche attraverso l'investimento della ricchezza, e aveva inoltre profondo interesse a estendere i propri affari a sempre nuove regioni. Si può perciò parlare - fatte le debite distinzioni rispetto alla moderna borghesia - di una "borghesia capitalistica antica", versata nella produzione di beni su larga scala e in una loro commercializzazione attraverso mercati che col tempo tendevano a divenire sempre più estesi.
A questo proposito scrive Mario Attilio Levi, parlando appunto del mondo greco classico: "La formazione di un ceto medio istruito e medio possidente fu uno dei fatti più rivoluzionari di tutta la storia del mondo antico, e costituì anche la maggiore caratteristica della civiltà ellenica […]. Il mondo mediterraneo non conosceva l'esistenza di ambienti sociali di questo genere, all'infuori che nella forma, frequente in Egitto e nel mondo babilonese, di ceti di funzionari statali di vario livello e, solitamente, di cultura strettamente specializzata per le esigenze della loro attività e per le mansioni loro affidate. Non risulta che in nessuna altra parte del mondo si fossero determinate le condizioni obiettive che permettevano lo sviluppo di un ambiente di imprenditori economici, i quali riuscivano a organizzare imprese produttive di sufficiente grandezza da dare lavoro a alcune decine di operai liberi o schiavi, procurandosi profitti che consentivano investimenti grazie ai quali accrescevano i loro redditi".
Tali attività imprenditoriali poi, dalla Grecia (e dalle sue colonie) si erano gradualmente diffuse anche in quelle regioni limitrofe (come, ad esempio, la Macedonia) che risentivano dell'influenza del mondo ellenico.
Così, per esempio, anche in Macedonia si era formata col tempo una vasta rete urbana (le città essendo le sedi del commercio e dell'imprenditoria) che andava ad affiancarsi alle antiche strutture produttive fondiarie della nobiltà, fino ad allora uniche basi economiche della regione.
E' importante conoscere questi meccanismi sociali ed economici, poiché in epoca ellenistica essi furono trapiantati dai Greci e dai Macedoni anche nelle vicine regioni asiatiche (che avevano fatto parte prima dell'Impero persiano), dove avrebbero conosciuto un ulteriore e prodigioso potenziamento (con conseguenze peraltro negative per l'economia delle regioni d'origine). La comprensione del "capitalismo greco" quindi, è una precondizione indispensabile per quella del "capitalismo ellenistico", il quale pure - come si mostrerà qui di seguito - sviluppò rispetto a esso anche dei caratteri innovativi e originali.
In ogni caso, sul finire del periodo classico (cioè attorno al IV sec.) i Greci (e, seppure in grado minore, i popoli che avevano risentito della loro influenza), avevano oramai acquisito tecniche produttive decisamente all'avanguardia per la propria epoca, molto più avanzate cioè rispetto a quelle in uso presso i loro vicini asiatici e presso le vicine popolazioni mediterranee (comprese quelle dell'Italia), giungendo così a produrre beni in grande quantità, che esportavano in cambio di prodotti di scarsa o nulla reperibilità interna.
Ricordano a tale proposito Clough e Rapp, nella loro Storia economica d'Europa, che "la Grecia [del periodo classico e preclassico, n.d.r.] produceva derrate agricole specializzate come l'olio d'oliva e il vino, adatte al suo territorio collinoso, e le vendeva ai mercati esteri, facilmente raggiungibili per mare. In un secondo tempo, produsse anche merci industriali specializzate, utensili e armi in ferro, vasellame e opere d'arte, di cui vi era domanda all'estero".
Grazie dunque alle proprie innovative tecniche produttive (sia artigianali che agricole), la Grecia era riuscita a conquistare un sostanziale predominio sui traffici di buona parte del Mar Mediterraneo, divenendo così all'interno del proprio mondo una civiltà (anche) economicamente egemone. A tali competenze e abilità di carattere produttivo - nonché in gran parte come causa indiretta di esse - si accompagnava inoltre una nuovo tipo di organizzazione sociale, fondata rispetto agli altri popoli su rapporti giuridici estremamente elastici, maggiormente basata quindi sulla libera iniziativa individuale tanto in ambito economico, quanto in ambito politico e culturale.
E una simile civiltà - privatistica e individualistica, imprenditoriale ed "anarchica" - avrebbe trovato nella nascita dei grandi Regni ellenistici un'occasione prodigiosa per una propria ulteriore espansione, avvenuta - come meglio vedremo - attraverso una curiosa e fino ad allora inedita commistione tra le proprie tradizioni economiche e quelle politico-amministrative del vicino mondo asiatico.
-- I mercati nelle società antiche --
Quanto si è finora detto richiede tuttavia dei chiarimenti di fondo, in merito soprattutto all'effettivo sviluppo dei mercati all'interno dell'economia greca - e più in generale antica - anche nelle fasi di maggiore rigoglio di quelle attività affaristiche, privatistiche e "capitalistiche" su cui essi solitamente si sostengono.
Soprattutto, è necessario guardarsi dal sopravvalutare la portata effettiva di questo tipo di attività all'interno di tali economie. Mentre difatti, nelle moderne società occidentali (e oramai, si può dire, mondiali) i mercati hanno raggiunto un livello di sviluppo tale da costituire in sostanza l'unico sbocco delle attività produttive (ad essi infatti, oramai interamente finalizzate), nelle società antiche - anche in quelle che, come la Grecia o Roma, conobbero uno sviluppo mercantile e affaristico davvero notevole - essi costituirono sempre soltanto una parte, seppure alle volte per nulla marginale, delle attività economiche complessive.
Per questa ragione, nonostante si possa già parlare di un'economia "proto-capitalistica" per alcune zone o periodi della storia antica - tra i quali, senza dubbio, possiamo annoverare quello ellenistico -, non si può tuttavia mai parlare per essi di vero e proprio "capitalismo", ovvero di un'economia interamente dominata dalle logiche di mercato.
E anche se in passato autori "modernisti" come Rostovtzeff hanno - soprattutto in riferimento al periodo tardo-classico ed ellenistico, e a quello romano e imperiale - adombrato l'idea di un mondo già virtualmente dominato dai commerci e dalle attività affaristiche e di mercato (comprese quelle finanziarie e, a volte, persino di borsa), una tale visione appare oggi ormai completamente superata.
Come mostreremo di nuovo più avanti infatti, in riferimento soprattutto alle regioni ellenistiche asiatiche, la capacità produttiva delle società dell'epoca fu sempre fortemente limitata da fattori - tanto di natura istituzionale e giuridica, quanto di natura tecnologica - che non le permisero una trasformazione in senso propriamente capitalistico. Solo nel mondo moderno si sono realizzati quegli avanzamenti sia tecnici (industriali) che istituzionali (tra i quali, senza dubbio, quello principale è lo sviluppo di un mercato del lavoro formalmente libero, fondato cioè sulla possibilità del lavoratore di vendere al proprietario dei mezzi di produzione la propria forza-lavoro, sulla base di un accordo revocabile da ciascuna delle parti contraenti) che sono appunto alla base di una simile trasformazione!
Al contrario, nel mondo antico sussistettero sempre alcune rigidità di fondo, in parte connesse al diritto (in linea di massima non revocabile) dei lavoratori a rimanere stabilmente insediati sulle terre d'affitto (in Asia concesse solitamente dal Sovrano, in Occidente invece dai proprietari terrieri, sempre sulla base di vari tipi di "patti colonici") o alla natura stessa del lavoro schiavile (che obbligava il proprietario a mantenere i propri schiavi anche in condizioni economicamente sfavorevoli, quali ad esempio un eccesso di manodopera o un insufficiente rendimento della produzione in termini di profitti) [1]; e in parte a un ridotto utilizzo dei ritrovati tecnici - che pure esistevano - ai fini di un aumento quantitativo della produttività (un fattore questo, che proprio nel periodo ellenistico conobbe un sia pur parziale superamento). Tali tipi di rigidità sottrassero a queste economie quella dinamicità - sia organizzativa, sia produttiva - che costituisce invece la radice ultima del capitalismo vero e proprio, in quanto organizzazione economica basata su una produzione di carattere intensivo interamente finalizzata ai mercati, per la cui nascita sono appunto necessari sviluppi sia giuridici, sia finanziari, sia tecnologici che, seppure non del tutto estranei, non furono comunque sufficientemente sviluppati nel mondo e nella stessa mentalità antica.
[1] Sul tema dei rapporti sociali, già Max Weber aveva notato le diverse implicazioni economiche di rapporti sociali rigidi e gerarchizzati, quali quelli tipici delle società pre-capitalistiche (arcaiche e/o extraeuropee), rispetto a quelli (formalmente) paritari - e quindi flessibili - tipici delle società occidentali moderne (dal XVI sec. in poi).
Il primo tipo di società infatti, conosce al proprio interno una divisione tra differenti "caste" (gruppi sociali chiusi), le più alte delle quali, assieme a un'indubbia azione di sfruttamento economico, esercitano su quelle inferiori anche un'azione di tutela e di protezione (secondo le coordinate tipiche di una società patriarcale e chiusa). Per tale ragione, i rapporti economici - discendenti in linea diretta da quelli sociali - non possono acquistare in esse un eccessivo dinamismo, rimanendo vincolati da obblighi consuetudinari rigidi, che creano legami stretti e tendenzialmente inscindibili tra singoli nobili e singoli plebei, tra singoli patroni e i loro clienti. In questi contesti dunque, anche qualora - come nel caso della società romana antica - si crei effettivamente un'iniziativa privata orientata commercialmente, non sarà comunque possibile un pieno dispiegamento di una razionalità di tipo capitalistico (basata cioè su un freddo calcolo delle convenienze economiche, e sulla possibilità di una rapida trasformazione d'impresa).
Viceversa il moderno mondo occidentale, europeo e americano, caratterizzato dal principio inviolabile della parità giuridica tra soggetti (discendente in origine dall'appartenenza a una medesima confessione religiosa, quella cristiana, di impronta non solo monoteistica ma anche universalistica e egualitaria), ha sviluppato i presupposti giuridici e istituzionali necessari a un pieno dispiegamento della razionalità d'impresa, nonché quindi alla nascita del vero e proprio capitalismo. Proprio l'eguaglianza formale tra liberi cittadini infatti, dà al proprietario d'impresa la possibilità di interrompere il rapporto che lo lega al lavoratore stipendiato, qualora lo consideri economicamente "non conveniente".
E' merito di Weber, tra l'altro, quello di avere affrontato il tema della nascita del capitalismo non solo nell'ottica degli incrementi produttivi determinati dalla Rivoluzione industriale, ma anche nell'ottica di quelle trasformazioni istituzionali ed "etiche" - le cui origini egli rintraccia appunto nel messaggio cristiano - che, al pari dei primi, hanno involontariamente posto delle premesse indispensabili per una tale nascita. (torna su)