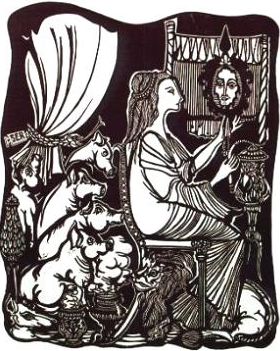|
| |
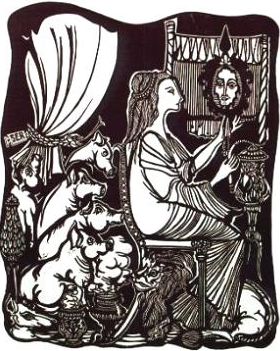
Circe, al vedere Ulisse superare l'inganno grazie all'aiuto di Ermes, chiede
di congiungersi con lui perché spera di poterlo "raggirare" con l'ultima chance
che le è rimasta: "saliamo sul letto, perché congiunti nel letto e in amore ci
si possa l'un l'altro fidare"(334-5).
Ma Ulisse non cede al ricatto sessuale, poiché egli sa dominare i sensi con
l'astuzia dell'uomo che prima do tutto deve salvaguardare l'interesse: "Come puoi
chiedermi d'essere mite con te, che nella casa m'hai fatto maiali i compagni, e
qui tenendomi adeschi anche me, insidiosa, a venire nel talamo sopra il tuo
letto, perché, appena nudo, mi faccia vile e impotente? Sul tuo letto io non
voglio salire, se non acconsenti a giurarmi, o dea, il gran giuramento che non
mediti un'altra azione cattiva a mio danno"(337-44).
Nella seconda sequenza abbiamo creduto di ravvisare una sottile differenza
tra quanto richiesto da Ermes e quanto invece messo in pratica da Ulisse.
Alla richiesta di Ermes di cedere, previo giuramento, al ricatto sessuale
per la liberazione dei compagni, Ulisse darà un'interpretazione leggermente
diversa: "Lei giurò subito come volevo... allora io salii sul bellissimo letto
di Circe"(345-7).
In pratica Ulisse accetta l'invito di giacere con Circe prima ancora
che i compagni siano stati liberati, semplicemente con la promessa, sotto
giuramento, che lei non avrebbe tramato altri inganni a suo danno. Nel consiglio
di Ermes vi era invece la liberazione dei compagni, anzitutto, come
motivazione dell'amplesso.
Qui, a proposito del giuramento, delle due l'una: o Ulisse impone a Circe un
giuramento che non appartiene alla cultura di lei, sacerdotessa sicuramente più
"laica" del "servo fedele" Ermes, per farle capire che se l'avesse trasgredito
la vendetta sarebbe stata terribile; oppure le chiede un giuramento antico, che
per Circe aveva un valore assai maggiore di quelli che si facevano ai tempi di
Ulisse.
Il giuramento in questione veniva comunque pronunciato chiamando a testimone
il Cielo, la Terra e lo Stige, cioè valori in cui, a parte l'ultimo, anche Circe
avrebbe potuto credere.
In effetti lo Stige, il fiume infernale, nel nome del quale gli dèi
pronunciavano i loro giuramenti, sembra essere una categoria appartenente più
alla cultura di Ermes, con cui questi chiede a Ulisse di sottomettere Circe.
Uno spergiuro faceva decadere gli dèi, per un periodo di cento anni, dal
dono privilegiato della divinità. Sulle rive di questo fiume, Caronte prendeva
in consegna dalle mani di Mercurio le ombre ch'egli, poi, dallo Stige
sospingeva, sulla sua barca, nell'altro fiume infernale, l'Acheronte.
Si può quindi supporre che in quel giuramento vi fosse in realtà
un'ammissione di sconfitta culturale di Circe non solo nei confronti di
Ulisse ma anche nei confronti di Ermes, suo principale rivale.
Comunque nella letteratura antica troviamo molti esempi che ci testimoniano
l’importanza della pratica del giuramento. Il fatto stesso che garanti del
giuramento fossero gli dèi, la dice lunga sulla difficoltà che una
cultura naturalistica e agro-pastorale come quella rappresentata da Circe
potesse sopravvivere nel confronto, anche violento, con la nuova cultura
emergente di Ermes e, qui, del suo emissario, Ulisse, entrambi esponenti di una cultura urbana,
mercantile, individualistica...
Non dimentichiamo che anche Ermes faceva addormentare o risvegliare gli
uomini con la sua verga e che conduceva le anime nell'Ade, cioè in un inferno
non meno avvilente del porcile della maga. La religione di Circe è indubbiamente
più primitiva: la sua magia è legata ai segreti della natura e non a una
rappresentazione intellettuale dell'oltretomba, con cui i sacerdoti del mondo
ellenico potevano spaventare gli sprovveduti o illudersi di tenere a freno i
potenti.
Ma la cosa più interessante di questa sequenza è che Ermes ha avuto bisogno
di Ulisse per imporsi su Circe, non avendo le sue qualità fondamentali,
a testimonianza che nell'area geografica in cui è ambientata la vicenda, i
valori culturali non erano stati ancora così profondamente alterati dai rapporti
schiavistici e mercantili tipici della società ellenica.
Ulisse infatti è il "multiforme", il "versatile"(330), l'uomo rotto a ogni
esperienza, disposto a tutto pur di primeggiare, ma capace di farlo con astuzia,
lungimiranza... A lui non basterà neppure fidarsi della parola data, come
vedremo nella sequenza successiva.
|