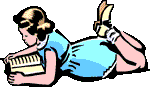|
|
IL DIRITTO ALLA
CULTURA
|
|
QUESTIONI DI FONDO 1-2-3-4-5-6-7-8-9
Opponendo il diritto d’autore al diritto alla cultura la Siae viola la Costituzione?
Ci sono almeno quattro articoli della Costituzione che la Siae rischia di violare pretendendo d’imporre royalties a chi in rete fa solo cultura senza scopo di lucro.
Art. 4: Se la Repubblica riconosce a ogni cittadino il diritto al lavoro per
concorrere al progresso materiale o spirituale della società, dando per scontato
che tale diritto debba essere remunerato, a maggior ragione deve riconoscerlo
quando tale diritto non viene remunerato. Perché dunque imporre il pagamento di
royalties a chi svolge un lavoro a titolo gratuito?
Sostenere inoltre che il diritto d’autore è un diritto al lavoro anche per gli
eredi degli artisti, significa soltanto sostenere un diritto alla rendita. E un
diritto del genere non può risultare più importante del diritto al lavoro
esercitato in maniera gratuita per il progresso “materiale” e, nella
fattispecie, soprattutto “spirituale” della società.
Art. 9: La Siae si pone contro la Repubblica che promuove lo sviluppo della
cultura e della ricerca scientifica e tecnica imponendo compensi per lo sviluppo
gratuito di detta cultura.
E considerando che Internet è una rete mondiale, essa impedisce tale sviluppo
oltre i confini nazionali.
Art. 21: La Siae è palesemente contro il diritto di ogni cittadino di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
L’unica eccezione al principio espresso nell’art. 21 dovrebbe essere quella del
plagio, nel senso che non si possono usare opere altrui facendole passare come
proprie.
La storia purtroppo è piena di casi del genere (la stessa redazione della Bibbia
ne è un esempio eloquente, dove spesso intorno all’identificazione degli autori
dei testi circolano le più svariate ipotesi interpretative).
Subordinata al plagio integrale (che risulta comunque evento poco frequente in
campo artistico) è l’alterazione, cioè la modificazione di una parte dell’opera
d’ingegno: cosa che, soprattutto con l’avvento dell’era digitale, è diventata
molto frequente.
In casi del genere l’utilizzatore dell’opera dovrebbe sempre citare le sue
fonti, ovvero indicarne la paternità, la provenienza e la reperibilità, al fine
di permettere un confronto obiettivo tra ciò che l’utilizzatore ha trattato e la
fonte originaria.
In ogni caso la Siae non può impedire il riutilizzo libero delle opere altrui,
quando in ciò non si ravvisi il reato del plagio integrale o della parziale
alterazione.
Il progresso dell’arte e della cultura è sempre avvenuto e ancora avviene anche
grazie ai reciproci condizionamenti delle opere dell’ingegno umano.
Il diritto d’autore non può essere configurato come obbligo a non tener conto di
alcuna opera degli ultimi 70 anni, senza averne preventivamente pagato il
compenso per l’utilizzo. Un obbligo del genere dovrebbe essere rifiutato da
qualunque artista, proprio perché l’arte è il risultato di una inevitabile
contaminazione di opere differenti.
In tal senso il diritto d’autore può valere soltanto finché l’artista è vivo:
non può appropriarsi di questo diritto né l’editore delle sue opere, né l’erede
dell’artista.
Se il diritto d’autore si configura come diritto al lavoro, questo diritto
cessa, necessariamente, con la morte dell’artista, e se si vuole farlo
continuare, inevitabilmente esso si trasforma in un diritto alla rendita.
E, come noto, ogni rendita è parassitaria e contraria al diritto di sviluppare
la cultura.
Se il diritto d’autore è semplicemente un diritto al riconoscimento di una
paternità intellettuale dell’opera, ebbene questo diritto è eterno, non può
scadere dopo 70 anni.
Con l’avvento dell’era digitale la riproduzione di un’opera, in forme diverse da
quelle originali, è divenuta una pratica molto semplice e proprio per questo
motivo molto efficace per la diffusione della cultura.
Qualunque cosa può essere trasformata in “bit”. Impedire un fenomeno del genere,
che esiste in rete dal 1989, anno in cui è nato il world wide web, significa
andare contro la storia e lo sviluppo tecnico-scientifico.
L’unica cosa che si può fare per impedire la violazione del diritto d’autore è
quella di citare la fonte originaria o comunque di dichiarare che la propria
riproduzione è o non è conforme all’originale.
Sono i musei, le fondazioni, gli archivi, le biblioteche ecc. che conservano gli
originali: solo loro possono essere autorizzati a rivendicare un diritto
d’autore quando ciò venga palesemente violato.
Le opere d’arte sono uniche e irripetibili. Qualunque loro riproduzione può
essere tollerata a condizione che si affermi appunto che si tratta di una
riproduzione (integrale o parziale) e a condizione che si specifichi il luogo
ove poter visionare l’opera originaria.
Art. 33: L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Siae non può obbligare i docenti a mettere in area riservata, sotto password, le loro produzioni didattiche e culturali, per poter non pagare i diritti d’autore. La cultura offerta a titolo gratuito deve essere libera e pubblica.
DIRITTO D’AUTORE CONTRO DIRITTO ALLA CULTURA?
La recente diatriba, scoppiata nel web nazionale, tra la Siae e alcuni siti gestiti da insegnanti, in relazione ad immagini jpeg riproducenti dipinti di artisti oggetto di copyright, utilizzate in ipertesti didattico-culturali, senza fini di lucro, ha posto un problema inedito all’attenzione di chi, in rete, s’era fino adesso limitato a citare le fonti e non a pagare royalties; un problema che si può riassumere nella seguente domanda: il diritto d’autore può condizionare il diritto alla cultura libera, offerta a titolo gratuito e in area pubblica?
La Siae, che sino a ieri era intervenuta là dove poteva constatare usi non autorizzati di opere musicali, filmiche, editoriali ecc., oggi pensa di agire anche nel settore delle immagini digitali, siano esse riproduzioni di dipinti o di fotografie. E non fa distinzioni, quando i materiali sono pubblici, tra siti culturali e siti commerciali, se non negli importi dovuti.
Pare che le ingenti perdite causate dalla pirateria informatica, attraverso cui il mondo intero può impunemente scaricare film, musiche e software, stiano trovando nei siti amatoriali, dediti alla cultura e all’arte in particolare, una sorta di insperata compensazione.
Come difendersi da queste interpretazioni così restrittive della legge n. 633/1941 sul diritto d’autore? Come prevenire l’atteggiamento di questo leone ruggente che da qualche anno s’aggira in rete in cerca di chi divorare?
Per la Siae infatti ogni webmaster è, ipso facto, un “editore”: è sufficiente che metta in chiaro i propri files.
Gli unici due modi per non pagare royalties sono o di usare (relativamente alle immagini) dei link esterni (p.es. il tag iframe), oppure di mettere i propri elaborati in area riservata, sotto password.
Per la Siae c’è più differenza tra area riservata (accessibile solo agli iscritti) e area pubblica, che tra sito culturale (senza fine di lucro) e sito commerciale. La gratuità, nell’uso di immagini protette, è riservata alla didattica privata, non alla cultura pubblica. Le sue tabelle parlano chiaro.
Le immagini, anche nel caso vengano pagate, non possono superare i 72 dpi di risoluzione e un sito amatoriale non può metterne in chiaro più di 50, altrimenti diventa come i siti intestati a persona giuridica: scuole, università, musei, biblioteche ecc. (Come poi si possa sostenere che una jpeg di così bassa risoluzione sia copia fedele di un dipinto di Picasso o di Kandinsky, questo solo la Siae può saperlo).
Poiché detta società pubblica non ha mai emesso alcun comunicato stampa su questo suo singolare atteggiamento, gli insegnanti – che almeno avrebbero dovuto essere avvisati in tempo dal loro Ministero, al fine di poter controllare i loro ingenti archivi – di fatto stanno pagando di persona le conseguenze di un trend che improvvisamente hanno scoperto essere illegale.
Di fatto il diritto d’autore può essere usato contro il diritto alla cultura offerta a titolo gratuito al mondo intero.
È vero che, in questa fase iniziale, la Siae sta cercando di colpire quei siti culturali che dispongono di circuiti banner e di ad-sense di Google, come per voler in qualche modo legittimare il proprio arbitrio.
Ma è anche vero che se nessuno reagisce, sarà una reazione a catena: il web culturale e artistico, messo in chiaro, inevitabilmente morirà.
Infatti la stragrande maggioranza dei siti amatoriali possiede aspetti “commerciali” del tutto insignificanti, che non giustificano neanche lontanamente l’accusa di fare business con l’arte.
Homolaicus.com p.es. ha un circuito banner del tutto gratuito; il proprietario del sito non ha rapporti diretti con alcun inserzionista di banner o loghi a pagamento, e non vincola in alcun modo la visione dei propri ipertesti culturali ad azioni di tipo commerciale. Il ricavato degli ad-sense di Google copre in maniera assolutamente ridicola le spese sostenute per gestire un sito generalista di oltre due giga di materiali.
La Siae non transige neppure, in aperta violazione dell’art. 70 della L. 633, sull’uso porzionato delle immagini, asserendo che i diritti vanno pagati in ogni caso, sia che la jpeg riproduca il dipinto integrale o solo una sua parte.
Su questo inaudito atteggiamento vi sono già state in Parlamento tre interrogazioni: due alla Camera (Cardano e Zanella) e una al Senato (Bulgarelli), e si sono mosse con un’identica petizione due associazioni di docenti: Anitel e Didaweb.
Ciò che si chiede, fra le altre cose, è una moratoria di almeno un anno, onde permettere ai docenti e ai webmaster culturali di controllare i loro archivi sulla base dell’elenco degli artisti che la Siae mette a disposizione in un file pdf di non facile reperibilità.
Ma la cosa più importante è quella di introdurre nella legislazione italiana il concetto americano di “fair use”.
Il “fair use” – come dice Wikipedia - è un aspetto legislativo, concernente il diritto d'autore, che stabilisce la lecita citazione non autorizzata o l'incorporazione di materiale protetto dal diritto d'autore nel lavoro di un altro autore sotto certe specifiche condizioni.
Le condizioni sono quelle che chiunque dotato di buon senso può immaginarsi: “promozione del progresso della scienza e delle arti utili".
Un modo molto semplice sarebbe quello di aggiungere alcune precisazioni all’articolo 70 della L. 633:
È sempre lecito un uso didattico o culturale, formativo o informativo, parziale o integrale di opere tutelate dal diritto d’autore, alle seguenti condizioni: che l’opera non venga alterata o modificata in modo da pregiudicare la paternità del suo autore; che pur in presenza di alterazioni o modificazioni si possa sempre e comunque risalire all’originale integro; che lo scopo dell’utilizzo sia manifestamente privo di alcun fine di lucro; che venga sempre citato il legittimo proprietario dell’opera in oggetto; che venga riportato, quando necessario, il nome della sede in cui l’opera è collocata, onde poterla identificare in maniera certa.
È fatto obbligo all’utilizzatore di tali opere indicare che la licenza in cui intende distribuirle o farle pubblicamente fruire è del tipo copyleft: “Proprietà Comune Creativa”.
Tale licenza ha effetti legali in tutti i paesi che la riconoscono.
Con l’espressione “assenza di fine di lucro” s’intende che la fruizione integrale dell’opera deve restare assolutamente gratuita e non può essere in alcun modo vincolata all’utilizzo di qualsivoglia forma di pubblicità.