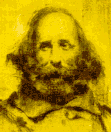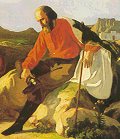LE AVVENTURE DELL'AUTOBIOGRAFIA
quando la vita è un romanzo
INTRODUZIONE ALL'AUTOBIOGRAFIA
Memorie risorgimentali: D'Azeglio e Settembrini
Più vario se non complesso sembra l’intento narrativo di Massimo D’Azeglio, autore dei Miei Ricordi (1867), dopo aver vissuto intensamente come pittore, romanziere (Ettore Fieramosca) e uomo politico.
|
Con i Miei Ricordi abbiamo varcato la metà del secolo e siamo entrati nella prima fase post-risorgimentale per approdare a un tipo di autobiografia dal linguaggio piano e scorrevole, dall’interesse memorialistico, cioè volto alla narrazione degli eventi storici (si vedano le pagine sui moti del '48 e sulla politica di Cavour), ma anche dall’affabile e vivace rievocazione narrativa degli anni della giovinezza trascorsi nei Castelli romani a colloquio con il Sor Checco Tozzi, non meno che con Carluccio caffettiere. |
Ormai il modello alfieriano di un’autobiografia volta a celebrare l’individuo senza radici, unico ed eccezionale, deve cedere all’apologia degli ideali della propria generazione che si conclude nella presentazione degli eroi del suo tempo. Tale galleria riproduce nella varietà degli esempi lo stesso modello di virtù riconosciuto nel padre Cesare D’Azeglio.
Quanto in D’Azeglio si trova di moderato, di ottimisticamente burbero si trasforma nelle Ricordanze della mia vita del Settembrini in una sorta d'insofferenza per il nuovo Stato unitario. Ma siamo passati da un moderato come D’Azeglio ad uno schietto democratico come Settembrini, per il quale l’idea risorgimentale affonda nel ricordo del padre, vittima della repressione del 1799, fino a quello non meno remoto della coccarda tricolore regalata al piccolo Luigi durante i moti del 1820.
Il profilo dell’uomo romantico accorato in Pellico, più riflessivo in D’Azeglio, diventa nelle pagine del Settembrini più acceso e accentuato, fino a fargli dire che un uomo che nella sua vita non abbia commesso delle corbellerie, che non abbia desiderato almeno una volta di farsi prete o di ammazzarsi, non può essere considerato suo amico e quindi, si arguisce, suo lettore.
Ricordi, rimpianti e rammarico sembrano costituire la scansione di una scrittura autobiografica che si arresta alle soglie del presente, che vede l’autore senatore del regno, ma anche per nulla fiducioso nel futuro. Sembra che egli preferisca fare emergere nelle Ricordanze il volto della giovinezza ancora ammirato di quei giorni d’amore e di speranza .
L'autobiografia in guerra: ricordi garibaldiniIl tema della giovinezza e quello della guerra si sposano nelle memorie garibaldine. Si tratta di una memorialistica dal successo editoriale ampio e cospicuo negli anni che seguirono l’unificazione del paese.
| Il racconto dell’io si diffonde nell’epos, la riflessione personale si allarga ai momenti della spedizione militare nel Regno delle Sicilie e in altri luoghi del mito garibaldino. Le voci narranti sono soprattutto quelle di Cesare Abba, Da Quarto al Volturno, noterelle di uno dei Mille, di Giuseppe Bandi, I Mille da Genova a Capua e di Eugenio Checchi, Memorie di un garibaldino. |
|
|
L’eco di una patria ancora tutta letteraria sembra rivivere in queste testimonianze insieme ad elementi di narrazione del tutto realistici, che ritraggono i giovani protagonisti in situazioni quasi inconsapevoli del destino che si sta compiendo. Basti pensare alla descrizione della cena di Talamone, in cui si vede la moglie di Crispi vestita in dimessi panni giocare a scopa con l’antico parroco Gusmaroli, o dove si annota lo stesso futuro ministro abbigliato con uno spronchette stretto stretto che mostrava le corde. Altre volte l’apparizione di un evento inatteso, come l’incontro con un branco di festosi delfini serve al narratore per mettere in luce lo stato d’animo dei soldati, oscillante tra la gioia più infantile per quello spettacolo insolito e la superstizione per il presagio che quella vista potrebbe procurare. (Giuseppe Bandi, I Mille) |
Scritti con uno stile già giornalistico ma non a ridosso degli eventi, a volte pubblicati a puntate sui giornali, questi testi sono redatti non di rado in modo veloce e paratattico per rendere il ritmo incalzante di eventi che si succedono gli uni agli altri, senza altro collegamento che la necessità della guerra e l’urgere della storia.
| Nella frenesia delle tappe della spedizione domina la figura del condottiero, il mitico eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi. Sembra che i narratori distinguano tra il luogotenente efficace ma talvolta brutale e il mitico generale che riesce ad imporre il silenzio con il solo carisma della sua presenza, che appare nei momenti critici della vicenda per ottenere dai soldati il massimo della loro energia. |  |
Agli ordini ripetuti e sferzanti, alle orrende minacce di Bixio fanno eco le poche parole con le quali il generale conduce la guerra. Il rapporto con il condottiero diviene quasi mistico nelle conclusioni dell’autobiografia di Abba. Alla vigilia del "rompete le righe" l’autore descrive il generale nell’atto di passare in rassegna le truppe con l’espressione pallida e crucciata di chi a stento trattiene il pianto. Chi scrive sembra volere essere testimone di una volontà ultima che è insieme quella del generale e dei soldati, cioè la delusione per non avere portato a termine l’impresa, per essersi piegati alle ragioni di Stato, alla pressione politica delle potenze europee e del Piemonte.
Il condottiero non smette di esserlo, neppure quando, come nella battaglia di Bezzecca, debba scendere da cavallo e ferito condurre la battaglia da una carrozza. (Ernesto Checchi, Memorie di un garibaldino) Il disordine, l’approssimazione caotica dei volontari all’ordine di battaglia riceve forma dal passaggio dell’anziano generale che viene a compiere nella battaglia la grande impresa risorgimentale.
| L’autorità del generale s'impone da sola insieme allo sguardo strategico sulla battaglia, insieme al superiore coraggio che sembra scaturire nel cuore dei volontari che assistono al suo passaggio. Più tarde sono le memorie del pittore garibaldino Nino Costa, Quel che io vidi e quel che io intesi, scritte tra il '92 e il '96, ma pubblicate soltanto nel 1926, ormai postume. |
|
Scritta da uno spettatore di eventi ai quali egli stesso afferma di aver partecipato, mai da comprimario, l’autobiografia partecipa con il suo ricordo alla grande epopea risorgimentale, soffermandosi nelle giornate della repubblica del '48. Il realismo a volte grottesco delle descrizioni di un autore, che dichiara di vedere attraverso l’io, si unisce a considerazioni di cittadino ormai moderato, quando osserva che la grandezza di Garibaldi fu quella di aver sgombrato con la sua partenza la città da un folto numero di facinorosi. Ma siamo ormai al culmine di un processo narrativo e forse anche ideologico in cui il generale è passato da eroe fondatore dell’Italia a saggio tutore dell’ordine pubblico.
![]()