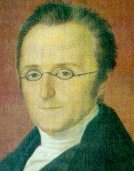LE AVVENTURE DELL'AUTOBIOGRAFIA
quando la vita è un romanzo
INTRODUZIONE ALL'AUTOBIOGRAFIA
Le avventure dell'autobiografia in Italia
Anche dal punto di vista storico, le funzioni del genere romanzo e del genere autobiografia sembrano intrecciarsi, sicché quando in Italia non è ancora matura l’affermazione del primo, nella complessità della sua accezione moderna, il secondo sembra svolgere un vero e proprio ruolo di supplenza.
Il tessuto narrativo delle autobiografie di fine secolo, ricco di molteplici intrecci e situazioni evocative, prepara il terreno al romanzo, che ancora nel Settecento risente sia delle suggestioni della tragedia (tale il caso delle Avventure di Saffo poetessa di Mitilene di Alessandro Verri, autore neoclassico suggestionato dalla visione archeologica della natura e della poesia), sia delle necessità di conformarsi alle esigenze di lettori che preferiscono il racconto avventuroso, quando non scopertamente licenzioso, come nel caso dei romanzi L’attrice e l’amor militare del veneziano Antonio Piazza.
L’ambientazione realistica degli avvenimenti e dei personaggi, l’interesse per le sfumature psicologiche del carattere, il piacere di raccontare con descrizioni minutamente esatte aspetti altrimenti censurati della vita privata, ma anche la stessa apertura alla cornice storica dell’Europa e degli eventi che l'attraversano, trovano posto nell’autobiografia quando ancora il romanzo italiano sembra prediligere contenuti o troppo letterari o troppo licenziosi e comunque non adatti a formare il gusto complesso dei lettori della narrativa moderna.
Va però precisato che questa funzione sostitutiva del romanzo viene svolta dall’autobiografia in concomitanza della commedia, trasformata in senso realistico dalla riforma goldoniana. Poiché all’improvvisazione delle maschere della commedia dell’arte è stata sostituita la regia di una vera e propria sceneggiatura, dalla quale prendono vita personaggi e situazioni ricavati dallo studio della società settecentesca, la commedia si trova a fornire al pubblico una rappresentazione non lontana dall’intento di critica e di satira che il romanzo mette in atto nei confronti del mondo che porta alla luce sulla pagina.
Un pubblico come quello del Settecento, abituato al successo delle commedie goldoniane, giunte ad avvicinarsi al romanzo nel respiro ampio della trilogia, trova, forse per paradosso, proprio nelle memorie dei suoi migliori uomini di teatro la strada verso il romanzo, identificato come il luogo d'una rappresentazione della scena umana che, nella varietà di linguaggi e di stili, attribuisce ad ogni personaggio, ad ogni visione del mondo uno specifico accento. E del mondo il genere romanzo diventa il racconto privilegiato nel concerto a più voci che si apre alla poliedrica babele della realtà.
Memorie risorgimentali: PellicoE’ un fatto che il percorso dell’autobiografia è in qualche modo legato a quello biologico: la scrittura sembra aspettare la vita. Sicché all’inizio dell’Ottocento non sono pronte che le memorie degli uomini del secolo precedente: Alfieri, Casanova, C. Gozzi, Da Ponte.
|
Al grande rigoglio del genere succede una pausa, nell’attesa che una nuova generazione salga alla ribalta della storia e la viva per raccontarla. Nel frattempo però il romanzo italiano assume con Le Ultime lettere di Jacopo Ortis lo stile di una confessione che si riverbererà anche nel Sesto tomo dell’io e nelle Notizie intorno a Didimo Chierico: le altre opere a sfondo autobiografico del Foscolo. |
| Il silenzio è interrotto solo nel 1831 con la pubblicazione delle Mie prigioni del cospiratore antiaustriaco, Silvio Pellico. Il clamoroso rifiuto della politica nell’incipit dell’opera dichiara il favore per una storia intima, un esame di coscienza che conduce il prigioniero dai Piombi allo Spielberg lungo la traccia di una meditazione religiosa sul senso dell’esistenza. |
|
Eppure le riflessioni dell’internato, che sembrano sprofondare in un senso di creaturale abbandono a Dio, diventano, trasformando il patriottismo in un senso di superiore moralità, più eversive di ogni riflessione ideologica e rivoluzionaria.
Un nuovo modello antropologico ha sostituito l’avventuriero del Settecento. Al piacere della vita giocata con un azzardato lancio di dadi si è ormai sostituito l’uomo esemplare, che afferma i diritti del romanticismo melodrammatico, delle passioni purificate dall’etica della famiglia e della religione.
Non è un caso che l’autore delle Mie Prigioni sia anche quello di Francesca da Rimini, che l’autobiografo scriva recitando se stesso davanti al compassionevole ascolto del lettore. Proprio la disarmante nitidezza di cuore dell’eroe romantico fa apparire ancora più grave, ancora più terribile il sopruso ch'egli riceve da un governo nemico non solo della nazione italiana ma della pietà umana.
Il motivo sadiano della carcerazione viene riscattato a favore di una testimonianza che non si sofferma sulle sofferenze subite, perché vuole piuttosto intrattenere il lettore sugli insegnamenti che ne ha tratto. L’ideale pedagogico si rivela l’arma più potente a disposizione di un intellettuale del Conciliatore, ben consapevole di quanto la letteratura debba essere al servizio dell’umanità.
![]()