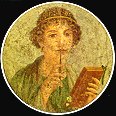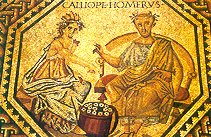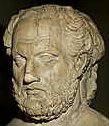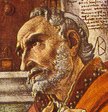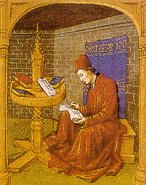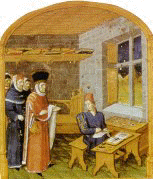LE AVVENTURE DELL'AUTOBIOGRAFIA
quando la vita è un romanzo
INTRODUZIONE ALL'AUTOBIOGRAFIA
Si dice che a volte il racconto di una vita può essere più avventuroso di quello di un romanzo, perché i suoi personaggi sono più veri e realistici, perché l’azione è maggiormente movimentata, perché le conclusioni sono in qualche modo più imprevedibili di quelle messe in atto da qualsiasi autore di successo.
|
Dall’antichità ad oggi gli uomini non hanno
smesso di raccontarsi, di percorrere a ritroso la trama della loro vita per riconoscere
magari il filo segreto, la connessione che collega avvenimenti da cui sono, mentre
scrivono, già lontani. Altre volte il piacere di denudarsi davanti al lettore prevale, per stupirlo con l’intreccio delle proprie azioni eroiche e turpi, sconcertanti ed esemplari. Apparentemente senza vergogna e con molta disinibizione, emerge la natura di straordinari personaggi, di situazioni avvincenti, scandalose o a volte noiose, come spesso è l’esistenza, del resto. |
Chi parla di se stesso nelle pagine di un diario o in quelle di un'autobiografia si specchia nella propria scrittura per riconoscersi, per assumere un punto di vista su di sé come se osservasse un altro. L’autore incontra il proprio eroe, con il quale ha sempre vissuto, per riconoscerlo, per giudicarlo, per difenderlo, per descriverlo mentre agisce. Un patto di complicità si stabilisce, un sodalizio fatto di ammiccamenti rivolti al lettore.
L'idea di vita esemplare: un breve percorso storico
| Prima che il racconto autobiografico, cioè la narrazione della propria esistenza scritta dall’autore protagonista, prendesse forma e consistenza e il parlare di sé avesse libero accesso alla grande letteratura, il resoconto delle vite celebri e il ricordo delle imprese eroiche erano affidati alla penna di letterati storici che, mescolando notizie accertate ad altre leggendarie, ritraevano, come sulla tela di un dipinto, le gesta di sovrani e guerrieri, sacerdoti e matrone. |
|
|
Fin dall’antichità classica, cioè dall’epoca greco-romana, la descrizione degli avvenimenti della vita dei grandi personaggi della storia ne propone il modello esemplare, dunque da imitarsi, e fa confluire la celebrazione di uomini e semidei nel canto della poesia antica, espressa dal greco Omero come dal latino Virgilio. |
| Poiché la ricerca storica si confonde con la letteratura e la religione, lo stile narrativo acquista, grazie a storici greci come Tucidide e Plutarco, e latini come Suetonio, la tensione di un dramma che rappresenta l’esistenza degli eroi nelle loro parole inclinate ora alla tragica vivacità del dialogo, ora elevate alla straordinaria forza espressiva del monologo. |
|
Lo storico è quindi prevalentemente poeta e scrittore, sebbene non manchino casi nei quali la sua osservazione si nutre di una maggiore presenza di documenti e valutazioni scientifiche, come avviene nell’opera di Cornelio Nepote e di Tacito, storici romani l’uno nell’età di Cesare l’altro in quella di Tiberio, rispettivamente autori del De Viris e De Vita Agricolae.
|
Quando poi il racconto storico interessi la contingenza politica, e il suo protagonista sia anche un grande letterato, la narrazione dei successi delle campagne militari si trasferisce nelle esigenze propagandistiche del De Bello Gallico e del De bello Civile di Giulio Cesare. Queste opere pur redatte alla terza persona contengono l’avvincente registrazione della volontà di potere del trionfatore della Repubblica romana, amplificata dal racconto propagandistico dei suoi successi militari. |
La memoria del sacro
|
Giunti in epoca cristiana, le Confessioni
di Agostino da Ippona, padre della chiesa antica e suo grande teologo, illustrano le tappe
della conversione religiosa mediante il colloquio con Dio svolto al cospetto del lettore. Nel momento in cui la vita dei discepoli del Vangelo diventa soprattutto imitazione di quella di Cristo, la scrittura delle confessioni si apre alla testimonianza della santità e per questo approfondisce la propria funzione di modello esistenziale. |
| Dalle Confessioni di S. Agostino hanno inizio le vite dei santi, che avranno grande fortuna letteraria fino al Settecento, sulla base di una narrazione volta a sostituire i meriti acquisiti negli eserciti e sul trono con quelli ottenuti al servizio di Dio. Ad esse compete, oltre il raggiungimento dei fini edificanti, il riconoscimento di avere aperto alla comunicazione letteraria il dialogo fra l’io della coscienza e il Tu rappresentato dalla verità durevole della parola del Dio. |
|
Dunque, le necessità di un colloquio con se stessi e il prossimo, sotto lo sguardo della parola del vangelo, inducono a superare l’imbarazzo e il tabù del parlare di sé come soggetti di una conversione che tutto il mondo deve conoscere per imitarne il percorso spirituale.
|
Nello stesso tempo, il racconto della Vita dei santi prosegue da un punto di vista esterno, cioè ad opera della penna di una terza persona, spesso un loro confratello o un discepolo. Si tratta in questo caso di biografie scritte per illustrare i detti edificanti, i miracoli e le opere degli uomini di Dio, così come avviene nei Fioretti di S. Francesco, propugnatore della povertà evangelica e dell’amore caritatevole e autore dello splendido Cantico delle creature. |
Memorie di lavoro e d'arte
| Sempre nel Medioevo, ma su un piano assai più terreno, i mercanti imparano, con la stesura di libri di ricordi, l’uso di trasmettere, a vantaggio dei discendenti, il risultato della loro esperienza, spesso legata a viaggi in paesi lontani. In questo senso, essi forniscono in prima persona una testimonianza della propria esistenza fondata sulla gestione del patrimonio e della ricchezza. |
|
|
Ai libri di famiglia, volti a trarre le fila della storia del casato, rinserrando il rapporto con i discendenti, si affiancheranno durante il Rinascimento, i diari di bottega degli scultori e pittori. Basti pensare nella Toscana, fra il Quattro e Cinquecento, a quel senso di consapevolezza artistica che emerge dal Memoriale di uno scultore come Baccio Bandinelli o dal Diario di un pittore manierista come Pontorno. |
| La riflessione sulla propria esperienza artistica ritorna nella Vita dello scultore toscano Benvenuto Cellini, a sottolineare con accento, nello stesso tempo eroico e domestico, il momento della realizzazione delle sue grandi opere. E’ memorabile e straordinaria la scena della fusione del Perseo, in cui la tensione creativa si risolve nel vorace appetito che fa divorare allo scultore un grande piatto di insalata, così come Michelangelo, dopo aver scolpito la Pietà, si mangiò volentieri una frittata. |
|
In realtà, l’autobiografia del Cellini si presenta come un racconto molteplice, in grado di alternare la descrizione di momenti di intensità religiosa con altri dove il protagonista veste piuttosto i panni dell’eroe avventuroso e del furfante, ma anche dell’omicida.
![]()