LA GRECIA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Storia ed evoluzione della Grecia classica
Trasformazioni delle poleis in età tardo-classica ed ellenistica
(IV - II secolo a. C.)
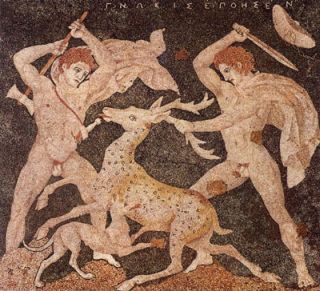
Si è già visto come le "classi medie" costituissero la scaturigine più profonda, nonché il vero pilastro dei sistemi di governo sorti in epoca classica, sistemi tutti fondati - quali più e quali meno - sul ridimensionamento dei poteri politici (ed economici) dell'antica nobiltà latifondista, e sull'affermazione - anche se certo non ovunque egualmente netta - dei valori di libertà individuale e di partecipazione attiva alla vita politica della propria comunità da parte di tutti i cittadini. Tra tali sistemi, la forma più estrema era rappresentata senza dubbio dalle democrazie, diffusesi dapprima in Asia Minore (nonché più in generale nelle colonie) e in un secondo tempo nella stessa Grecia europea (…e in primo luogo, nella città di Atene).
Non fu un caso quindi, se il declino dei ceti medi (sia urbani, che agrari), in seguito a un nuovo formarsi di gruppi di potere 'aristocratici', ovvero di nuove élite economiche e politiche (peraltro stavolta non solo agrarie, ma anche cittadine ed affaristiche) decretasse, seppure spesso in una forma non esplicita, la decadenza morale e sostanziale delle strutture politiche affermatesi nei secoli precedenti, cioè in età classica.
A partire soprattutto dal quarto secolo difatti, non di rado ripresero vigore in Grecia forme di governo arcaiche o comunque fondamentalmente regressive: e cioè le antiche oligarchie (che però - va ricordato - anche in età classica erano estremamente diffuse) e le tirannidi.
Certo, più che di un ritorno aristocratico (ovvero ad un tipo di dominio fondato, oltre e prima che sul possesso fondiario, sulla discendenza nobiliare) si ebbe qui una trasformazione della società, almeno nei suoi aspetti principali, in senso plutocratico - verso un sistema cioè, nel quale i cittadini più ricchi esercitavano un potere sostanziale sempre crescente, a dispetto delle altre classi sociali (medie e basse).
Non era più insomma il 'sangue', quantomeno in prima istanza, a determinare il potere individuale, bensì la semplice ricchezza patrimoniale! In ogni caso, erano oramai i grandi interessi economici - peraltro sempre più evidentemente prevalenti - a costituire le molle fondamentali della vita politica e decisionale interna agli stati, cosa che limitava chiaramente l'influenza dei rimanenti cittadini.
Ma la decadenza politica dei ceti medi, delle loro concezioni e 'ideologie', e delle istituzioni che ne erano espressione, non poteva essere che il riflesso di un loro parallelo declino sul piano sociale ed economico.
D'altra parte, i fattori alla base della lenta e graduale elisione a livello economico delle classi medie furono senz'altro svariati, e proprio per tale ragione (oltre che per la scarsa quantità di notizie, sia dirette che indirette, in nostro possesso…) anche molto difficili da definire.
E' un fatto in ogni caso, che tra la fine del quinto e nel corso di tutto il quarto secolo tanto la piccola proprietà terriera, quanto le piccole e medie imprese commerciali e artigiane cittadine conobbero un lento ma inarrestabile declino, e ciò in favore ovviamente dei loro omologhi "ricchi".
Alla base del primo fenomeno - quello cioè dell'assorbimento di buona parte dei piccoli appezzamenti indipendenti all'interno delle più vaste proprietà nobiliari, o comunque in quelle dei cittadini più ricchi - vi furono molto probabilmente prima le Guerre peloponnesiache, e - in seguito alla fine di queste ultime, nel 404 - l'endemica situazione di conflittualità e il continuo stato di guerra e di insicurezza (dovuto appunto allo smantellamento dei precari equilibri politici e militari precedenti tali guerre) che dilaniarono le città-stato soprattutto della madrepatria.
Certo anche i grandi proprietari soffrivano per le continue guerre, le quali infatti coinvolgevano altrettanto spesso le loro proprietà rispetto a quelle dei loro concittadini più poveri. Tuttavia, a differenza di questi ultimi, essi disponevano - oltre che di più vaste terre coltivabili - anche di una maggiore quantità di forza-lavoro schiavile, e di fondi molto più ingenti a livello finanziario.
Per tali ragioni, essi furono meno colpiti dalle devastazioni e dalle guerre rispetto ai proprietari più "poveri", i quali quindi si dovettero spesso rivolgere a loro per ricevere aiuti e prestiti, che rafforzavano tuttavia sempre di più i vincoli che li legavano alle grandi proprietà agricole (in un modo peraltro non del tutto dissimile - seppure ovviamente in forme nuove - a quanto già era avvenuto in epoca arcaica).
Del resto - come è facile immaginare - il processo di elisione della piccola proprietà era in parte anche un fatto autonomo rispetto ai fattori appena citati, legati all'esasperata conflittualità diffusasi in Grecia a partire dalle Guerre peloponnesiache.
Anche in una condizione di pace infatti la vita era più dura per i piccoli e medi proprietari - decisamente più esposti ai rovesci della sorte - che non per quelli più facoltosi. Il problema della proprietà agraria difatti (ovvero dei suoi dislivelli), accompagnò - in forme ora più e ora meno esasperate - un po' tutta la storia greca, e viene oggi definito "questione agraria". (4)
In ogni caso, fu a partire soprattutto dal quarto secolo che il fenomeno della contrazione dei piccoli appezzamenti terrieri iniziò a divenire davvero drammatico, e ciò con la conseguenza di riportare la Grecia - seppure, chiaramente, solo in parte - a una situazione simile a quella del periodo (arcaico) precedente l'instaurazione dei regimi democratici e più in generale delle poleis dell'età classica.
Tutt'altro tipo di cause furono invece probabilmente quelle alla base del declino della piccola imprenditoria cittadina.
Qui, al contrario che nelle campagne, non vi fu dopo il 404 alcun tipo di "emergenza economica". Le forze capitalistiche e commerciali difatti, si andarono sviluppando costantemente anche nelle poleis della madrepatria, senza risentire (quantomeno in modo sostanziale) degli esiti del recente conflitto. Atene per esempio, da sempre il principale centro dell'economia marittima greca, seppure in tali anni vedesse fortemente ridimensionate - e inizialmente anche annullate - le sue alleanze e le sue influenze politiche sulle altre città-stato dell'Egeo (molte delle quali erano peraltro originariamente colonie commerciali), continuò comunque a svolgere un ruolo di primaria importanza per le merci che dalle zone orientali (Propontide e Anatolia) transitavano verso quelle occidentali delle Grecia.
Il commercio insomma, e le attività a esso annesse, non conobbero negli anni in questione alcun declino, bensì al contrario un ulteriore sviluppo.
Ma quale fu allora, la causa dell'elisione e dell'assottigliamento - anche in questo frangente - delle classi medie e piccole in favore di quelle più ricche e potenti?
Causa di ciò fu forse la logica stessa della concorrenza, la quale ovunque col tempo finisce per favorire di solito le imprese più ampie - capaci di maggiore produttività, dotate di risorse finanziarie più cospicue… - rispetto a quelle più modeste. Al periodo d'oro dell'imprenditoria (quello cioè maturato nei primi secoli dello sviluppo commerciale) seguirono insomma anni di maggiore saturazione dei mercati e di più esasperata competitività: un fattore che ovviamente, non poteva non favorire le imprese più solide a dispetto di quelle di più modesta entità!
Resta il fatto però, che la Grecia rimase ancora per alcuni decenni il principale crocevia delle merci transitanti tra l'oriente caucasico e mediorientale e le zone occidentali della Grecia e delle vicine regioni balcaniche: ragion per cui le attività affaristiche e mercantili continuarono nel corso più o meno di tutto quarto secolo a prosperare, conservando alle città-stato greche un consistente afflusso di ricchezza e mantenendone ancora piuttosto alto il tenore di vita.
In complesso dunque, se da una parte nel quarto secolo il mondo greco vide effettivamente un assottigliamento delle classi medie in favore di nuove élites economiche e politiche, dall'altra esso conservò tuttavia quell'antico ruolo di centralità economica che già aveva avuto in passato - una cosa che gli permise di mantenere, oltre a un certo livello economico, anche una consistente presenza intermedia tra i "grandi plutocrati" (agrari e/o cittadini) e le classi più povere.
La grande stagione democratica era in ogni caso ormai giunta al termine, e i sistemi dell'epoca classica (anche peraltro - ed anzi soprattutto - quelli più aperti alla modernità) andavano oramai trasformandosi in una direzione sempre più "populistica" : da un parte cioè verso una condizione di potere sempre più apparente della maggioranza (assecondata peraltro nelle sue richieste, laddove possibile, dall'assistenzialismo dello Stato!), e dall'altra verso un accentramento dei poteri decisionali reali nelle mani delle nuove élites fondiarie e borghesi, coadiuvate inoltre da una nuova classe di 'politici di professione' che ne era in sostanza un mezzo.
Ma il declino sostanziale - seppure non apparente: in epoca ellenistica infatti, molte città-stato si diedero una costituzione democratica! - dei sistemi politici sorti in epoca classica proseguì ancora nei decenni e nei secoli successivi.
Il declino dei traffici difatti, dovuto allo spostamento dell'asse dei commerci verso il sud del Mediterraneo (l'isola di Rodi, ad esempio, divenne nell'Ellenismo un centro politico ed economico di primissimo piano) determinò anche quello dell'economia delle stesse regioni greche.
E seppure i Greci continuarono spesso a dar prova delle proprie mirabili qualità intellettuali, i loro migliori cervelli (anziché restare nelle proprie terre d'origine) si spostarono di solito verso altre e più ricche regioni, in cui essi sapevano che le loro prestazioni avrebbero ricevuto maggiori compensi e acquisito maggiore risonanza.
Era questo, ovviamente, l'effetto imprevisto del formarsi di una vasta classe affaristica anche nei circostanti stati asiatici - ciò che era poi una conseguenza dell'esportazione, da parte dei greci stessi , del proprio stile di vita in terre lontane!
L'impoverimento delle città-stato greche poi, ebbe come inevitabile conseguenza l'ulteriore recrudescenza dei dislivelli economici già formatisi nel IV secolo nonché, di conseguenza, un indebolimento ulteriore della reale capacità di comando del 'popolo minuto' all'interno delle città-stato.
Con tutto ciò tuttavia, sarebbe errato pensare che i mutamenti determinatisi - tanto a livello sociale, quanto a livello politico e costituzionale - durante la grande stagione classica, compresa tra VI e IV secolo, scomparissero nel nulla con il declino e con la fine di quest'ultima.
Al contrario difatti, un tale periodo aveva impresso all'ambiente sociale e culturale del mondo ellenico (e peraltro non solo ad esso…) dei cambiamenti che, almeno fino alla fine della dominazione romana, sarebbero rimasti, seppure - come si è appena mostrato - in forme decisamente attenuate rispetto al passato, fondamentalmente incancellabili.
(4) Ma la "questione agraria" non fu un problema che riguardò soltanto la Grecia, bensì più in generale l'intero mondo privatistico occidentale. Anche Roma, ad esempio, fu funestata sempre dalla frequente richiesta di terre dei ceti medi e bassi: e ciò spesso in conseguenza di conflitti di lunga durata che, impedendo a coloro che dovevano curare personalmente le proprie terre di svolgere le proprie mansioni, riducevano queste ultime in uno stato davvero miserevole affamandone i proprietari. (torna su)