LA TRAGEDIA DELLE
BACCANTI
|
|
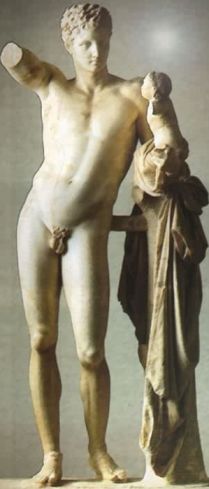
CONSIDERAZIONI SU EURIPIDE 1-2-3
Anche Euripide, come gli altri due grandi tragici che lo hanno preceduto, deve essere considerato un “educatore della società”, benché nel suo teatro ci sia una trasformazione sostanziale rispetto al passato: dal punto di vista formale la struttura della tragedia non subisce alcuna modificazione, ma mentre l’evento mitico era al centro del teatro di Eschilo e Sofocle, conformemente alle versioni tramandate dalla tradizione, con Euripide invece il mito viene considerato un’elaborazione dei poeti e non parte fondamentale della religiosità greca (basti ricordare che la rappresentazione stessa era considerata un rito sacro), e quindi il mito viene utilizzato come mezzo per rappresentare i problemi e le tematiche profane, quotidiane, su cui era necessario riflettere.
Euripide intende affrontare i problemi dell’uomo esclusivamente in termini umani, ma essendo la tragedia una rappresentazione "religiosa", egli non poteva non coinvolgere gli aspetti mitici, ch'erano appunto quelli della religiosità dominante: e così il dio viene confinato nel prologo o nell’esordio, facendo in modo che la vicenda si svolga senza il suo intervento (a volte il mito viene usato proprio per contestare la religiosità, come nel prologo di Afrodite nell’Ippolito).
Euripide vede nell’azione dei suoi personaggi il risultato di un processo psicologico: si interessa dell’interiorità dei suoi personaggi, che non si identifica con l’interezza morale, come nel teatro di Sofocle, ma è caratterizzata da un conflitto tra la ragione e la componente irrazionale. Questo conflitto è elemento di tragedia insito nell’uomo, al punto che ci si chiede se l’uomo sia causa di ciò che fa o non piuttosto vittima delle sue azioni. La componente dominante è quella irrazionale: la ragione arriva a comprendere ma non è in grado di evitare che si compiano errori.
Questa introspezione psicologica dà origine all’imborghesimento del mito: anche gli eroi vengono disegnati con i conflitti e le passioni proprie di tutti gli uomini; il suicidio non è più considerato come affermazione di sé ma come via di fuga (l’Aiace di Soflocle si uccide per affermare il suo valore, Fedra invece perché è di fronte a una realtà a cui non trova soluzione).
E’ assente in Euripide l’idea di giustizia, di un dio che intercede in favore del più debole. La vicenda umana è regolata dal caso, per cui ha senso solo il cercare una dignità astratta dell’uomo, fine a se stessa. C’è una grande apertura nei confronti di tutti gli uomini, poiché tutti sono accomunati da un destino costretti a condividere.
In tal senso Euripide è molto distante dal pensiero di Socrate: con le sue opere dimostra che conoscere il bene non spinge necessariamente al bene. I personaggi euripidei alternano momenti di lucida analisi in cui si esprimono in termini razionali e filosofici, a momenti di totale soggezione alle forze irrazionali.
Il prologo diventa espositivo: un personaggio racconta l’antefatto, la situazione e la conclusione della vicenda per far conoscere agli spettatori le modifiche al mito o anche perché è confinata in questo punto l’azione del dio.
Il deus ex machina interviene spesso nelle tragedie di Euripide ma non porta ad un finale risolutivo: il conflitto tragico infatti è ineliminabile.
Il coro assume un ruolo diverso: è un accompagnamento lirico che esprime compartecipazione ai dolori dei personaggi, ma non ha più il compito di analizzare la vicenda (cosa che fanno gli stessi personaggi).
