TEORICI
Politici Economisti Filosofi Teologi
Antropologi Pedagogisti Psicologi Sociologi...
Vico: matematica o retorica, scienze sempre più separate
o loro ricomposizione unitaria in una nuova filosofia?
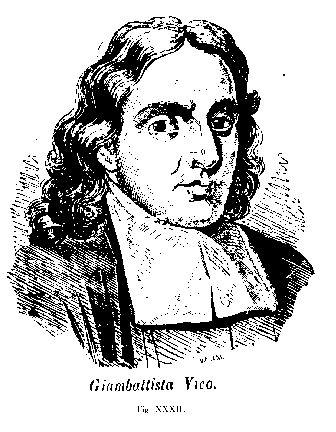
Giuseppe Bailone “Quelli
che hanno separato sia dalla filosofia sia tra di loro le arti e le
discipline – che non soltanto erano tutte comprese nel grembo
della filosofia, ma tutte insieme – mi paiono esser stati
simili a tiranni che, impadronitisi di una città nemica quanto
mai estesa, ricca e popolosa, per esserne al sicuro da allora in poi,
distruggono la città e disperdono i cittadini per villaggi
molto lontani: affinché essi non confidando più nella
magnificenza e nelle ricchezze della loro città e nel numero
dei loro, non possano sollevarsi d’animo, né cospirare,
né essere d’aiuto agli altri”.1 Vico
sta facendo l’orazione inaugurale dell’anno accademico.
Questo compito tocca a lui, perché è professore di
eloquenza, e pertanto, come spiega nella parte conclusiva
dell’orazione, deve essere “istituzionalmente abbastanza
dotto in tutte le scienze e le arti per spronare nell’orazione
annuale la gioventù studiosa ad impegnarsi in ogni genere di
studi e di arti”.2 L’orazione
è però molto di più di un’esortazione allo
studio: l’immagine dei tiranni che hanno frantumato la cultura,
collocata nel bel mezzo del discorso, dice quanto sia critica la sua
posizione nei confronti dell’organizzazione degli studi del suo
tempo e quale sia l’impegno teorico che si assume. Il
titolo, De
nostri temporis studiorum ratione
(Sul metodo di studio dei nostri tempi), e la domanda iniziale,
“Quale
metodo di studio è più corretto e migliore, il nostro o
quello degli antichi?”,
collocano questo discorso all’interno nel dibattito, allora
vivo, sul primato degli antichi o dei moderni. Presto, però,
il confronto fra i due metodi di studio si approfondisce e diventa
esame delle possibilità e dei limiti della conoscenza umana. L’orazione
si apre con la citazione del De
augmentis scientiarum
(Sugli avanzamenti delle scienze), ”l’aureo libretto”
di Francesco Bacone, insieme alla denuncia delle sue “smisurate
ambizioni”, e si chiude con il consiglio dello stesso Bacone
“che i giovani siano tenuti lontano dagli studi di eloquenza,
finché non hanno compiuto l’intero ciclo di studi”.
Infatti, “che altro è – spiega –
l’eloquenza, se non la sapienza, che parla in modo elegante,
con abbondanza e in modo appropriato al senso comune?”3 Vico
apprezza questa definizione dell’eloquenza di uno dei suoi
quattro autori, ma scrive che Bacone “si è comportato
nel campo degli studi in modo analogo ai dominatori degli imperi più
potenti nelle questioni pubbliche, i quali, giunti al massimo potere
sul genere umano, tuttavia si sforzano, sebbene vanamente di
tormentare con le loro grandi opere la natura stessa: lastricare i
mari con le pietre, veleggiare tra le montagne, ed altre imprese
vietate per natura. Mentre invece tutto ciò che all’uomo
è dato conoscere è, al pari dell’uomo stesso,
finito ed imperfetto”.4 Quanta
arroganza e quanta presunzione! Vico
conosce bene i vantaggi del nuovo sapere, tanto esaltato da Bacone,
il filosofo del motto “sapere è potere”. Li elenca
con ammirazione. Sono magnifici, ma l’uomo sta perdendo il
senso della misura: può bensì “tormentare la
natura”, ma ha perso la saggezza che viene solo dall’unitarietà
del sapere; deve rientrare nei limiti che lo costituiscono, tornare a
occuparsi di se stesso, realizzare il sapere che è alla sua
portata e ricomporlo in unità. In
Grecia “un solo filosofo corrispondeva ad una università
degli studi perfettamente compiuta”; i Romani non avevano
bisogno delle università, “poiché collocarono la
sapienza nella sola giurisprudenza”. Oggi, invece, “una
qualsiasi arte e scienza è diventata talmente difficile, che
un singolo è a stento sufficiente per insegnarne una sola.
Pertanto presso di noi sono state istituite le università
degli studi e organizzate in ogni genere di disciplina, nelle quali
gli uni insegnano una disciplina, gli altri un’altra, ciascuno
preparatissimo nella propria. Ma a questo vantaggio si contrappone
quello svantaggio, consistente nel fatto che le arti e le scienze,
che la sola filosofia comprendeva come in un unico respiro, oggi sono
distinte e divise. […] E l’insegnamento di esse è
talmente disordinato e spesso a rovescio che, per quanto vi siano di
dottissimi nelle parti, tuttavia nell’insieme, che è il
fiore della sapienza, non sono saldi”.5 È
necessaria una nuova filosofia, unitaria come quella degli antichi. Vico
incomincia a costruirla con questa esortazione ai giovani. “Oggi
– scrive Vico – si guarda ad un solo fine di tutti gli
studi, uno solo si tratta con riguardo, uno è da tutti
celebrato: la verità”.6 Questo
fine è sicuramente apprezzabile, ma la verità è
il punto d’arrivo, non di partenza del processo conoscitivo e
di studio. Vico
rovescia Cartesio e il primato della critica e del rigore razionale,
modellato sulla matematica, che il suo metodo ha imposto. “Oggi
iniziamo gli studi dalla critica: la quale, per mondare il suo primo
vero non solo da ogni falsità, ma anche da ogni sospetto di
falsità, prescrive che i secondi veri e tutti i verisimili
siano respinti dalla mente come fossero falsi. Ma in modo
svantaggioso: infatti, negli adolescenti si deve formare quanto prima
il senso comune, affinché giunti nell’età delle
occupazioni non se ne escano in stranezze ed insolenze. Ma, come la
scienza si origina dal vero, l’errore dal falso, così il
senso comune nasce dal verisimile. Ed
infatti le cose verisimili sono per così dire intermedie tra
le vere e le false: come quelle che sono vere per lo più,
assai di rado sono false. Dunque, dovendo essere educato negli
adolescenti soprattutto il senso comune, si deve stare attenti che la
nostra critica non lo soffochi in loro. Inoltre il senso comune com’è
regola di ogni prudenza così lo è dell’eloquenza:
infatti, spesso gli oratori si affaticano più per una causa
vera, che non abbia niente di verisimile, che per una falsa, la quale
si basi su uno svolgimento credibile. Ragion per cui c’è
il rischio che la nostra critica renda gli adolescenti più
inadeguati nell’eloquenza. Infine i nostri critici collocano il
loro primo vero avanti, fuori, sopra ogni immagine corporea. Ma lo
insegnano agli adolescenti prima del tempo e con severità.
Infatti, come nella vecchiaia prevale la razionalità, così
nell’adolescenza prevale la fantasia: e davvero non è in
alcun modo opportuno nei giovinetti offuscare quella che è
sempre stata considerata l’indizio più felice
dell’indole futura. Ed è necessario che nei fanciulli, i
quali non eccellono in nessun altra facoltà della mente, sia
molto coltivata la memoria, la quale se non coincide con la fantasia,
è perlomeno quasi la stessa cosa: e non si devono ottundere
affatto gli ingegni rivolti ad arti nelle quali prevalgono la
fantasia o la memoria oppure entrambe, come la pittura, la poesia,
l’oratoria, la giurisprudenza”.7 L’abitudine
al ragionamento ponderato si raggiunge “gradatamente e con
dolcezza, in proporzione all’ingegno dell’età”. Purtroppo,
“al giorno d’oggi si celebra la sola critica; la topica
non solo non è permessa, ma è del tutto lasciata da
parte”.8
Con gravi inconvenienti: “infatti, come l’invenzione
degli argomenti precede per natura il giudizio rispetto alla loro
verità, così nell’insegnamento la topica deve
precedere la critica”. Se “la critica ci rende veritieri,
così la topica ci rende facondi”. Presi
da soli la critica e la topica hanno dei difetti: “Il metodo
dei topici, perché spesso afferrano il falso; il metodo dei
critici, perché non assumono anche il verisimile”. Vico,
quindi propone “che gli adolescenti vengano istruiti con
giudizio in tutte le scienze e le arti, affinché si
arricchiscano dei luoghi della topica, ed intanto si rafforzino nel
senso comune per la prudenza e l’eloquenza, nella fantasia e
nella memoria per le arti che spiccano per queste facoltà
della mente; imparino la critica, ed allora valutino daccapo con loro
proprio giudizio le cose nelle quali sono stati istruiti; e si
esercitino nelle medesime discutendo pro e contro. In tal modo,
infatti, risulterebbero veritieri nelle scienze, accorti nella
prudenza delle cose, facondi nell’eloquenza, ricchi di
immaginazione nella poesia e nella pittura, di buona memoria nella
giurisprudenza. Ed oltre a ciò sarebbe sicuro che non
diventerebbero avventati, come chi disputa intorno alle cose mentre
le sta imparando; né religiosi in modo distorto, come chi
ritiene che niente sia vero se non è dettato da un maestro”.9 Gli
svantaggi del metodo moderno sono molti: l’introduzione del
procedimento geometrico in fisica non solo “spegne il gusto di
contemplare più a fondo la natura”, riducendone lo
studio ai soli aspetti geometrizzabili, ma presenta come vero, “in
forza del procedimento geometrico” cose che “non sono se
non verisimili”; “ottunde le facoltà di parlare
con acume e con eleganza”; in particolare “poiché
questa fisica, sia mentre la si impara sia una volta appresa,
inferisce sempre i prossimi dai prossimi, ottunde negli uditori
quella facoltà che è propria dei filosofi, cioè
il vedere qualità simili in cose di gran lunga lontane e
diverse: ciò che è considerato la sorgente e l’origine
di ogni forma acuta ed elegante del parlare”. Il
modello geometrico delle lunghissime catene di ragionamenti a
piccolissimi passi, di uguaglianza in uguaglianza, che tanto seduce
Cartesio, per Vico, applicato in fisica e nelle altre scienze,
ottunde le facoltà filosofiche. “Il
sottile non è il medesimo dell’acuto: infatti il sottile
consta di una linea, l’acuto di due. Nell’acuto parlare,
del resto, la metafora, che è l’abbellimento al massimo
grado insigne ed il più splendido ornamento di ogni discorso
elegante, occupa la posizione più importante. Ma anche per un
altro motivo quelli che sono abituati a questo genere di discussione
sono meno adeguati all’eloquenza. Infatti l’eloquenza è
predisposta soprattutto per la moltitudine inesperta: e gli uomini
inesperti, soprattutto quando vola
irrevocabile la parola10,
molto difficilmente afferrano queste lunghe catene di ragionamenti
[…]. Perciò al loro cospetto è necessario
ricorrere a quella libera ed ampia forma del parlare, in virtù
della quale l’oratore ora dimostri, ora si allontani, ora torni
all’argomento; e ciò che ha detto in modo più
rude, rifinisca; ciò che ha detto più succintamente,
estenda, ed indugi nella stessa cosa con altre ed altre figure del
discorso, affinché l’uditore avendola profondamente
impressa nell’animo la faccia propria”.11 Anche
nelle altre scienze il nuovo metodo comporta svantaggi. Vico esamina
quelli dell’analisi ed esprime il dubbio che essa sia utile
alla meccanica. Esamina gli effetti negativi del nuovo metodo nella
medicina: “Noi, credendo di conoscere con sufficiente sicurezza
le cause delle malattie, non prestiamo attenzione sufficiente ai
sintomi e formuliamo diagnosi regolarmente. Nelle quali cose, poiché
gli antichi erano superiori ai nostri, la loro via ed il loro metodo
di cura era senza dubbio più sicuro. Infatti, forse perché
le cause apparivano loro piuttosto nascoste ed incerte, erano
solleciti e desiderosi di sapere fino allo scrupolo solo ciò
che potevano ammettere e dimostrare, persuasi da lunga osservazione;
dai sintomi giudicavano non tanto le cause delle malattie, quanto la
gravità e l’avanzamento, in direzione del sicuro
tracciato della terapia”.12
Gli antichi, “credendo più facile preservare la salute
del corpo, come gli altri beni, che ristabilirla una volta corrotta,
prestavano attenzione a quei segni con cui la natura sana facesse
cenno della futura malattia, perché potesse essere prevista ed
evitata […]. Sempre infatti, prima di cadere in malattia, la
natura preannuncia la futura rovina con qualche sintomo”. I
medici moderni, invece, spesso dicono: «temporeggiamo, e
attendiamo che la natura malata esca allo scoperto»”.13
Il fine della verità evidente, chiara e distinta compromette
l’efficacia terapeutica. Non
è poi detto che questa verità evidente si possa
raggiungere: “Oggi deduciamo le nostre dissertazioni attorno
agli argomenti fisici da un unico vero sperimentato: ma i sintomi e
le valutazioni che si raccolgono con lunga osservazione sono
verisimili”.14
Non solo: questo modello porta solo a “spiegare un secondo vero
che si celava nel primo; ma le malattie sono sempre nuove e
diverse”.15 “Ma
il massimo inconveniente del nostro metodo di studi è che
mentre ci dedichiamo molto intensamente alle scienze naturali, non
facciamo tanto per la morale ed in particolare per quella parte che
tratta dell’indole dell’animo umano e delle sue passioni
in modo appropriato alla vita civile e all’eloquenza, dei segni
distintivi della virtù e dei vizi, delle buone e delle cattive
arti, dei caratteri dei comportamenti rispetto all’età,
al sesso, alla condizione, alla fortuna, alla stirpe, allo Stato di
ciascuno, e di quell’arte, tra tutte la più difficile,
della dignità (nel testo latino c’è il gen.
decori);
e così l’amplissima ed eminentissima dottrina dello
Stato giace presso di noi quasi abbandonata ed incolta. Poiché
oggi unico scopo degli studi è la verità, indaghiamo la
natura delle cose perché sembra certa: non indaghiamo la
natura degli uomini perché è resa incertissima
dall’arbitrio”.16 La
“nuova critica” può essere utile alla poesia. Premesso
che “la vocazione poetica è un dono di Dio” che
non “può essere acquistata con alcun mezzo”,
tuttavia “quelli che sono ispirati divinamente da questa
facoltà” possono perfezionarla con gli studi delle
lettere. Se insegnata agli adolescenti, però, “la
critica nuoce alla poesia”, perché “in loro
offusca la fantasia e cancella la memoria. Ma, se gli adolescenti,
una volta rafforzati in entrambe le facoltà della mente,
fossero istruiti in tale arte, riterrei che la critica gioverebbe
alla poesia: poiché i poeti si rivolgono al vero in idea, o
per genere […]. Ed il procedimento geometrico conduce il più
possibile a foggiare invenzioni poetiche: vale a dire così che
i personaggi agiscano sempre per tutto il corso della favola in modo
tale, quali sono stati presentati una volta al principio”.
Infatti, “non sanno correttamente foggiare tali invenzioni
poetiche se non coloro che sono in modo sufficientemente corretto
capaci di unire strettamente le cose le une alle altre, affinché
le seconde paiano seguire per natura dalle prime, le terze dalle
seconde”.17 Le
lunghe catene di ragionamenti a piccolissimi passi, tanto nocive alla
filosofia, giovano alla poesia! Convinto
che il metodo moderno danneggi la “prudenza civile”, Vico
pensa, infatti, che giovi alla “poetica”. Non solo: “E
sarei dell’opinione, aggiunge, che la fisica moderna sia
conveniente alla poesia. I poeti infatti in buona parte ricorrono a
frasi attraverso le quali spiegano le cause naturali delle cose, sia
al fine di suscitare l’ammirazione dell’orazione poetica,
sia a prova dell’antico possesso: poiché i più
antichi tra i poeti furono fisici. Da ciò «nato nel
sangue» in luogo di «generato», «svanire
nell’aria»invece di «morire», «fuoco
ardente nel petto» invece di «febbre», «vapore
condensato nell’aria» invece di «nube»,
«fuoco scagliato dalle nubi» invece di «fulmini»,
«ombre della terra» in luogo di «notte». […]
Poiché la fisica moderna descrive le immagini più
sensibili delle cause soprattutto a partire dalla meccanica, della
quale si serve come strumento, essa comodamente potrebbe provvedere i
poeti di una classe di nuove espressioni”.18 Figlio
di un libraio, Vico non poteva non apprezzare i vantaggi della
stampa. Tuttavia nota che essa ha eliminato una condizione preziosa
per la cultura. “Quando
i libri erano scritti a mano, i copisti, per fare il prezzo
dell’opera, trascrivevano gli autori di solida reputazione, e
poiché spesso erano venduti a caro prezzo, gli studiosi erano
spinti a trascriverli di loro propria mano. È sorprendente
quanti progressi si facciano con tal genere di esercizio! Poiché
ponderiamo meglio ciò che scriviamo, e soprattutto perché
non scriviamo in modo disordinato, né in fretta, né in
modo frammentario, ma con calma e senza interruzione. Ed infatti in
tal modo non sopravviene una conoscenza superficiale, ma una lunga
consuetudine tra noi e gli autori stessi, e attraverso di essa ci
trasformiamo in essi stessi tali e quali. E per questo motivo i
cattivi scrittori mancavano di trascrittura, invece i buoni erano
divulgati con tanto vantaggio”.19 Note 1
Vico, De nostri temporis studiorum ratione, Edizioni ETS
2010, pp. 89-91. 2
Ib. p. 147. 3
Ib. p. 147.
4
Ib. p. 25. 5
Ib. pp. 141-145. 6
Ib. p. 29. 7
Ib. pp. 37-39. 8
La topica è la teoria dei luoghi (topoi in greco)
logici e l’arte di inventarli. Aristotele ne parla a proposito
della retorica e dei ragionamenti dialettici: i luoghi sono quegli
“argomenti che sono comuni all’etica, alla politica,
alla fisica e a molte discipline diverse, come, per es., l’argomento
del più e del meno” (Ret., I.2, 1358 a 10).
Questi sarebbero i luoghi comuni. Essi non hanno oggetto
specifico, perciò non accrescono la conoscenza delle cose, ma
sono strumenti di persuasione. Su questa funzione ha insistito
Cicerone, che ha inteso la topica come la parte inventiva della
logica, cioè quella che escogita gli argomenti utili a
convincere.
9
Ib. pp. 45-47. 10
Orazio, Epistole, I, XVIII, 71. 11
Ib. pp. 51-53. 12
Ib. p. 59. 13
Ib. p. 61. 14
Ib. p. 61. 15
Ib. p. 61. 16
Ib. p. 65. 17
Ib. pp. 79-81. 18
Ib. pp. 83-85. 19
Ib. p. 137. Fonte: ANNO ACCADEMICO 2012-13 - UNIVERSITA’ POPOLARE DI TORINO Torino 20 maggio 2013 Giuseppe Bailone ha pubblicato
Il Facchiotami, CRT Pistoia 1999. Nel 2006 ha pubblicato
Viaggio nella filosofia europea, ed. Alpina, Torino. Nel 2009 ha pubblicato, nei Quaderni della Fondazione
Università Popolare di Torino,
Viaggio nella filosofia, La Filosofia greca.
Due dialoghi. I panni di Dio – Socrate e il filosofo della caverna
(pdf)
Plotino (pdf)
Download
- La scienza nuova (pdf-zip)
- Vita di Vico (htm-doc-pdf.zip)
- Leggi e conflitto sociale in Giambattista Vico (pdf-zip)