TEORICI
Politici Economisti Filosofi Teologi
Antropologi Pedagogisti Psicologi Sociologi...
Vico: l’alternativa umanistica al cartesianesimo
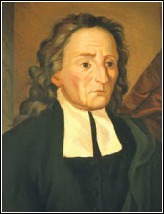
Giuseppe Bailone La
scienza moderna nasce liberandosi dalla metafisica aristotelica e
della ricerca della causa finale dei fenomeni naturali. Durante il
parto, però, viene presa in cura da un’altra metafisica,
di origine pitagorica, anche più antica di quella
aristotelica. Nasce, pertanto, con il presupposto che la natura sia
scritta in caratteri matematici. Il
razionalismo geometrizzante trionfa nella filosofia del Seicento:
Cartesio rimette in discussione tutta la tradizione culturale e
ricostruisce il sapere sul modello della geometria; Hobbes si propone
di geometrizzare anche la filosofia politica e si ritaglia il ruolo
del Galilei della nuova scienza politica; Spinoza rivela chiaramente
il suo programma filosofico già nel titolo del suo capolavoro,
Etica
ordine geometrico demonstrata.
La tradizione reagisce con forza e il Seicento, già
tragicamente lacerato da conflitti religiosi, vive una profonda
divisione anche in filosofia. Non mancano, però, voci
importanti fuori dai due cori: Pascal è diviso, pratica con
notevoli successi la nuova scienza, ma parla di limiti della ragione
e vive una fede religiosa in conflitto con la ragione; Leibniz, pur
affascinato dalla nuova scienza, non condivide la demolizione della
metafisica tradizionale finalistica e tenta una difficile
conciliazione tra il vecchio e il nuovo orientamento; Vico, a cavallo
di due secoli, è più radicale: contesta l’antica
idea pitagorica e platonica della natura scritta in caratteri
matematici, arruolata a servizio della scienza moderna, e fonda il
sapere su una metafisica ricavata dallo studio dell’antica
lingua latina. La
matematica, pensa Vico, è scrittura umana e come sia scritta
la natura lo sa solo Dio, che l’ha creata. L’uomo non può
illudersi di raggiungere la verità in fisica, ma deve ritenere
solo verosimili i suoi risultati, mentre può conoscere a fondo
quel che fa, la geometria, appunto, e la storia. Quest’idea,
Vico la presenta in forma embrionale nel 1708, la riprende in forma
più sviluppata in un’opera del 1710 e la fa maturare
negli scritti successivi. Nel
1708, in occasione dell’apertura dell’anno accademico
nell’Università di Napoli, scrive e recita, nella sua
funzione di docente di retorica, il De
nostri temporis studiorum ratione
(Il metodo di studio dei nostri tempi), un confronto tra il metodo
moderno della fisica cartesiana e quello antico della retorica. Le
cose della fisica cartesiana, scrive Vico, “in forza del
procedimento geometrico si presentano come vere”, ma “non
sono se non verisimili”, perché ricevono dalla geometria
“il procedimento, non la dimostrazione”.1 C’è
una differenza profonda fra le reali dimostrazioni della geometria e
quelle presunte della fisica: “Dimostriamo la geometria perché
la facciamo; se potessimo dimostrare la fisica, la faremmo”.2 Con
questo scritto, Vico interviene nel dibattito, allora molto vivo
soprattutto in Francia e in Italia, sul primato fra la cultura antica
e quella moderna. Si propone un confronto tra i loro diversi metodi
di studio, ma va ben oltre: approda a una sua originale concezione
dell’uomo, che, dotato di fantasia e d’immaginazione,
realizza pienamente se stesso nell’eloquenza. A
differenza di Cartesio, Vico non sente il bisogno di mettere in
dubbio tutto quel che ha appreso e di rifondare il sapere. Un po’
come Leibniz, è profondamente legato al passato e non lo
respinge per aderire alla cultura vincente, ma è meno
conciliante del filosofo tedesco: critica profondamente la cultura
moderna, prendendo di mira soprattutto il suo campione più
rappresentativo, Cartesio, e aggiorna in modo sorprendente la cultura
antica. In
quest’orazione Vico non cita Isocrate e Platone è il
primo dei suoi quattro “auttori”, ma, la sua battaglia
contro il razionalismo cartesiano rinnova la profonda divergenza dei
due grandi fondatori di scuole ateniesi sul valore educativo della
matematica e della retorica.3 Sesto
di otto figli, nasce a Napoli nel 1668, in un ambiente sociale basso,
ma tra i libri: il padre è libraio nella storica via san
Biagio dei Librai. Nella
sua Vita
scritta da se medesimo
racconta: “Il padre fu di umore allegro, la madre di tempra
malinconica; e così entrambi concorsero alla naturalezza di
questo lor figliolo. Imperciocché, fanciullo, egli fu
spiritosissimo e impaziente di riposo; ma in età di sette
anni, essendo col capo in giù piombato da alto fuori d’una
scala nel piano, onde rimase ben cinque ore senza moto e privo di
senso [..] talché il cerusico, osservato rotto il cranio e
considerato il lungo sfinimento, ne fe’ tal presagio: che egli
o ne morrebbe o arebbe sopravvivuto stolido. Però il giudizio
in niuna delle due parti, la Dio mercé, si avverò; ma
dal guarito malore provenne che indi in poi e’ crescesse di una
natura malinconica ed acre, qual dee essere degli uomini ingegnosi e
profondi, che per l’ingegno balenino in acutezze, per la
riflessione non si dilettino dell’arguzie e del falso”.4 Le
conseguenze di quel grave incidente rendono irregolare la sua
formazione scolastica, ma l’ambiente paterno gli rende
possibile procedere da autodidatta negli studi umanistici e,
soprattutto, in giurisprudenza. “Aveva
– scrive Vico di sé in quel periodo – un ardente
desiderio di ozio per seguitare i suoi studi, e l’animo suo
aborriva grandemente dallo strepito del fòro, quando portò
la buona occasione che, dentro una libreria, monsignor Geronimo Rocca
vescovo d’Ischia, giureconsulto chiarissimo, come le sue opere
dimostrano, ebbe con essolui un ragionamento d’intorno al buon
metodo d’insegnare la giurisprudenza. Di che il monsignore
restò così soddisfatto che il tentò a volerla
andare ad insegnare ai suoi nipoti in un castello del Cilento di
bellissimo sito e di perfettissima aria, il quale era in signoria di
un suo fratello, signor Domenico Rocca (che poi sperimentò
gentilissimo suo mecenate e che si dilettava parimenti nella stessa
maniera di poesia), perché l’arebbe dello in tutto pari
a’ suoi figlioli trattato (come poi in effetto il trattò),
ed ivi dalla buon’aria del paese sarebbe restituito in salute
ed arebbe tutto l’agio di studiare”.5
In
questa importante parentesi della sua esistenza, lunga ben nove anni,
dal 1686 al 1695, approfittando della ricca biblioteca del castello,
“fece il maggior corso degli studi suoi, profondando in quello
delle leggi e dei canoni”.6 Studia
la dottrina della grazia di “sant’Agostino posta in
mezzo, come a due estremi, tra la calvinistica e la pelagiana”.
Legge Lorenzo Valla, Cicerone, Virgilio, Orazio, Dante, Petrarca e
Boccaccio. Studia il giusnaturalismo. Apprezza le opere di Aristotele
e di Platone, che mirano “a ben regolare l’uomo nella
civile società”. Il suo forte interesse ai problemi del
vivere in società fa sì “che egli nulla o assai
poco si dilettasse della morale degli stoici e degli epicurei,
siccome … sono entrambe morale di solitari: degli epicurei,
perché di sfaccendati chiusi ne’ loro orticelli; degli
stoici, perché di meditanti che studiano non sentir passione”.
Si cura poco della “fisica di Aristotele, di Epicuro ed
ultimamente di Renato Delle Carte”, ma è ben disposto
verso “la fisica timaica seguita da Platone, la quale vuole il
mondo fatto di numeri”. Di lì passa allo studio di
Euclide, ma il ragionamento analitico non lo appassiona: pensa che
metta “in ceppi ed angustie la sua mente già avvezza col
molto studio di metafisica a spaziarsi nell’infinito de’
generi; e con la spessa lezione di oratori, di storici e di poeti
dilettava l’ingegno di osservare tra lontanissime cose nodi che
in qualche ragion comune le stringessero insieme, che sono i bei
nastri dell’eloquenza che fanno dilettevoli l’acutezze”.
Apprezza Aristotele che, “quantunque esso dal metodo usato
dalla geometria avesse astratto l’arte sillogistica, …
afferma che ai fanciulli debbono insegnarsi le lingue, l’istorie
e la geometria, come materie più proprie per esercitarvi la
memoria, la fantasia e l’ingegno”. La matematica non è
cartesianamente apprezzata come modello di ragionamento e di
conoscenza: Vico la inserisce tra le materie della scuola elementare
“perché in un certo modo è una pittura la quale
invigorisce la memoria col gran numero de’ suoi elementi,
ingentilisce la fantasia con le sue delicate figure come con tanti
disegni descritti con sottilissime linee, e fa spedito l’ingegno
nel doverle correre tutte, e tra tutte raccoglier quelle che
bisognano per dimostrare la grandezza che si domanda”.7 Tornato
a Napoli, frequenta il salotto del nobile Niccolò Caravita che
lo introduce nell’ambiente universitario. A Napoli, in quegli
anni, ha larga diffusione il pensiero galileiano e di Gassendi. Vico
lo studia, ma i suoi interessi umanistici lo spingono alla ricerca di
una fondazione metafisica della cultura morale e giuridica. Studia
Platone e Tacito, che diventano suoi “auttori”, cioè
punti di riferimento, “perché con mente incomparabile
Tacito contempla l’uomo qual è, Platone quale dee
essere”. Nel
1698 ottiene la cattedra di Retorica nella facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Napoli. Nel 1699 si
sposa con Teresa Caterina Destito, che gli darà otto figli,
tre dei quali muoiono presto. Nello stesso anno pronuncia la prima
delle sue sette orazioni
inaugurali
degli anni accademici. In essa è evidente l’influenza
della metafisica cartesiana del cogito,
ma la sua concezione dell’anima, che avrebbe in sé la
misura del bello e dei valori risente anche degli studi platonici. Si
apre una fase del suo pensiero che si potrebbe etichettare cartesiano
– platonica. Con l’orazione del 1708 Vico apre una
polemica frontale con Cartesio e col suo geometrismo, difende i
valori della fantasia, della retorica e della poesia. Diventa Vico. Nel
1710, nel De
antiquissima Italorum sapientia,
mette a fuoco il cardine del suo pensiero, l’idea che “verum
et factum conventuntur”, che il vero sia il fatto, che l’uomo
possa conoscere solo ciò che fa. Il
libro non ha però il successo che avrebbe meritato: poche le
copie vendute e i pochi uomini di cultura che se ne occupano non ne
colgono l’originalità. Nel
1713, pressato da necessità economiche, accetta una
commissione di lavoro che si rivelerà importante per gli
sviluppi della sua filosofia: scrivere una storia delle imprese di
Antonio Carafa. È così costretto a muoversi e a
riflettere su un terreno di ricerca sul quale il De
antiquissima Italorum sapientia
ha prospettato la possibilità di raggiungere validi risultati.
Ha modo di apprezzare Tacito, ma, soprattutto lo aiuta lo studio del
De iure
belli et pacis di
Ugo Grozio, letto più volte tra il 1714 e il 1716. Quest’opera
lo porta a chiarirsi le idee sul diritto naturale e a convincersi che
esso si trovi nel “senso comune” di tutti gli uomini e
non nelle speculazioni razionalistiche dei filosofi. Comincia così
a pensare che questo elemento ideale comune a tutti gli uomini sia
decisivo per capire la vicenda umana. Grozio
diventa “il quarto auttore da aggiungersi agli altri tre che
egli si era proposti”,8
cioè Platone e Tacito, come già detto, e Bacone, dal
quale Vico ritiene di aver appreso il valore dell’esperienza e
il metodo empirico, il modo di liberarsi dai pregiudizi e le misure
per evitare gli errori. Sempre
più si convince che sia il mondo umano il campo dove il suo
nuovo principio del sapere può diventare veramente fecondo. Si
occupa e scrive di diritto, anche per conquistare, ma invano, la
cattedra di giurisprudenza. Dedica molto tempo alla storia e al
laborioso parto della Scienza
nuova,
che ha una prima edizione nel 1725. La rielabora per l’edizione
del 1730. Ci torna su con quattro serie di Correzioni,
miglioramenti e aggiunte.
Sulla base di queste viene composta una terza edizione, che esce nel
1744, sei mesi dopo la sua morte. Quest’opera gli assicura
nella storia del pensiero una posizione importante e originale, che,
però, gli è riconosciuta pienamente solo molto tardi,
nel Novecento. Note 1
Vico, De nostri temporis studiorum ratione, Edizione ETS
2010, p. 49. 2
Ib. p. 51. 3
Sulla divergenza pedagogica delle due scuole ateniesi rimando alle
pagine 59-60 del primo dei “Quaderni della Fondazione
dell’Università Popolare di Torino”, Viaggio
nella filosofia. La filosofia greca. 4
G. Vico, Autobiografia, Istituto Italiano per gli Studi
Storici 1992, p. 14. Cerusico è il chirurgo. 5
Ib. pp. 23-24. 6
Ib. p. 24. 7
Ib. pp. 24-29. Fisica timaica = fisica esposta nel dialogo
platonico Timeo.
8
Ib. p. 64. Fonte: ANNO ACCADEMICO 2012-13 - UNIVERSITA’ POPOLARE DI TORINO Torino 13 maggio 2013 Giuseppe Bailone ha pubblicato
Il Facchiotami, CRT Pistoia 1999. Nel 2006 ha pubblicato
Viaggio nella filosofia europea, ed. Alpina, Torino. Nel 2009 ha pubblicato, nei Quaderni della Fondazione
Università Popolare di Torino,
Viaggio nella filosofia, La Filosofia greca.
Due dialoghi. I panni di Dio – Socrate e il filosofo della caverna
(pdf)
Plotino (pdf)
Download
- La scienza nuova (pdf-zip)
- Vita di Vico (htm-doc-pdf.zip)
- Leggi e conflitto sociale in Giambattista Vico (pdf-zip)