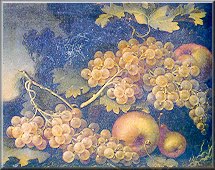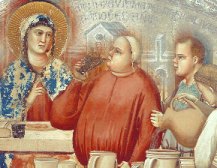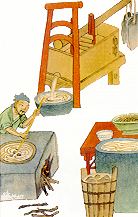IL VINO E LA ROMAGNA
dai greci ad oggi
TRA BACCO E NOè, OVVERO TRA MISTICA E PROFEZIA DEL VINO
|
Non il ridere Rabelais |
|
Storia e Simbologia
Rispetto a tutte le altre bevande fermentate, il vino si distingue per tre prerogative fondamentali:
- grande varietà del sapore a seconda del tipo di vite, della zona e del clima;
- possibilità d'invecchiare in rapporto alle condizioni di conservazione;
- possibilità di trasporto in luoghi lontani, senza alterazioni nella qualità.
| Forse per queste ragioni il vino è una bevanda antichissima, nata già in epoca neolitica, presso il bacino del Mediterraneo (10.000-6.000 anni fa). Successivamente si è diffusa in tutte le zone del mondo a clima temperato. Il più antico recipiente di vino conosciuto risale a circa 7.000 anni fa ed è stato trovato in Iran, nei Monti Zagros, dove tuttora l'uva selvatica cresce spontanea. |
|
L'origine della vite si perde invece nella notte dei tempi. Le prime impronte dell'addomesticamento della Vitis vinifera si trovano in alcune zone dell'Asia anteriore e del Caucaso. Foglie e semi fossili di questa pianta sono stati ritrovati in depositi dell'era del Miocene e del Terziario in Europa continentale, Inghilterra, Islanda e Nord America. Nel Nuovo Mondo la vite fu portata dai colonizzatori: dapprima in Messico, poi, agli inizi del 1600, negli Stati orientali degli Usa e da qui in California. Alla Vitis vinifera appartengono quasi tutte le varietà a frutto bianco o rosso.
Una stretta interdipendenza tra vitis e vinum è presente in alcuni pittogrammi sumeri risalenti alla fine del IV millennio a.C.
Gli antichi consideravano il vino non tanto come un prodotto da differenziare secondo i vitigni, quanto come un punto di partenza per ogni tipo di bevanda, di cui facevano parte l'acqua, il miele, la pece, le resine e ogni altro tipo di aroma. Profumare i vini, soprattutto coi fiori o con spezie, è stato un aspetto fondamentale dell'arte enologica sino alla fine del Medioevo.
Nelle varie culture mediterranee, che basavano il loro sviluppo sull'agricoltura, il vino entra come simbolo di questo stesso sviluppo e del punto più alto del benessere raggiunto, che si esprimeva nel binomio pane e vino.
Il vino era anche una delle offerte fatte al dio e per il suo potere inebriante entrava come componente importante nei riti orgiastici, intesi a raggiungere uno stato di trance, in cui si compiva l'unione del fedele con il suo dio.
A tutt'oggi risultano selezionate circa 20.000 varietà di specie viticole, di cui solo il 10-15% può ritenersi coltivato.
MITOLOGIA GRECA
| Nella mitologia greca si racconta che
Bacco,
figlio di Giove, chiese un giorno a Sileno, suo maestro e precettore, un
consiglio su come fare una guerra senza l'uso delle armi. Sileno consigliò di
usare tirsi e tamburi (che facevano solo rumore) e soprattutto qualcosa che
assomigliasse al sangue: il vino. Sileno raccontò di una pianta che dava buffissimi frutti, che amano tanto la compagnia da stare sempre insieme attorno a un unico gambo. "Se strizzi questi frutti -disse Sileno a Bacco- ne viene fuori un liquido uguale al sangue; se te ne cibi, danno al corpo la stessa energia. Insomma è per questo che la pianta a me nota l'ho chiamata vite". |
|
E così Bacco, dopo aver conquistato col fracasso dei tirsi e dei tamburi le Indie e l'Egitto, vi piantava la vite, ne raccoglieva i frutti, obbligava i sudditi a cibarsene quando li vedeva impiastricciati nel viso e nelle mani diceva: "Ora non si potrà dire che non versi sangue anch'io".
Da notare che un vocabolo ittita, tuwarsa, che ha il significato di "vite", passò nel greco jursos, con il significato di "bastone delle baccanti", a testimonianza che la vite era una pianta sacra, probabilmente a motivo del fatto che la fermentazione appariva un autentico mistero.
ELLENISMO
| Nel mondo greco il saper produrre vino di qualità era segno di cultura e civiltà. "Chi usa vino è civile, chi non lo usa è barbaro", dicevano i greci. I cosiddetti "barbari", infatti, usavano prevalentemente la birra (le cui origini non sono meno antiche). Oppure usano, come il Ciclope dell'Odissea, un vino di scarsa qualità. |
|
Secondo Arriano di Nicomedia (II sec. d.C.) la civiltà nasce con Dionisos o Bacco (che fece conoscere il vino agli uomini) e da allora è cominciato il culto degli dei. Il dono del vino equivale al dono del fuoco. Il vino è simbolo di amicizia tra gli uomini e tra questi e gli dei. Il vino, in tal senso, può essere considerato come una delle prime sostanze naturali usate a scopi religiosi.
La sobria ebrietas indicava proprio il vertice della contemplazione, secondo una tematica di tutta la tradizione platonica, gnostica, ermetica e persino cristiana. Nei misteri orfico-dionisiaci Dio è equiparato a un vignaiolo.
Il proverbio "In vino veritas" è stato attribuito al poeta greco Alceo, e si riferiva all'azione del vino quale forza disinibitrice di ogni falso ritegno a dire la nuda verità senza infingimenti.
Anche Socrate lo sapeva: infatti le sue libagioni, pur abbondanti, non lo privavano mai della sua forza argomentativa (così almeno dicono Platone e Senofonte).
Pare assodato che siano stati i greci, un millennio avanti Cristo, a introdurre la vite nel Nord Africa, in Andalusia, Provenza, Italia meridionale e Sicilia. Nel V sec. a.C. Sofocle proclamò l'Italia il paese prediletto da Bacco.
Altri scrittori hanno dato il nome di Enotria ("paese dei pali da vite") alle antiche popolazioni illiriche stabilitesi sulle coste della Calabria, Lucania e Sud della Campania. Esse infatti disponevano le viti, tenute basse, a tre a tre, legate in piccoli piramidi.
MONDO EBRAICO
| Nel mondo
ebraico, cioè
sostanzialmente nell'Antico Testamento, si dice a chiare lettere che "Noè
il coltivatore iniziò a piantare la vite; avendo bevuto del vino, fu
ebbro" (Gen, 9, 20s.).
La stessa storia degli uomini viene fatta iniziare, dopo il diluvio, con la vigna e il vino. L'ebbrezza di Noè viene descritta anche nel Cantico dei Cantici. Ambrogio così commentava: "Piantò la vite cercando il voluttuario perché sapeva che Dio gli avrebbe dato il necessario". |
|
Nell'Ecclesiastico la vite è chiaramente la sapienza.
Ancora oggi il sabato ebraico inizia con un atto di benedizione che si fa salmodiando mentre viene passato un calice di vino, da cui bevono tutti i membri della famiglia.
La regole ebraiche per fare il vino sono molto rigorose:
-
non deve contenere ingredienti proibiti come grassi, vitamine, conservanti ricavati da animali proibiti (al massimo è ammessa la chiarificazione con l'albume dell'uovo sbattuto),
-
bisogna evitare qualunque elemento di lievitazione,
-
dev'essere lavorato esclusivamente da ebrei.
CRISTIANESIMO
| Nel cristianesimo il vino acquistò nuova nobiltà nella simbologia eucaristica, dove viene equiparato al sangue di Cristo, simbolo di vita. Il vangelo di Giovanni (15, 5 s.) pone uno stretto parallelo tra il Cristo e la Vite, i cui tralci sarebbero gli stessi discepoli che devono portare frutto (vedi anche la parabola della vigna nei vangeli sinottici, Mc 12, 1ss.; Mt 21, 33ss.; Lc 20, 9ss.). Col miracolo di Cana (Gv 2, 1ss.), in cui l'acqua fu trasformata in vino, Gesù addirittura inaugurò i suoi prodigi. |
|
Carlo Magno darà molta importanza alla vite nei suoi Capitulares de villis, al punto che un cronista medievale distinguerà nettamente i popoli mediterranei che avevano appreso l'arte del vino dai popoli nordeuropei dediti alla birra e all'idromele. I limiti geografici della viticoltura corrispondevano praticamente a quelli delle frontiere della Respublica Christiana.
Disposizioni a tutela dell'attività vinicola si trovano anche nelle Costitutiones di Federico II, negli Statuti di Conegliano e di Ivrea e soprattutto nel Ruralium Commodorum di Pier de' Crescenzi.
Per tutto il Medioevo furono i religiosi di ogni ordine che si fecero viticoltori ed enologi: "Fecit ecclesias et planavit vineas", sono parole attribuite a Carlo Magno.
Dice Honorius Augustodunensis (sec. XII): "alla fine dei tempi i giusti saranno inebriati dal vino dell'eterno piacere".
Anche nel mondo medievale il vino indica l'arcano deitatis, i misteri della divinità, l'intelligenza delle Scritture e la contemplazione.
Le Allegoriae in universam Sacram Scripturam riassumono la gamma vastissima dei referenti simbolici del vino che, come si legge nel Libro dei Giudici, "allieta Dio e gli uomini".
Per questo esso significa gaudium, mentre l'acqua è tristitia, dirà il monaco Bernardo di Chiaravalle. Nei monasteri la quantità di vino era concessa in relazione al grado gerarchico ricoperto.
Isacco della Stella dirà: "Essere sapiente è avere vino".
L'invenzione della bottiglia col collo lungo è dovuta o al diplomatico corsaro e alchimista Sir Kenelm Digby, mentre nell'abbazia di Hautvillers, l'abate cantiniere Dom Pérignon inventò nel 1668 lo Champagne.
LA VITE IN CINA
| La coltivazione della vite (Vitis vinifera) fu introdotta in Cina dall'Asia centrale ad opera del generale Zhang Qian nel II secolo a.C., ma fu solo sotto i Tang (618-907) che cominciò ad essere diffusa. |
|
| Nuovi tipi di uva da vino
vennero introdotti in Cina dal Turkestan e con essi la conoscenza dell'arte
della vinificazione dell'uva. Il tipo più spesso menzionato dagli antichi testi
cinesi è quello chiamato, per la sua forma allungata "capezzoli di cavalla",
color porpora, distinto dal tipo "perle di drago", di forma sferica. Alla vite coltivata preesisteva in Cina una varietà selvatica (Vitis thumbergii) che ancora cresce nella regione dello Shandong, anch'essa valorizzata in seguito per la vinificazione e per usi terapeutici: gli erbari di epoca Tang parlano infatti di un vino ottenuto da questo frutto. Sempre ad esso si riferisce, probabilmente, la leggenda sulla "Valle dell'Uva" dove questo frutto poteva essere raccolto liberamente, ma colui che lo mangiava perdeva facilmente la strada. |
|
L'uva era così già diffusa nel VII secolo da meritare l'attenzione dei dietologi del tempo: Meng Shen, per esempio, afferma che "mangiarne troppa provoca sintomi di ansietà e oscuramento della vista", mentre il succo d'uva è utile per abbassare un feto che preme contro il cuore... Aggiungi l'uva al vino e bevilo durante le epidemie: eviterai piaghe e ascessi".
Il Classico della farmacopea di Shen Nong afferma: "L'uva fa bene ai muscoli e alle ossa, potenzia il flusso vitale, rende resistenti alla fame, immuni ai raffreddori e se mangiata a lungo fa dimagrire, tiene lontana la vecchiaia e ringiovanisce. Puoi inoltre farne vino".
"L'uva è diuretica" è scritto nelle Memorie di medici famosi.
IL VINO IN CINA
| Il "vino" più antico e più diffuso in Cina in tutte le epoche è quello ottenuto dalla fermentazione dei cereali, soprattutto ottenuto da una varietà di riso, diversa da quella commestibile (si tratta più precisamente di una sorta di birra prodotta con il liquido di cottura dei cereali ai quali veniva aggiunto lievito di farina per la fermentazione). |
|
| Secondo la leggenda, artefice
dell'invenzione del "vino" cinese (di riso) fu I Ti, la figlia del mitico
imperatore Yu (2205-2198 a.C.) che la elogiò per l'eccellenza della bevanda, ma
la punì anche per aver dato al genere umano una fonte di mali. La storia fa invece risalire l'invenzione del "vino" di riso a un'epoca un po' più tarda, attribuendola a Du Kang, ricordato e celebrato dai produttori di alcolici cinesi. |
|
| Huang jiu ("vino giallo") è il
nome generico di un vino di riso o di miglio ampiamente usato in Cina. Esso si
trova in molte varietà locali, di cui la più famosa - descritta nel Jiu Jing o Classico dei vini - è il "vino Shaoxing", ottenuto dal riso
glutinoso nella località omonima della regione del Jiejiang. Tra le bevande alcoliche di origine straniera molto noti erano il kumiss, di origine mongola, ottenuto dalla fermentazione del latte di cavalla e soprattutto il vino d'uva. |
|
Anche il processo di distillazione è di origine straniera: si dice che un distillato, chiamato shao jiu o baigan jiu, sia stato introdotto in Cina dall'Asia centrale durante la dinastia Yuan (1279-1368).
La farmacopea cinese attribuisce l'origine del vino d'uva all'espansionismo dei Tang (618-906) che lo introdussero dal Turkestan. Pur essendo molto apprezzato, il vino d'uva non divenne però mai una bevanda popolare in Cina: persino a Dunhuang, avamposto occidentale sulla via della seta, era una bevanda di lusso riservata ad importanti celebrazioni, proprio come lo champagne nelle nostre feste.
Una coppa di questo vino fu offerta all'imperatore Mu Zong (821-825) ed egli osservò: "Quando lo bevo sono immediatamente conscio dell'armonia che soffonde le mie membra; è il vero Principe della Grande Tranquillità!". Quest'ultima definizione allude al titolo onorifico di Lao Zi, il padre del Taoismo, e sembra anche echeggiare la nozione greca de vino come divinità.
Fu precisamente dal nuovo protettorato di Qoco che l'arte della vinificazione dell'uva fu introdotta nella Cina Tang e gli "otto colori" (o varietà) di questa bevanda fortemente aromatica e pungente divennero noti alla popolazione del nord.
L'uva chiamata "capezzoli di cavalla" sembra avere avuto una parte importante in questa nuova industria, e certamente ad essa alludono i versi della Canzone dell'uva che così concludeva: "...i fiori si aprono come frange di seta, i frutti pendono come grappoli di perle... Noi uomini di Tsin queste uve così belle coltiviamo come gemme tra le più rare e di esse facciamo un vino delizioso di cui gli uomini non estinguono mai la sete".
Ma per lo più il "vino" di cui parlano i poeti Tang, il"vino" bevuto dai taoisti per attuare il ritorno al Tao, quello usato dagli alchimisti e dai medici per esaltare l'efficacia delle droghe e dei farmaci, non è il vino d'uva del mondo occidentale.
Nelle Memorie di medici famosi è scritto: "Il vino dà potenza alle droghe, annienta i cento influssi nocivi. I suoi nomi sono: vino primaverile di lunga durata, vino di cenere, vino di digitale, vino bianco, vino amaro, vino distillato, vino d'uva, vino di miele, vino d'oro. Puoi anche far fermentare il latte di vacca, l'osso di tigre, la bile di un immortale, l'aralia, la soia, le bacche e altro ancora per ottenerne vino. Il vino disperde la malinconia, annulla la passione; per questo se ne beve molto e ci si ubriaca, ma se viene aggiunto senza moderazione in medicina non è di alcun giovamento. Per aumentare l'efficacia dei farmaci devi fare molta attenzione alle dosi. Il vino che userai è soltanto quello che si ottiene facendo fermentare il riso glutinoso".
"Il vino di gelso è un rimedio per le cinque viscere, rende più acuto l'udito e rischiara la vista. Il vino di cipolla è un rimedio per le forze indebolite. Il vino d'uva giova al soffio vitale e lo rende più armonico, fa più resistenti nelle carestie, rafforza la volontà. E' buono anche il vino che si ottiene facendo fermentare il succo dei viticci", è scritto sulle Memorie di medici famosi (VI sec.). E ancora: "Il vino di primavera fa ingrassare e rende più chiara la pelle".