STORIA ROMANA
La falange nella Roma antica
L'antico cittadino romano in origine era un contadino e/o un allevatore (la stessa contesa tra il contadino Romolo e il pastore Remo rappresentò, in chiave figurata, il punto di arrivo di una progressiva differenziazione di ruoli: non più contadino "e" allevatore ma o l'uno o l'altro, fino alla maturazione di quell'antagonismo - in relazione all'uso della terra - che a un certo punto divenne irriducibile, esattamente come in altre zone geografiche caratterizzate dal sorgere delle civiltà, e che si può sintetizzare nel conflitto tra il nomadismo degli allevatori e la sedentarietà degli agricoltori).

Quando la rottura (che nel caso della leggenda di Romolo fu tragica) trovò il suo compimento, prese l'avvio la progressiva trasformazione del contadino romano in soldato. Tale trasformazione sarà accompagnata, come in parallelo, da quella del possidente agrario in comandante militare e quindi in uomo politico e amministratore di città.
Il primitivo esercito romano era formato da gruppi di combattenti che appartenevano alle grandi famiglie aristocratiche (gentes), in grado di pagarsi carri, cavalli, armi di ferro, nonché di disporre di un certo seguito di clienti, bisognosi di protezione ma anche capaci di seguire quelle famiglie nel corso delle guerre per conquistare terre e città.
I combattimenti non si svolgevano a cavallo ma a piedi: i cavalli servivano per spostarsi velocemente sul luogo dello scontro. Questo ovviamente non vuol dire che non esistesse nel primitivo esercito la cavalleria, ma semplicemente che lo scontro decisivo avveniva tra fanti, che rappresentavano il cosiddetto "esercito degli opliti schierati a falange" (1). L'uso intelligente della cavalleria avverrà solo nel corso delle guerre puniche.
Il comandante dell'esercito era il re, coadiuvato da un generale (magister populi), il quale nominava un proprio sottoposto: il magister equitum.
Intorno al VI sec. a.C., sotto il regno di Servio Tullio, l'esercito di Roma e di altre città sotto la sua influenza si organizza in modo rigoroso: tutti gli uomini (quindi non solo gli aristocratici di nascita) in grado di pagarsi un armamento completo di metallo (scudo, corazza, schinieri, elmo, lancia e spada) e disposti a combattere insieme con disciplina, potevano aspirare non solo a una spartizione del bottino ma anche a un controllo politico della città. Era nato l'esercito su base censitaria e nel contempo una strategia di tipo politico-militare.
Quelli che erano inferiori a un certo censo (i cosiddetti proletarii, perché censiti solo per la prole) potevano combattere solo con armi rudimentali, fuori dallo schieramento della falange e dalla possibilità di ottenere ruoli politici di rilievo.
L'ordinamento politico-istituzionale fu una conseguenza di quello militare. Infatti dall'esercito riunito per combattere si sviluppò il comizio centuriato, un'assemblea cittadina fondata sulle centurie, l'unità base della legione. Composta inizialmente di 3.000 e poi di 6.000 uomini, la legione non era più comandata dal re, dopo il crollo della monarchia, ma da due consoli. La cavalleria che l'affiancava aveva 300 unità per legione.
Una centuria era generalmente composta di 100 uomini, agli ordini di un ufficiale: il centurione. Forse quando le legioni divennero due, ogni centuria comprendeva solo 50 uomini.
Nei comizi centuriati i ceti benestanti disponevano sempre di più voti, coi quali potevano eleggere i magistrati, i comandanti militari e dichiarare la guerra o la pace. Si votava infatti per centurie, non individualmente, e i più ricchi erano distribuiti in un maggior numero di centurie.
Queste assemblee si tenevano fuori dalla linea sacra della città, il pomerio, al cui interno non si potevano portare armi. Le proposte venivano presentate dai magistrati e i cittadini si limitavano a votarle, senza neppure discuterle.
Ecco il diagramma in cui si rappresenta il tipo e il numero di centurie che ciascuna classe di cittadini doveva fornire in caso di guerra:
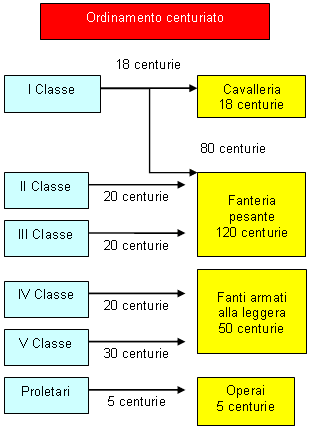
I censimenti venivano fatti ogni cinque anni. I cittadini venivano divisi in cinque classi, di cui le prime quattro includevano quelli con patrimoni compresi tra i 100.000 e gli 11.000 assi. Nell'ultima era i proletarii. A parte venivano censiti i fabri, cioè i tecnici necessari, e i trombettieri. Ecco una tabella relativa ai cittadini romani censiti come abili alle armi:
| Anni | 393-392 | 340-339 | 329 | 294-293 | 288-287 | 280-279 | 276-275 |
| Censiti | 152.573 | 165.000 | 150.000 | 262.321 | 272.000 | 287.222 | 271.224 |
Durante la guerra decennale contro Veio, conclusasi nel 396 a.C., fu introdotto il soldo, un contributo dei cittadini alle spese di vestiario e di armamento dei soldati.
Ogni romano diventava abile alle armi praticamente a 17 anni, quando indossava la toga virile ed entrava a far parte degli iuniores, dove vi restava fino a 46 anni, dopodiché apparteneva ai seniores, cioè alla riserva, richiamabile per una guerra in casi di particolare pericolo. Ma esisteva anche una chiamata di emergenza detta tumultus che avveniva a prescindere totalmente dal censo.
I plebei spesso rifiutavano le continue chiamate alle armi, poiché dalle conquiste realizzate ricevevano solo le briciole e le famiglie rimaste in patria facilmente cadevano vittime dei debiti, senza considerare che, una volta entrato nell'esercito, il plebleo perdeva automaticamente tutti i diritti faticosamente acquisiti con le lotte di classe: poteva p.es. essere messo a morte per indisciplina, senza alcun processo.
La disciplina era un aspetto fondamentale dell'organizzazione militare. Ogni soldato prestava un solenne giuramento al suo comandante: la parola sacramentum, con cui si designava questo atto di totale fiducia e sottomissione, implicava l'idea della punizione severa per chi trasgrediva le regole. Manlio Torquato nel 340 a.C. mise a morte il figlio solo perché aveva ingaggiato un duello individuale (vincendolo) senza la sua autorizzazione. Esempi come questo se ne possono fare tanti e non a caso già a partire dal II sec. a.C. i giovani romani cominciavano a manifestare una certa insofferenza per la leva militare.
[1] In battaglia ogni legione si schierava su tre linee: hastati, che avevano il compito di scagliare la lancia per scompigliare le file nemiche; principes, i soldati migliori che intervenivano subito dopo per lo scontro decisivo; triarii, che costituivano il rinforzo in caso di necessità. (torna su)