|
| Percorso geografico |
Geologia e clima del territorio cesenate centuriato
Il territorio di S.Giorgio di Cesena
Premessa
Il territorio di S.Giorgio occupa la parte centrale della pianura cesenate
tra il fiume Savio ad occidente e il mare Adriatico ad oriente. Tale territorio
si eleva ad una quota media di 15 metri sul livello del mare, con generale
pendenza verso Nord-Est. Si tratta di una vasta pianura alluvionale.
Nella sua struttura e formazione hanno agito prevalentemente due fenomeni:
subsidenza (abbassamento del livello del terreno) e alluvionamento
(fenomeno di trasporto di detriti fini e grossolani dato da straripamenti
dei fiumi). Dove l'alluvionamento incontra la subsidenza si formano paludi,
stagni ecc.
I fattori climatici che furono favorevoli a tali avvenimenti
furono: alta piovosità, abbassamento della temperatura media e più
erosione. Sulla base dei dati emersi con l'esecuzione di pozzi, sondaggi
geotecnici, canali di bonifica e costruzione di edifici è stato
possibile ricostruire le varie vicende geologiche che portarono alla formazione
del territorio.
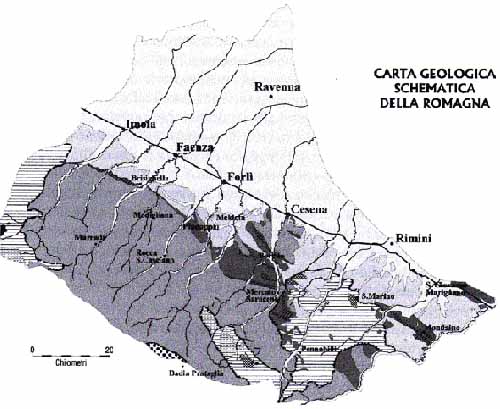
I tempi geologici più antichi
Nella zona attorno a San Giorgio, al di sotto di una copertura ghiaiosa,
sabbiosa, argillosa, e torbosa, giacciono strati compatti e cementati.
La copertura si sedimentò negli ultimi 2.250.000 anni. Tra i
sedimenti della copertura e quelli sottostanti, vi è uno strato di
sedimentazione dovuto a movimenti orogenetici, causati dallo spostamento
della microplacca che occupa l'area dell'Appennino e della pianura Padana.
Il sottosuolo di S.Egidio si trova nella fascia esterna degli Appennini
e i corpi sedimentari del Pliocene superiore - Quaternario non sono stati
mascherati dagli accavallamenti delle strutture appenniniche. I pozzi eseguiti
dall'AGIP hanno raggiunto ed esplorato i terreni oligo-miocenici intensamente
tettonizzati.
Terreni attribuibili alla parte più alta della Formazione
marnoso-arenacea sono presenti anche nel sottosuolo della pianura
cesenate. I terreni prevalentemente marnosi oligo-miocenici vengono attualmente
indicati con il nome di Marne di Gallare. Si tratta di sedimenti
di origine marina ricchi di microfossili. Sulla base della presenza di
questi ultimi è stato possibile anche per i terreni miocenici del
sottosuolo della pianura cesenate dettagliarne la successione stratigrafica.
I pozzi "Cervia 1", "Cervia 3" e "Cesena 1" furono ubicati in corrispondenza
di due zone di alto strutturale, denominate rispettivamente anticlinale
di Cervia e anticlinale di Cesena. Si può infine accennare
che con l'esecuzione da parte sempre dell'AGIP di due pozzi, nella parte
più orientale della pianura cesenate, denominati "Gambettola 1"
e "Rubicone 1", sono stati raggiunti e oltrepassati i terreni dell'Oligocene.
Si è così potuto accertare che nel sottosuolo della pianura
cesenate sono presenti tutte le formazioni geologiche dal Paleogene al
Mesozoico, che affiorano nelle Marche. Si tratta in massima parte di terreni
di natura calcarea e dolomitica. Tali terreni si sedimentarono intorno
a 190-195 milioni di anni fa in un ambiente marino poco profondo.
I tempi geologici recenti
I sedimenti del Quaternario non hanno, nella catena appenninica, subito
traslazioni e piegamenti ed hanno pertanto una giacitura più tranquilla.
Le correlazioni attraverso questi sedimenti, tramite i vari pozzi eseguiti,
sono di più facile esecuzione ed è possibile seguire le successive
fasi della sedimentazione. È stato così riconosciuto che
dopo l'emersione di una parte della catena appenninica, ora sepolta nel
sottosuolo della pianura cesenate, si creò in tale zona un vasto
promontorio. Le colline si estendevano fino nei pressi di Cesenatico e
Cervia. L'area in esame rimase emersa per buona parte del Pliocene inferiore
e medio. Poi il mare invase le terre precedenti, fino a spingersi presso
l'attuale bordo del Subappennino romagnolo.
Nel complesso di sedimenti del Pliocene si possono distinguere due
fasi di sedimentazione: una, più antica, caratterizzata da depositi
prevalentemente argillosi; ed una, più recente, con predominanza
di sabbie con intercalazioni di argille, torbe e ghiaie. Il primo complesso
viene indicato nella letteratura geologica padana con il nome di "Argille
del Santerno" ed il secondo con "Sabbie di Asti". Osservando la sezione
geologica attraverso il sottosuolo di San Giorgio, si può constatare
che lo spessore del Pliocene rilevabile dal pozzo "Cervia 2" è doppio
di quello dei pozzi "Cervia 1"e "Cervia 3", ed è quadruplo di quello
del pozzo "Cesena 1". Ciò è dovuto al fatto che la subsidenza
nell'area Nord dell'anticlinale di Cervia era molto maggiore di quella
della pianura cesenate in esame. Nella parte più alta del Pleistocene
si trova la documentazione delle fasi glaciali. L'alternarsi di periodi
glaciali e di periodi interglaciali provocò vasti movimenti nella
linea di riva dei mari, compreso l'Adriatico. Se si fa riferimento all'ultima
grande glaciazione, il livello del mare Adriatico, rispetto a quello attuale,
si abbassò di oltre 100 metri.
Ambienti palustri, lagunari, marino-costieri, vallivi e terrestri si
alternarono nel corso dei millenni, a seguito del susseguirsi delle variazioni
climatiche, delle oscillazioni della linea di spiaggia e degli apporti
solidi dei fiumi al mare.
A nord di San Giorgio, il pozzo "Pisignano 1" ha individuato strati
mineralizzati ed acqua dolce fino alla profondità di 340 metri,
poi fino alla profondità di 500 metri dominano le acque salmastre.
Spostandosi a sud di San Giorgio, la base delle acque dolci si trova via
via a profondità minori. Così nel pozzo "Cesena 1", le acque
dolci si trovano fino a 70 metri, seguono le acque salmastre fino a 125
metri, e a maggiori profondità si hanno acque salate.
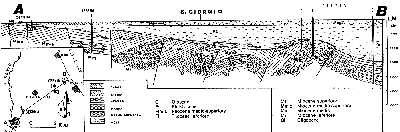 |
| Il sottosuolo del territorio di S. Giorgio |
|---|
Dove e perché la centuriazione persiste o cede
Tutte quelle elencate nei paragrafi precedenti sono le caratteristiche
geologiche e naturali a cui si è dovuto adattare il grande impianto della
centuriazione.
Infatti, quando la si realizzò, la si mise in stretta relazione
con le condizioni naturali del suolo, prima fra tutte le pendenze per assicurare
il drenaggio. Così gli assi della centuriazione sono orientati secondo
la direzione del corso dei fiumi. La centuriazione è andata incontro
a un graduale degrado che però non è uniforme fra le varie
zone. È successo che i territori centuriati sono stati sottoposti
a risistemazioni e bonifiche per ripristinarvi le loro capacità
di drenaggio aggredite da dissesti idrogeologici e, soprattutto,
da alterazioni della rete idrografica nel corso del tempo, che hanno causato
la perdita delle loro funzioni. I luoghi in cui la centuriazione si è
ben conservata sono gli alti strutturali, zone poste sopra ai rilievi appenninici
che continuano sotto la pianura, per esempio S. Giorgio.
