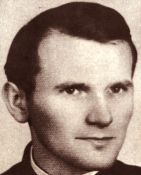
MARXISMO E TEOLOGIA DELLA LIBERAZIONE
| A partire dalle autorevoli posizioni del comunista L. L. Radice, sostenute negli anni 60 e 70, nell'ambito della sinistra italiana, alcuni intellettuali, con sempre maggiore insistenza (soprattutto alla luce degli sviluppi della Teologia della liberazione) hanno cercato di rivedere o riprecisare le tesi classiche del marxismo sul fenomeno religioso (cfr p.es. i nn. 5/81 e 4/83 di Critica marxista). |
|
Accortisi che con il legame latinamericano di fede e politica le popolazioni oppresse di quel continente ottenevano risultati di una certa rilevanza, in rapporto all'esigenza di una trasformazione dell'esistente in direzione del socialismo, questi intellettuali -le cui idee si ritrovano anche oltreoceano (cfr p.es. Monthly review, n. 36/84)- mirano a porre sotto il vaglio della loro critica l'affermazione basilare del marxismo che vede nella religione in sé un "oppio per i popoli". (1)
Essi in sostanza fanno il seguente ragionamento. Nel Sudamerica neocolonizzato dall'occidente capitalistico vivono milioni di cittadini professanti diverse religioni (in specie la cattolica); questi oppressi e sfruttati d'ogni genere, per opporsi al sistema iniquo dei loro governi filooccidentali, non hanno rinunciato alla fede religiosa, ma anzi l'hanno trasformata mettendola al servizio di una politica rivoluzionaria. Ora, se hanno potuto fare questo, significa che tale fede (in primis quella cristiana) non è -come da Marx in poi ci è stato insegnato- l'aspirazione dell'illuso o dell'ingenuo, ma, al contrario, un motivo di lotta reale per l'emancipazione reale, terrena, delle categorie sociali più deboli. Ergo: i teologi della liberazione e i cristiani per il socialismo hanno dimostrato che il giudizio marxista sulla religione dev'essere completamente rivisto, poiché solo con un'analisi storica e politica si può verificare quando e come la religione è alienazione, quando e come non lo è.
Questo modo di vedere le cose è sostanzialmente giusto. Anzitutto è vero che il marxismo, se vuole restare dialettico e soprattutto se non vuole diventare settario, non deve limitarsi a un giudizio ideologico (o di principio) sulla religione, ma confrontarsi di volta in volta con questo fenomeno sul terreno più propriamente politico. Un partito di sinistra che restasse indifferente di fronte al credente che decide di lottare per un cambiamento sostanziale della realtà in cui vive, non mostrerebbe certo d'essere democratico e pluralista. Se un credente vuole militare in tale partito o se è anche solo interessato, in qualità di simpatizzante, al suo programma politico, sarà del tutto naturale considerarlo come un credente progressista.
Qui l'unica osservazione che forse è lecito fare è che al credente che milita nelle fila di un partito comunista sarebbe lecito chiedere la separazione della fede dalla politica. Se tale credente pensa di realizzare gli ideali della sua religione mediante la lotta di classe, ciò deve restare un suo patrimonio personale, poiché altri credenti nel medesimo partito potrebbero avere opinioni diverse dalla sua. Una condizione del genere i cristiano-socialisti, che rifiutano sia la netta separazione di fede e politica, sia un nesso vissuto a livello di mera coscienza, difficilmente potrebbero accettarla. Per loro la fede deve avere un risvolto politico nella "chiesa popolare".
In ogni caso il marxismo dovrebbe cercare di capire, anche sul piano storico-culturale, dove come e quando il fenomeno religioso contribuisce e ha contribuito allo sviluppo della libertà e della giustizia nella storia e quando invece svolge o ha svolto un ruolo regressivo. Questo per dire che non ha senso attribuire alla religione, in sé e per sé, una funzione reazionaria, oscurantista. I giudizi categorici (siano essi politici o culturali) sono sempre fuorvianti, anche perché impediscono il dialogo, il confronto su posizioni che possono anche avere molti punti in comune. Il marxismo p.es. non hai mai elaborato una storiografia delle idee religiose progressiste in correlazione allo sviluppo socio-economico e politico di determinate formazioni sociali. Il motivo di questo probabilmente è dipeso dal fatto che alla tesi marxiana secondo cui "la religione non ha storia propria" si è voluta dare un'interpretazione unilaterale.
Il marxismo può anche sostenere che la religione di per sé sia un retaggio del passato e che essa nella storia abbia svolto un ruolo prevalentemente conservatore e che nel presente assai raramente s'incontrano credenti progressisti che abbracciano la causa del socialismo; tuttavia, nonostante questo, si deve continuare ad affermare, sia per la vita reale che per gli studi sul passato, una certa differenza tra credente e religione, nel senso che è possibile che una determinata religione abbia dei principi assai migliori dei credenti che li mettono in pratica, ed è possibile anche il contrario, e cioè che esistano dei credenti assai migliori della religione che professano.
Poiché a partire dal marxismo si è arrivati alla conclusione che con la religione non si è in grado di risolvere alcun problema sociale, Lenin arrivò a dire che se un credente progressista vuole abbracciare la causa del socialismo rivoluzionario, inevitabilmente soffrirà di una "personale contraddizione", ma non per questo il partito dovrà rifiutarlo come militante. In fondo l'Ottobre è stato fatto anche da numerosi seguaci della religione ortodossa ed ebraica. Questo poi senza considerare che attraverso l'assistenzialismo, il volontariato e altri aspetti di carità sociale la religione riesce ad affrontare spesso situazioni di disagio con un forte senso della concretezza, che sfugge a chi è abituato ad affrontare le cose in maniera prevalentemente politica o culturale.
Dunque, che importanza può avere sapere se in Americalatina quei credenti che scelgono la via rivoluzionaria lo fanno in virtù della loro religione o nonostante questa religione? Il marxismo sostiene che non è possibile giudicare un uomo sulla base di quello che lui pensa di se stesso, in quanto ciò che conta alla fine è solo la sua posizione di classe, cioè il ruolo oggettivo ch'egli ricopre nel processo rivoluzionario; ebbene, se questo è vero, allora il marxismo dovrebbe sospendere qualunque giudizio sull'atteggiamento che un individuo assume nei confronti della religione.
Se un credente diventa rivoluzionario, ciò probabilmente dipende da fattori sociali di forte privazione: tutta la storia del cristianesimo è piena di casi del genere (si pensi solo alle eresie medievali). Oggi ci meravigliamo di questo semplicemente perché in Occidente la coscienza comune del cittadino è più orientata verso l'ateismo o l'agnosticismo che non verso la religione, ma il fatto che il cittadino ateo occidentale non sia affatto rivoluzionario e non nutra in genere alcuna simpatia o alcun interesse per le forze rivoluzionarie del Terzo mondo, cosa ci deve far pensare?
L'ateismo è stato rivoluzionario nei confronti della religione, ma oggi si trova ad essere oscurantista nei confronti di una rivoluzione politica condotta da credenti. Le cose stanno forse in questi termini?
Un'affermazione del genere ovviamente non ha senso, poiché qui si è finito col mescolare due realtà che dovrebbero restare separate: la politica e la religione. Infatti, non è l'ateismo indifferente alla rivoluzione dei credenti, ma è il soggetto occidentale che, proprio per la sua posizione di classe, non può che restare indifferente alle rivendicazioni che minacciano la sua sicurezza. Qui l'ateismo è del tutto incidentale. Cioè esso può anche riflettere una posizione culturale più avanzata di quella religiosa terzomondista, ma se questa acquisizione non si traduce sul piano politico in direzione del socialismo, alla fine quale posizione culturale risulterà più avanzata?
Dunque, come si può notare, ateismo e religione, messi al cospetto di esigenze rivoluzionarie, risultano in sostanza equivalenti. Di rilievo è il fatto che il magistero della chiesa romana, pur vedendo che non viene messa in discussione la fede, non riesce assolutamente a tollerare il connubio con una prassi rivoluzionaria legata alle idee del socialismo. Gli intellettuali credenti terzomondisti sono addirittura arrivati a reinterpretare in chiave rivoluzionaria molti brani biblici (specie quelli dell'Antico testamento), discostandosi alquanto dalle versioni ufficiali del magistero.
La Teologia della liberazione è il frutto più maturo che la chiesa cristiana abbia mai prodotto dai tempi del cristianesimo primitivo. Essa supera la stessa teologia del vangelo e qualsiasi altra moderna teologia di qualsivoglia confessione. E' potuto accadere questo non tanto perché essa è sorta in una società peggiore di altre, quanto perché è venuta a contatto con una fonte di ispirazione -il socialismo scientifico- che mai nessuna epoca precedente aveva conosciuto.
La fede di questi cristiani non trova un vero riscontro nella storia del cristianesimo semplicemente perché lo stretto legame col socialismo scientifico l'ha modificata nettamente, facendole perdere le sembianze della fede tradizionale (che resta ferma su posizioni attendiste: la speranza dei poveri, o su posizioni conservatrici: la carità dei ricchi).
La fede dei cristiano-socialisti è un valore umano inserito in una cornice religiosa. Non potendo rinunciare di colpo alla loro tradizione culturale, questi cristiani fanno risalire tale valore alla fonte del vangelo, ma l'interpretazione che ne danno ha poco e nulla di religioso. Essi in un certo senso hanno soppresso la fede realizzandola politicamente. Un'esperienza del genere in Europa è stata vissuta, in maniera molto meno intensa, dalle frange del movimento modernista o da quelle esperienze marginali di cattolici comunisti, che in genere si sono risolte con una fuoriuscita dalla chiesa romana.
(1) Alla Conferenza, dei partiti comunisti dell'America del Sud (Buenos Aires. 5-7 luglio 1984) si è, fra l'altro, rilevato che "alla lotta di liberazione contribuisce la partecipazione notevole dei credenti e non di rado anche della chiesa stessa, e di alcuni suoi esponenti più illuminati. Tutto ciò mostra che si sono create enormi possibilità per l'unità d'azione e per un'ampia comprensione reciproca". (torna su)