METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA
Dalle conoscenze alle competenze, passando per le opzioni
COME STUDIARE LA STORIA
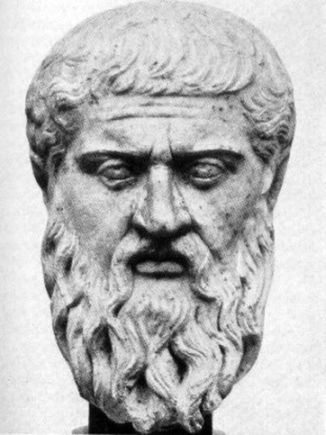
Uno storico dovrebbe trovare delle costanti nelle vicende storiche mondiali, tali per cui una persona qualunque sia indotta a credere nella possibilità di una lettura scientifica a prescindere dall'analisi dettagliata dei particolari della singola vicenda; o, se vogliamo, l'analisi delle vicende dovrebbe poter servire, fatta salva l'individuazione delle costanti, come concreta dimostrazione paradigmatica della fondatezza di quest'ultime.
E' possibile trasformare la storia in una sorta di "scienza esatta"? Se è possibile dimostrare che esistono delle costanti nello sviluppo degli avvenimenti di qualunque luogo e tempo, lo studio di questi avvenimenti può in un certo senso essere decontestualizzato, e finalmente si può affrontare uno studio della storia per concetti, dove la contestualizzazione serve solo per giustificare la diversità delle forme e dei modi.
L'idea in sostanza è quella di permettere che l'astrazione superi la realtà contingente, affinché si possa avere una visione d'insieme, olistica, di un intero periodo storico o di una o più civiltà.
In tal modo, aumentando il livello di astrazione, è possibile elaborare le linee di un'interpretazione della storia mondiale dell'uomo.
Per arrivare a definire le leggi scientifiche degli avvenimenti storici, cioè le costanti che si diversificano solo negli aspetti di forma e non di sostanza, occorre stabilire una visione sinottica delle civiltà ed estrapolare dalle vicende le linee di tendenza che nell'essenza si ripetono.
Se arriviamo ad elaborare delle leggi scientifiche, oggettive, che tengano in considerazione non solo la categoria della necessità ma anche quella della libertà, che è tipica dell'essere umano, non ci sarà avvenimento storico che non potrà non essere adeguatamente interpretato.
E' difficile però accettare l'idea che la scientificità possa basarsi sulla categoria della libertà. La mutevolezza delle scelte umane sembra escludere a priori un esame scientifico degli avvenimenti; eppure bisogna convincersi che la legge scientifica della corrispondenza tra azione e reazione si può in qualche modo applicare anche ai comportamenti umani. Il problema semmai è definire che cosa è "umano" e che cosa non lo è.
In una storia del genere le responsabilità dello svolgersi degli avvenimenti ricadono su intere popolazioni e non esclusivamente sui loro rappresentanti istituzionali o ufficiali. Il singolo rientra nel concetto di comunità. Questo non significa "una storia senza soggetto" (come voleva Althusser), ma semplicemente che la storia viene fatta non tanto da individui singoli, quanto dalle masse, con differenti livelli di responsabilità.
Il problema comunque è sempre quello di come uscire dal nozionismo e di come fare ricerca storica o, se si vuole, di come sfruttare la cognizione delle leggi storiche per fare opera di riflessione culturale e politica, utile per il presente.
E' fuor di dubbio infatti che lo studio olistico della storia ha senso solo se aiuta a vivere meglio il presente o a meglio comprenderlo.
Noi possiamo eliminare lo studio nozionistico dei dettagli di ogni singola civiltà, per concentrarsi sulle costanti, sulle linee di fondo trasversali a tutte le civiltà, o meglio, a tutte le formazioni sociali, di cui le civiltà sono una, non l'unica, espressione (a meno che non si voglia intendere col concetto di "civiltà" una qualunque formazione sociale, anche primitiva o comunque non basata sullo schiavismo o sul servaggio).
Possiamo eliminare lo studio dei dettagli per concentrarci sullo studio dei fondamenti strategici di una civiltà, ma resta sempre il problema di come trasformare la conoscenza di questi fondamenti in uno stimolo per la crescita personale e per lo sviluppo della società in cui si vive.
* * *
Quando si studia la storia come disciplina scolastica, la priorità andrebbe data all'economia, poiché la storia economica, meglio di qualunque altra storia, permette di concatenare i fatti e le diverse epoche.
Quando invece si prende in esame il "pensiero" degli uomini, occorre dare un certo risalto alle idee politiche, poiché esse costituiscono una sintesi di tutte le altre idee, nonché una loro verifica applicativa.
Bisogna comunque fare attenzione che la storia fornisce documenti scritti per lo più da uomini legati al potere politico istituzionale, e la documentazione per così "eversiva" spesso è rimasta non tradotta o è andata perduta, o comunque ha subito ampie forme di marginalizzazione. Forse il primo vero momento storico in cui la documentazione controcorrente ha avuto un certo successo, è stato quello successivo alla rivoluzione francese, cioè quello che coincide con la nascita del socialismo utopistico, superato poi da quello scientifico. Se fra mille anni uno storico esaminasse la storia dei secoli XIX e XX troverebbe sicuramente molti più materiali, ideologicamente contrapposti, di quanti ne riesca a trovare oggi uno storico che esamini la storia greco-romana.
Dall'esame dei testi politici si può poi risalire all'etica, alla filosofia..., nonché alle concezioni socio-economiche, di una classe o di un'altra. E' stato il leninismo a insegnarci che la politica può essere considerata una sintesi dell'economia.
Questo per dire che se anche l'etica, la filosofia ecc. dicono cose opposte a quelle affermate e realizzate in sede politica, ciò non va considerato come una dimostrazione dell'autonomia di queste scienze, ma al contrario come la riprova ch'esse dipendono da una forma politica alienata, che a sua volta riflette un'economia di tipo antagonistico.
* * *
Compito della scuola dovrebbe essere, anzitutto, quello di far capire il presente, che ha una priorità sia sul passato che sul futuro. E' impossibile capire il passato senza conoscere il presente, e chi vuole vivere e conoscere a fondo il presente, deve avere del passato un quadro molto sintetico, essenziale.
E' vero, il presente può essere meglio compreso se si vanno a ricercare nel passato le motivazioni storiche del suo esistere (delle sue contraddizioni), ma questo non significa che il passato possa offrirci le soluzioni dei nostri problemi. La libertà dell'uomo deve giocarsi nelle contraddizioni del presente.
La storia dunque andrebbe fatta a partire dal presente, rivolgendosi al passato per cercare agganci col presente. Come si può pretendere che il giovane consideri "vivo" un tempo morto, quando per lui la scuola rende "morto" un tempo vivo. Se esiste un presente significa che il senso del passato non si esaurisce nel passato.
* * *
Oltre a ciò va detto che lo studio della storia, come scienza a sé, ha poco senso, in quanto ogni disciplina deve chiarire i propri limiti epistemologici, i quali a loro volta dipendono da determinate condizioni storico-culturali. La storia va considerata come argomento trasversale a tutte le discipline, incluse quelle scientifiche.
Quindi p.es. niente matematica senza storia della matematica e senza storia della civiltà in cui essa, come pensiero scientifico astratto, si è sviluppata.
Questo d'altra parte è l'unico modo in cui si possa capire il motivo per cui è nata una determinata scienza, e soprattutto il motivo per cui una medesima scoperta scientifica ha prodotto in un determinato contesto spazio-temporale conseguenze del tutto opposte a quelle prodotte in contesti differenti.
* * *
Di fondamentale importanza è il fatto che quando si fa un'analisi storica di un determinato fenomeno, bisognerebbe anzitutto distinguere tra ciò che il fenomeno poteva apparire ai contemporanei che l'hanno vissuto e ciò che il fenomeno appare a noi, che non l'abbiamo vissuto e che per questo possiamo osservarlo con distacco, nella consapevolezza dei suoi limiti.
Facciamo un esempio. Se nell'esaminare il nazismo, noi lo presentiamo solo nella sua negatività, che pur è stata evidente, noi non aiutiamo lo studente a capire il motivo per cui tantissima gente (milioni di persone), coeva a quel fenomeno, lo riteneva un evento positivo, da sostenere persino in maniera incondizionata. Se ci comportassimo così, dovremmo poi attribuire a una qualche caratteristica negativa di un intero popolo il fatto d'aver compiuto una determinata scelta. Cioè dovremmo affidarci alla psicologia o addirittura alla genetica per trovare spiegazioni di natura socio-economica.
Noi non possiamo presentare le cose col senno del poi. Non possiamo partire da tesi precostituite se vogliamo abituare lo studente a capire che nella vita si devono operare delle scelte e che quelle migliori per i destini delle generazioni non sono immediatamente visibili nel momento in cui si deve scegliere.
Alla verità ci si deve arrivare per gradi, per fasi successive, conseguenti, in maniera progressiva. Generalmente la verità è qualcosa di molto ambiguo nel suo svolgimento.