METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA
Dalle conoscenze alle competenze, passando per le opzioni
PASSATO E PRESENTE
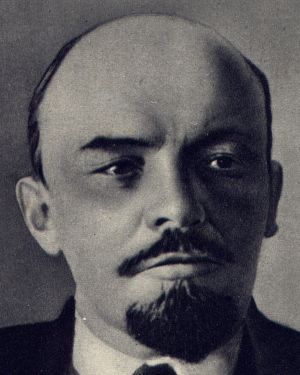
E' assurdo tentare di comprendere qualcosa del passato dall'alto del proprio presente. Per poter essere minimamente capito, il passato andrebbe studiato come se fosse un presente, cioè andrebbe in un certo senso rivissuto, e non tanto nelle forme esteriori, quanto proprio nella sostanza dei problemi, che sono poi quelli che hanno portato gli uomini a compiere determinate scelte.
Occorre capire la centralità dei problemi, il modo come l'uomo si è posto di fronte ad essi, infine le scelte operate e verso quali nuovi problemi queste scelte hanno portato. L'evoluzione dell'uomo non procede in linea retta.
Indicativamente si potrebbe dire che la storia è lo svolgimento di formazioni sociali differenti, in relazione a scelte che si sono dovute compiere tra due grandi esigenze più o meno contrapposte: quelle che trovano le loro ragioni o nell'individualismo o nel collettivismo.
Queste due esigenze s'intrecciano continuamente in ogni formazione sociale, nel senso che non esiste una formazione sociale del tutto individualistica o del tutto collettivistica. Quando ciò si presenta o si ha la pretesa (da parte delle istituzioni al potere) che si presenti, la crisi della società è giunta ad una fase molto acuta e la sua trasformazione drammatica è inevitabile.
La storia è l'altalenarsi continuo di una propensione concessa a questa o quella forma di esperienza sociale. Là dove prevale l'individuo, il collettivo è sacrificato e, in genere, viene visto come un impedimento allo sviluppo della personalità, alla creatività dell'individuo singolo.
Viceversa, là dove prevale il collettivo, spesso il singolo non è che un numero, un'astrazione, come nei regimi amministrati di tipo statalista.
Una formazione sociale naturale è quella dove l'equilibrio tra singolo e collettivo è costante, senza essere soggetto a pericolose oscillazioni, all'interno delle quali un aspetto finisce con l'escludere l'altro.
* * *
Il passato dovrebbe essere visto in funzione del presente, poiché di fatto esiste solo il presente. Senza uno studio del presente, lo studio del passato non serve a nulla.
Nella scuola la storia viene studiata come una cosa del passato, cioè morta. La stessa scuola, non sapendo interagire col presente ma solo col passato, è come se apparisse morta. Infatti si studia sui libri non sui problemi, cioè lo studio sui libri è aprioristico e non una conseguenza dei problemi che si devono affrontare.
Si studia non su eventi in movimento, ma su eventi statici, predefiniti, il cui significato è un già dato, un dato acquisito che va solo memorizzato.
A scuola non si impara neppure l'evoluzione del dato acquisito. Il dato, infatti, è acquisito appunto perché va dato per scontato. La sua evoluzione, se e quando affrontata, è un altro dato di fatti concatenati in maniera necessaria, come se ad ogni causa potesse corrispondere solo un determinato effetto.
Affrontare i fatti in questa maniera, cioè come se essi non fossero il frutto di scelte difficili, compiute di fronte a determinati problemi, non serve a nulla. Lo studente non riesce ad apprendere la necessità di operare delle scelte decisive, strategiche, per loro natura rischiose, tipiche della libertà umana.
Lo studio del passato ha senso solo nella misura in cui può servire a far vivere meglio il presente. Questa non è un'espressione statica, in quanto non si vuole affatto dare per scontato che l'attuale configurazione del presente sia un "dato di fatto". Ogni presente ha in sé delle contraddizioni che vanno risolte in maniera progressiva. Il passato va studiato nella misura in cui aiuta a comprendere e risolvere queste contraddizioni. Studiare il passato in maniera evolutiva, come una successione temporale di fatti che si cerca di collegare secondo lo schema di causa ed effetto, non serve a nulla. Anche perché in tal modo si dà per scontato che il senso ultimo del passato risieda nel presente, in forza del fatto che il presente è visibile, contemporaneo all'uomo, che può guardare dall'alto ciò che lo ha preceduto.
Il significato del passato non sta nel presente, altrimenti si sarebbe costretti a ipotecare il futuro. Il presente deve limitarsi a cercare nel passato quelle indicazioni che possono aiutare l'uomo a vivere meglio il suo presente. Avere un passato significa avere un aiuto in più, sempre che questo passato non venga vissuto come un potere vincolante, come una sorta di forca caudina per il presente. L'uomo deve essere libero di fare le sue scelte: il passato ha senso se lo aiuta in questo compito.
* * *
L'accettazione degli eventi storici secondo un criterio di ineluttabilità non fa progredire di un passo la comprensione dei meccanismi dinamici della libertà umana. Si usa la categoria della necessità come se la libertà fosse un peso gravoso da sopportare e non la fondamentale risorsa che distingue la consapevolezza dall'istinto.
Avere senso storico significa sostanzialmente saper esaminare le diverse opzioni culturali presenti nel momento in cui sono state prese determinate decisioni.
Se la tendenza è quella di giustificare il proprio presente (e non quella di relativizzarlo o di contestualizzarlo), si finirà necessariamente col valorizzare del passato solo quelle scelte (strategiche) che hanno contribuito a generare questo presente.
La conseguenza è che si considera di qualità inferiore (p.es. di matrice utopistica) tutto ciò che è risultato perdente, come fosse inesorabilmente destinato a uscire sconfitto dalla storia.
Ovviamente è impossibile per uno storico cercare le alternative nel passato quando come cittadino egli non le cerca neppure nel suo presente.
La storia non è una sequenza sconclusionata di eventi i cui protagonisti si sono affermati solo perché erano più forti di altri. La storia è piuttosto una rappresentazione drammatica delle molteplici possibilità che gli uomini hanno di discostarsi da ciò che dovrebbero essere.
PASSATO PRESENTE FUTURO
Un essere umano vive veramente il suo tempo quando considera il presente assolutamente prioritario rispetto al passato (la nostalgia o la memoria) e al futuro (l'illusione o il desiderio).
La memoria del passato e il desiderio del futuro non sono nulla senza l'esperienza del presente.
E' il presente che detta le regole interpretative del passato e che pone le condizioni dello sviluppo del futuro. Che questo avvenga in maniera giusta o sbagliata solo la storia può dirlo.
Gli uomini devono limitarsi ad assumere delle responsabilità soltanto in relazione al loro presente.
Il passato potrà mai un giorno essere compiutamente conosciuto? Per poter vivere adeguatamente il presente è necessario conoscere compiutamente il passato?
Probabilmente sono vere due cose che in apparenza si contraddicono:
- noi non potremo mai compiutamente conoscere il passato;
- nonostante questo, noi nel presente abbiamo sufficienti elementi per poter vivere nel migliore dei modi.
Ogni presente è sufficiente a se stesso, nonostante l'ignoranza più o meno grande che si può avere del passato.
Tuttavia si potrebbe anche dire che il presente è tanto più difficile da vivere quanto più è scarsa la memoria del passato.
E' vero che il passato non può porre delle ipoteche sul presente, nel senso ch'esso rappresenta soltanto un contributo che, nella libertà dei soggetti, può migliorare le condizioni della vita (sempre che sia stata un'esperienza conforme ai principi umanistici e naturalistici).
Ma è anche vero che il presente ha sempre un primato sul passato. Noi siamo ad affrontare e, possibilmente, a risolvere i problemi degli uomini contemporanei. Ogni aiuto che, in tal senso, può offrire il passato, deve essere tenuto nella massima considerazione. Non foss'altro che per una ragione molto semplice: l'uomo è sempre lo stesso, sono soltanto le forme della sua esistenza che cambiano. Il problema di compiere delle scelte o di porre dei limiti alla libertà è sempre uguale.
MEMORIA E DESIDERIO
E' difficile pensare che nel passato sia esistito qualcosa la cui dimenticanza oggi ci impedisce di diventare veramente umani.
L'umanità dell'uomo è intrinseca all'uomo stesso: la perdita della sua memoria non implica automaticamente quella del suo desiderio.
Il desiderio possiede una memoria inconscia, che la memoria non conosce.
L'unica difficoltà sta nel recupero di questa memoria: quanto meno forte è stata la dimenticanza, tanto meno forte dovrebbe essere il desiderio per recuperare la memoria. E viceversa: quanto più forte la dimenticanza, tanto più forte deve essere il desiderio.
Tuttavia, questi processi non sono mai automatici, poiché insieme alla memoria e al desiderio vi è anche l'interesse di chi vuol conservare la dimenticanza e alimentare falsi desideri.
L'opposizione alla memoria e al desiderio fa parte del gioco della libertà, per quanto la vera libertà non stia nella possibilità di scelta - come si crede in occidente - ma nell'esperienza del valore umano. La libertà di scelta non è in realtà che libero arbitrio, cioè la premessa non la sostanza della libertà.
La libertà, quando è vissuta, non esclude mai il libero arbitrio. In occidente la libertà è così poco vissuta - come esperienza del valore (il bene) - che si è stati costretti a farla coincidere, stricto sensu, con la facoltà del libero arbitrio. L'uomo occidentale è libero solo quando sceglie, solo nel momento in cui può fare una scelta tra il bene e il male, che poi la libertà borghese è l'esperienza dell'unica realtà veramente appagante: quella del profitto.
L'illusione che ci propinano è quella di poter scegliere, la menzogna è quella di farci credere di aver fatto la scelta giusta scegliendo il peggio.
Il fatto è che in questa civiltà, come in tutte le civiltà antagonistiche, la scelta viene fatta tra cose decise da altri, i quali dispongono di immensi poteri politici ed economici e non hanno interesse a che venga fatta la scelta giusta.
Quando si pensa di aver fatto una scelta giusta è perché in realtà si è fatta una scelta di comodo, non di valore (o comunque si è scelto un valore negativo); se invece si è fatta una scelta sbagliata, facilmente ci si sente dei condannati a morte, incapaci di risalire la china.
Si deve sempre avere il coraggio di fare scelte controcorrenti. Ma anche questa, detta così, è una definizione astratta. Le scelte veramente coraggiose sono quelle di chi si mette dalla parte di chi non può scegliere.
* * *
Il modo che hanno gli storici di considerare il passato come qualcosa di accaduto prima del presente, e quindi come qualcosa di concluso in sé, in maniera oggettiva e irripetibile, e che è tanto più "passato" quanto più è "lontano", è un modo di presentare e interpretare le cose che riflette il nostro tempo, proiettato verso il futuro (anche se oggi, in verità, con sempre meno sicurezze), ma non si può dire sia un modo naturale di concepire l'esistenza e il fluire del tempo.
La nostra epoca, sin dal Cinquecento (in Italia dal Mille, salvo il ripensamento in extremis, ma tardivo, della Controriforma), ha voluto imporsi negando valore al passato; sicché la memoria storica è andata inevitabilmente perduta.
Si è puntato tutto sul dubbio, sulla critica, sull'istanza di rinnovamento, sulla fine delle tradizioni e dell'autorità, sull'affermazione dell'idea di progresso indefinito, di sviluppo tecnologico ed economico inarrestabile. Il passato è diventato morto semplicemente perché è stato ucciso.
Così oggi non abbiamo più memoria di quel che eravamo. Il passato per la prima volta, con la civiltà borghese, è diventato "remoto" e ha smesso di scorrere nelle vene del presente. Non ce lo portiamo più con noi, nel nostro bagaglio di esperienze e conoscenze acquisite, se non, al massimo, come nostalgia di un mondo irrimediabilmente perduto.
Così facendo, abbiamo stravolto anche le caratteristiche del nostro desiderio, che sono diventate molto più individualistiche, settarie. Noi viviamo per realizzare un semplice desiderio di soddisfazione personale. Non c'è più coincidenza tra desiderio personale e desiderio collettivo, proprio perché non c'è più da salvaguardare una memoria comune.
Nel nostro cervello la memoria è scomparsa, forse si conserva in qualche angolo remoto dell'inconscio: quella che abbiamo è a breve termine, e il desiderio che le è correlato l'abbiamo ridotto alla mera necessità di sopravvivere in una società ove dominano i rapporti di forza, lo scontro tra egoismi particolari.