METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA
Dalle conoscenze alle competenze, passando per le opzioni
LO STUDIO DELLE CIVILTA'
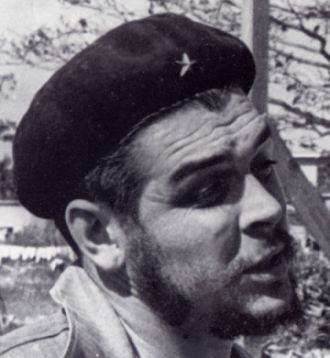
Lo studio delle civiltà sarebbe la cosa più interessante se si ponesse come analisi delle trasformazioni da una civiltà a un'altra.
La nostra stessa civiltà - che è quella borghese o capitalistica (anche se la borghesia la definisce con altri termini: p.es. "democratica", "liberale", "industriale", "tecnologica", "mediatica", sino a quelli più generici come "avanzata", "complessa" ecc.) - andrebbe studiata in rapporto a ciò che l'ha preceduta e anche in rapporto a ciò che potrebbe superarla o sostituirla. In tal modo si capirebbero meglio i pregi e i difetti.
Invece gli storici fanno il processo inverso: considerano la nostra civiltà come il metro di paragone di tutte le altre, e così non solo non comprendono nulla delle civiltà passate, ma non vedono neppure i veri limiti di quella presente né i tipi di soluzione possibili per le sue gravi contraddizioni.
Le civiltà sono relative, nel senso che ognuna ha in sé elementi di successo e di sconfitta. E' strano che gli storici, abituati come sono a studiare l'evoluzione delle cose, non siano capaci di applicare il concetto di "relativismo" alla stessa civiltà in cui vivono.
Certo, nel momento in cui si è contemporanei a una determinata civiltà, si pensa inevitabilmente ch'essa sia la migliore o che debba durare il più possibile; tuttavia, è proprio lo studio della storia che dovrebbe risparmiarci queste pie illusioni.
Le civiltà nascono, si sviluppano e muoiono - e così sarà per la nostra. Ecco perché bisognerebbe cercare di porre sin da adesso le fondamenta della civiltà prossima a venire.
Se gli uomini si sentissero parte della storia di un popolo, che vive attraverso varie civiltà, forse non attribuirebbero a se stessi delle qualità che non hanno e che non possono avere.
CIVILTA' E INCIVILTA'
Una popolazione pre-schiavistica e quindi anteriore alle cosiddette "civiltà" non può essere chiamata "primitiva", perché il concetto di "primitivo" non deve essere contrapposto a quello di "civilizzato", altrimenti col termine "primitivo" noi rischiamo di sottintendere altri concetti che storicamente sono falsi o non provati: quelli di "rozzo", "barbaro", "incivile"...
Il termine "primitivo", per come lo usiamo noi occidentali, non è mai neutro, cioè non è mai un semplice termine, ma esprime un concetto di valore vero e proprio, che a sua volta rappresenta un inequivocabile stato di fatto. "Primitivo" non è semplicemente "colui che viene prima", ma soprattutto "colui che non è civile", e per "civile" noi occidentali, normalmente, annoveriamo le civiltà che conoscevano la scrittura, il progresso tecnico-scientifico, un'organizzazione politica di tipo monarchico o repubblicano e sempre fondata sulla separazione delle classi, un apparato amministrativo e militare molto sviluppato, una netta divisione dei lavori e delle proprietà... in una parola tutte le civiltà che conoscevano e praticavano lo schiavismo.
I manuali di storia non hanno neppure il termine di "civiltà primitive", proprio perché lo considerano un controsenso. Una popolazione pre-schiavistica non ha dato origine ad alcuna "civiltà", proprio perché non ne aveva gli strumenti, le possibilità. Non a caso tutte le popolazioni nomadi vengono definite "tribù primitive", mentre le popolazione sedentarie vengono messe a capo della nascita delle "civiltà". Quando i nomadi sconfiggono i sedentari, allora gli storici dicono che si ha un regresso nello sviluppo sociale, politico, culturale ecc.
Da questo punto di vista sarebbe meglio usare il termine "primitivo" come sinonimo di "rozzo", "incivile", "ignorante" (non solo nella conoscenza ma anche nella moralità), in riferimento a qualunque atteggiamento, di ogni epoca e latitudine, che risulti nocivo o agli interessi delle masse popolari o alla natura nel suo complesso.
Per il nostro modo di saccheggiare le risorse naturali o di sfruttare il lavoro altrui noi occidentali siamo molto più "primitivi" degli uomini vissuti milioni di anni fa.
Al posto di "primitivo" o di "selvaggio", per indicare le popolazioni di milioni di anni fa, noi dovremmo usare termini come "originario", "primordiale" o "ancestrale". Sono "prime" non "primitive" quelle popolazioni esistite prima di noi, agli albori della nascita dell'uomo in generale e non tanto delle civiltà in particolare. Per indicare una popolazione noi non dobbiamo usare dei termini che di per sé esprimono dei giudizi di valore.
Le popolazioni potrebbero anche essere suddivise in "stanziali" o "sedentarie" e "nomadi" o "itineranti", "agricole" e "allevatrici", senza che per questo lo storico debba sentirsi in diritto di esprimere giudizi di valore su questa o quella forma di conduzione sociale della vita. I confronti sono sempre relativi.
Una popolazione che usa la scrittura non può essere considerata, solo per questo, più "civile" di quella che si basava sulla trasmissione orale delle conoscenze. Quando i legami tribali sono molto forti, la tradizione orale è più che sufficiente. Per milioni di anni gli uomini non hanno conosciuto la scrittura, ma non per questo la storia si è fermata.
La trasmissione orale delle conoscenze e delle esperienze offriva un certo senso della storia, utile alla conservazione e riproduzione del genere umano e dei suoi valori, secondo leggi di natura, anche se questa trasmissione era infarcita di elementi mitologici, favolistici, che costituivano la cornice fantasiosa di un quadro sostanzialmente realistico.
Non ha senso definire "barbare" le popolazioni che non si riconoscevano nella civiltà greco-romana: lo schiavismo è nato in questa civiltà e non tra i barbari. Diamo dunque un nome alle popolazioni sulla base della loro provenienza geografica o sulla base delle caratteristiche linguistiche o religiose, ma non usiamo una terminologia comparativa che a priori considera più avanzato solo quanto ci appartiene: oggi peraltro non sappiamo neppure quanto sia "nostro" e quanto no.
Ogni popolazione può avere aspetti di grandezza e di miseria, quindi forme di civiltà e di primitivismo. Le forme di civiltà sono il tentativo di superare il proprio primitivismo. E in questi tentativi si compiono passi avanti ma anche passi indietro, perché questo andirivieni fa parte della natura umana.
Non esiste un vero progresso all'infinito, ma solo il fatto che si compiono scelte diverse, che impongono diverse consapevolezze, diverse forme di responsabilità.
Non dimentichiamo che i peggiori crimini contro l'umanità noi li abbiamo compiuti nel XX secolo.
HOMO PRIMITIVUS
Ciò che ancora si deve chiarire è la seguente cosa: il processo di umanizzazione è stato ed è lungo e complicato perché va posto in relazione all'emancipazione dal mondo animale, nel senso che sono progressive determinazioni quantitative che ci fanno lentamente ma progressivamente emancipare dal mondo animale, oppure perché l'essere umano va considerato come un essere di per sé complesso, nel senso che lo sviluppo dell'umanità non è altro che una sorta di molteplici caratterizzazioni di determinazioni qualitative innate?
Se è vera la prima ipotesi, noi possiamo pensare a uno sviluppo progressivo, come è facile che sia, poiché è evidente la superiorità dell'essere umano sul mondo animale.
Ma se è vera la seconda ipotesi, occorre abolire qualunque idea di progresso e introdurre il concetto di relativismo storico.
E' difficile dire che gli uomini di oggi hanno una coscienza della loro umanità superiore a quella che potevano avere mille, diecimila o un milione di anni fa.
Non sono le circostanze esteriori, materiali o fenomeniche, che rendono più o meno grande tale consapevolezza, altrimenti si sarebbe costretti ad affermare che popolazioni prive di scienza e di tecnica evolute dovrebbero essere considerate dal punto di vista della consapevolezza umana, assolutamente primitive.
Come d'altra parte è assurdo sostenere che, solo per il fatto di non aver lasciato nulla di scritto, determinate popolazioni possono essere considerate umanamente sottosviluppate.
Noi oggi siamo talmente condizionati dalla scienza e dalla tecnica che non siamo più capaci di stabilire dei parametri qualitativi con cui indicizzare e monitorare l'umanità dell'uomo, a prescindere dai mezzi tecnico-scientifici impiegati.
Per noi l'essere umano è anzitutto l'homo technologicus, oltre il quale esiste solo l'homo animalis, l'uomo assolutamente primitivo, ferino, come - a partire dal mondo greco-romano - si presumeva fossero le popolazioni cosiddette "barbariche".
* * *
Probabilmente l'essere umano è nato nel momento stesso in cui lo sviluppo delle tipologie animalesche si era talmente ramificato da rendere impossibile o inutile un'ulteriore diversificazione ai fini della tutela della specie animale in quanto tale.
Nel senso che un'ulteriore diversificazione sarebbe stata possibile solo se la natura avesse puntato su degli aspetti qualitativi fino a quel momento poco o nulla sviluppati (si pensi p.es. alla sensibilità, ai sentimenti, alla coscienza, al pensiero...). In particolare, con la nascita dell'uomo la natura, in un certo senso, ha superato se stessa, poiché ha introdotto il concetto di libertà.
L'essere umano è in grado di compiere delle scelte che non necessariamente sono motivate dall'istinto o da circostanze esteriori. Questo significa che se da un lato è giusto parlare di evoluzione, in quanto l'essere umano è conseguente allo sviluppo del mondo animale, dall'altro occorre introdurre l'idea di "rottura", in quanto la discontinuità ha avuto il sopravvento sulla diversificazione quantitativa.
L'uomo è un essere ontologico la cui essenza non proviene da alcun processo fenomenico particolare. Sotto questo aspetto le scimmie, pur essendo sul piano quantitativo le più vicine all'uomo, sul piano qualitativo gli sono non meno lontane di qualunque altro animale.
Un uomo non può essere definito come tale sulla base di caratterizzazioni somatiche (p.es. la stazione eretta), e neppure sulla base di un'attività lavorativa specifica (p.es. produrre e conservare il fuoco).
Un uomo è tale se è cosciente di quello che fa, cioè se sa che potrebbe non farlo. Un uomo di questo genere non può essere individuato grazie ai reperti fossili.
COSCIENZA E MATERIA
Non si può valutare il livello di civiltà di una formazione sociale dal tasso di tecnologia applicato alle sue opere di edificazione. Una civiltà può essere avanzatissima sul piano tecnologico e nel contempo molto arretrata sul piano dello sviluppo etico.
Coscienza e materia sono due concetti che, pur dovendo coesistere, dispongono di una certa autonomia. Ecco perché un forte sviluppo della materia non implica in maniera automatica un forte sviluppo della coscienza. Di regola, anzi, un forte sviluppo della tecnologia raramente comporta un elevato sviluppo della coscienza. E viceversa.
E' come se il soggetto umano, per restare "umano", avesse un bisogno relativo della tecnologia e un bisogno assoluto della coscienza.
Là dove le civiltà hanno puntato maggiormente l'attenzione sulla tecnologia, lì bisogna porre il dubbio relativo alla loro livello di autoconsapevolezza.
Civiltà fortemente tecnologizzate sembra - agli occhi degli storici - che abbiano lasciato all'umanità grandi conquiste semplicemente perché le civiltà odierne (quelle occidentali) puntano allo stesso modo tutti i loro sforzi sullo sviluppo tecnologico.
In realtà queste civiltà (di ieri e di oggi) non hanno nulla da trasmettere alla coscienza degli uomini; sono civiltà malate e pericolose, proprio perché a motivo della loro forza tecnologica, che è impiegata soprattutto per scopi militari, esse minacciano l'esistenza di altre civiltà e anche quella della natura.
Occorre far sì che queste civiltà non possano nuocere al di fuori dei loro confini; occorre che esse vengano messe nella condizione di dover risolvere le contraddizioni interne utilizzando le proprie risorse e non quelle che possono saccheggiare all'esterno.
E' infatti sintomatico che nonostante la loro vantata tecnologia, queste civiltà riescono a sopravvivere solo a condizione di poter depredare il resto delle civiltà meno evolute sul piano tecnologico e a saccheggiare ogni risorsa naturale.
L'uomo è un ente di natura e sono anzitutto le leggi di natura che vanno rispettate. Queste leggi non prevedono un impiego massiccio della tecnologia, ma anzitutto il rispetto della coscienza e della libertà degli esseri umani.
Si dovrebbe considerare il fatto, nell'analisi storica delle civiltà, che quando la maggioranza della popolazione di una civiltà arriva ad accettare, o per convinzione o per rassegnazione, la modalità immorale o antidemocratica di gestione del potere politico, il destino della civiltà è praticamente segnato. Cioè non vi sono più possibilità di sviluppo.
La popolazione che vive in periferia tenderà a chiedere aiuto alle popolazioni limitrofe, e saranno loro che porranno le basi (morali e di un diverso uso della tecnologia) del futuro sviluppo.
Civiltà immorali e antidemocratiche tendono a distruggere i popoli confinanti, per spogliarli dei loro beni, ma tendono anche a creare delle contraddizioni sempre più acute al loro interno.
La gestione del potere diventa molto difficoltosa, poiché tende a dominare l'egoismo delle classi e degli individui. Si perde la consapevolezza del bene comune.
Queste civiltà, anche se apparentemente sembrano fortissime, in realtà tendono ad autodistruggersi. Sono civiltà che si indeboliscono, perché tutta la loro forza materiale, tecnologica non è supportata da alcuna risorsa morale. Senza peraltro considerare che il loro stesso sviluppo tecnologico innesca dei meccanismi automatici che ben presto sfuggono al controllo degli uomini, in quanto gli effetti a catena ch'essi producono esigono forme di controllo e di sicurezza così sofisticate che praticamente non sono più alla portata delle capacità normali degli uomini.
Domina incontrastata la corruzione e con essa l'inganno, l'insicurezza nella vita sociale. Civiltà di questo genere possono essere facilmente sconfitte se il popolo che le attacca è moralmente solido.
Nell'esame storico di una civiltà bisognerebbe accuratamente separare la questione della morale pubblica da quella delle contraddizioni antagonistiche, che riguardano i rapporti di forza tra le classi.
Non si possono giustificare tali rapporti e neppure misconoscerli o attenuarne la drammaticità, facendo leva sul fatto che anche tra le fila della classe dirigente vi sono soggetti che provano sentimenti umani e cose del genere.
Così facendo si fa un torto a milioni di persone che vivono in condizioni servili. I poveri non hanno bisogno del pietismo per riscattarsi dalla loro condizione.
Poiché l'uomo è un ente di natura la sua tecnologia non può distruggere l'ambiente, pena la sua stessa sopravvivenza come specie. In tal senso la tecnologia dovrebbe essere composta di materiali facilmente riciclabili dalla natura stessa. Ecco perché bisogna trovare un criterio umano di usabilità della tecnologia.
La tecnologia deve permettere uno sviluppo sostenibile, cioè equilibrato, delle società democratiche e una riproduzione garantita dei processi naturali.
Non può essere usata la tecnologia per sfruttare il lavoro altrui, per saccheggiare risorse naturali, specie se queste non sono rinnovabili. Il criterio di usabilità della tecnologia deve essere di utilità sociale e insieme di tutela ambientale. Questi due aspetti devono coesistere uno a fianco dell'altro.
EVOLUZIONE E INVOLUZIONE
Noi non possiamo attribuire il livello di progresso di una popolazione al grado di divisione del lavoro o ad altri fattori meramente economici, senza prendere in considerazione l'insieme delle condizioni sociali, culturali e politiche dell'intera popolazione.
Non sono un indice sicuro di progresso i fattori cosiddetti "dominanti", come p.es. il livello delle forze produttive, che si misura sulla capacità di riprodursi economicamente. E' l'insieme della vita sociale che va preso in considerazione e non un suo singolo aspetto.
Non dobbiamo dimenticare che i guasti principali arrecati al nostro pianeta provengono esclusivamente dalle cosiddette "civiltà", cioè da organizzazioni "avanzate" dell'economia, delle istituzioni, dell'apparato bellico...
Bisogna ripensare totalmente il significato della linea evolutiva che va dalle società tribali alle civiltà. Questo perché, a ben guardare, non c'è stata una vera e propria "evoluzione", ma piuttosto un'involuzione da uno stadio di vita collettivistico a una serie di formazioni sociali individualistiche, in cui le differenze sono soltanto di forma.
Una qualunque transizione al socialismo ha senso solo se porterà il genere umano a vivere in maniera analoga alle società tribali (pre-schiavistiche), ovviamente con una diversa consapevolezza rispetto a quella che gli uomini avevano oltre seimila anni fa (il periodo all'incirca in cui le civiltà sono iniziate).
Si potrà parlare di "evoluzione" solo quando usciremo da questa fase involutiva che ci attanaglia appunto da circa seimila anni. Questo significa che dobbiamo metterci a studiare lo stile di vita delle ultime popolazioni primitive rimaste sul nostro pianeta, perché esse sono le sole che ci possono indicare la strada (pacifica) per lo sviluppo futuro dell'umanità. Dobbiamo studiarle non come un reperto archeologico o socioantropologico, ma proprio come uno stile di vita in grado di assicurare una sopravvivenza al genere umano. Questo significa che dobbiamo recuperare le tradizioni tribali delle popolazioni africane, sudamericane e asiatiche.
Le civiltà non sono ancora riuscite a dimostrare che il loro stile di vita è compatibile con le esigenze riproduttive della natura e con la necessità di una coesistenza pacifica tra i popoli. Noi dobbiamo tutelare tutto ciò che è anteriore a qualunque forma di civiltà.
Se non chiariamo questi presupposti, noi rischiamo di realizzare un socialismo come "civiltà" che avrà contraddizioni ancora più gravi di quelle del capitalismo, come già abbiamo iniziato a vedere nel cosiddetto "socialismo reale" dei paesi est-europei, dove gli aspetti economici risultavano e in quello cinese ancora oggi risultano subordinati a quelli politici, all'interno di un sistema tutt'altro che democratico.
I socialismi utopistici, scientifici, rivoluzionari... vanno considerati come tappe verso il ritorno al comunismo primitivo, ovviamente nella consapevolezza storica dei limiti delle formazioni sociali individualistiche (schiavismo, servaggio, capitalismo) o falsamente collettivistiche (socialismo amministrato, burocratico, statalista). Tuttavia il ritorno dev'essere spontaneo, per evitare che si possa tradurre in una tragica mimesi della realtà. Questo ovviamente non significa rinunciare alla lotta, poiché non ci si può rassegnare all'involuzione.
CIVILTA' E MITOLOGIA
Quanto più aumenta la decadenza di una civiltà, tanto più aumentano le "favole" con cui si cerca di tenerla in piedi. La decadenza irreversibile, percepita come inevitabile, porta il sistema a dare di se stesso una rappresentazione mitologica, priva di riscontri reali.
La dicotomia tra istituzioni e società è netta e compito delle prime è appunto quello di imporre alle seconde le ideologie più subdole, più raffinate, al fine di celare i contrasti insanabili.
Le civiltà non vogliono morire di morte naturale, proprio perché la loro esistenza è stata, sin dall'inizio, basata sull'inganno e sulla violenza. Le civiltà hanno orrore della verità e sarebbero disposte a qualunque cosa pur di vederla negata. Ecco perché quand'esse sono in decadenza, le "favole" aumentano all'aumentare della consapevolezza della fine. Col concetto di "favola" occorre intendere qualunque cosa che svii l'attenzione delle masse dai veri motivi che stanno portando al crollo finale.
La storia ha conosciuto delle civiltà che si sono rassegnate al loro declino e non hanno opposto una resistenza convinta alle loro contraddizioni, quando si sono scontrate con civiltà ancora più forti di loro, nel senso che il conflitto bellico è stato utilizzato dalle istituzioni come una forma di autolesionismo. Si rinuncia a lottare contro il nemico esterno perché in realtà si è rinunciato a lottare contro le contraddizioni interne, e la sconfitta viene considerata come una sorta di "meritato castigo". Questo atteggiamento è molto evidente nelle civiltà precolombiane.
Nel mondo egizio le "favole" del potere altro non erano che la religione, il culto dell'oltretomba, l'edificazione monumentale dei santuari funebri, la magia, la divinazione, l'astrologia... Tutte cose che il mondo romano ha ereditato, trasformandole in senso materialistico, e aggiungendovi altri aspetti che la cultura egizia non conosceva: il culto del diritto, dello sport, dei festini, la lotta mortale tra i gladiatori, gli svaghi alle terme, sino alle feroci persecuzioni contro i cristiani, durate ben tre secoli.
Le civiltà in decadenza, cieche di fronte ai loro problemi di fondo, hanno bisogno di "favole" e quando queste non bastano, hanno bisogno di vittime sacrificali, una sorta di capro espiatorio che serva a celare il vero volto del potere e soprattutto della sua progressiva decadenza.
In questi frangenti di desolazione, occorre pensare che la storia può essere a una svolta significativa e che occorre costruire da subito una transizione verso il diverso.
Ecco perché non c'è nulla che ci possa interessare del passato se non ciò che ci può servire a risolvere i problemi del presente, poiché è comunque nel presente che dobbiamo cercare la soluzione ai nostri problemi: il passato ci può servire come ispirazione. Ormai il legame che ci univa alle generazioni passate è stato rotto per sempre dalla civiltà contemporanea, salvo sparute eccezioni che cercano di sopravvivere come possono.
INNOVAZIONI E IDEALISMO
Quando le innovazioni nascono dagli idealisti e questi sono consapevoli di esserlo, essi devono altresì accettare (con filosofia) che qualcun altro le possa sfruttare economicamente.
In tutte le società antagonistiche l'idealismo ha sempre avuto vita breve.
E' difficile comunque pensare che le innovazioni possano nascere da chi non è disposto, in nome di un ideale, a fare grandi sacrifici. E i sacrifici non si fanno quando si hanno molti mezzi.
Ecco perché le civiltà senza idealismo sono destinate a morire.
PISTE DI RICERCA
Abbiamo scavato nelle profondità dell'io per scoprire solo lacerazioni. Il bisogno stesso di analizzarlo nasceva da un'alienazione.
Ci siamo illusi di poter recuperare l'unità originaria semplicemente costatandone l'assenza.
Abbiamo perso la semplicità due volte: quando abbiamo voluto negarla per affermare il primato dell'io e quando abbiamo voluto scavare nell'io diviso, invivibile, nella speranza di trovare altro, cioè il non-io, l'altro che ci sta di fronte.
Ormai siamo talmente smaliziati sui difetti dell'io che persino la semplicità ci pare un limite. Siamo diventati maestri del sospetto e per noi ingenuità significa soltanto possibilità di inganno, di raggiro.
In queste condizioni non riusciremo mai a recuperare l'innocenza perduta. Anche se andassimo a vivere in un altro pianeta, anche se vivessimo in un'altra dimensione, il marcio resterebbe in noi.
Prima dovremmo purificarci. Hegel, il più grande filosofo della storia, non era contrario alla guerra come igiene del mondo.
In realtà sarebbe sufficiente rinunciare a tutto ciò che contraddice i ritmi naturali, ovvero le esigenze riproduttive della natura, perché se c'è una cosa che non possiamo permetterci (anche se all'apparenza sembra non essere così) è quella di essere contro-natura. Solo la natura può farci capire l'essenzialità della vita.
Qui non è più questione di destra o sinistra, di capitalismo o socialismo; la stessa tutela ambientale rischia di diventare un mero surrogato.
Dobbiamo piuttosto uscire dal concetto di civiltà, perché con esso oggi intendiamo cose del tutto innaturali e quindi disumane.
Analizziamo questo concetto e ne vedremo i limiti:
- la scrittura di pochi singoli ha sostituito la trasmissione orale di un popolo (interessi particolari hanno prevalso su interessi generali);
- la vita urbana ha subordinato a sé quella rurale;
- il valore di scambio ha prevalso su quello d'uso;
- il mercato ha rimpiazzato l'autoconsumo;
- la specializzazione del lavoro ha sostituito la capacità di saper fare ogni cosa utile a sopravvivere;
- il lavoro intellettuale prevale su quello manuale;
- con la scienza e la tecnica si vuole "dominare" la natura o la parte più debole, meno acculturata dell'umanità;
- all'uguaglianza dei sessi è seguita la dominanza del maschio;
- la proprietà privata domina su quella sociale;
- la stanzialità ha sostituito il nomadismo;
- l'esigenza del superfluo ha prevalso sui bisogni fondamentali;
- l'idea di progresso prevalente è diventata quella relativa alla materialità della vita, al benessere materiale ed è stata portata avanti da pochi contro molti;
- s'è fatto coincidere, in maniera automatica, il livello di produttività di un paese col benessere sociale della popolazione; indici quantitativi hanno prevalso su quelli qualitativi; l'economico ha prevalso non solo sull'ecologico ma anche sul sociale;
- l'io prevale sul collettivo;
- la democrazia delegata ha sostituito quella diretta;
- le amministrazioni statali hanno paralizzato l'autogestione o l'autogoverno delle popolazioni, e in generale lo Stato domina la società civile; si è voluto far credere che una maggiore statalizzazione significhi automaticamente una maggiore socializzazione;
- le nazioni hanno sostituito le comunità di villaggio; abbiamo posto dei confini per stare separati;
- ci si arroga il diritto di imporre alle nazioni più deboli i propri criteri di vita: non c'è confronto alla pari, rispetto della diversità, ma imposizione di un modello;
- tutti i valori affermati (siano essi laici o religiosi) servono solo per assicurare questo stato di cose, cioè anche se i valori sembrano umani e conformi a natura, nella pratica producono il contrario;
- le armi che servivano per cacciare ora possono distruggere l'intero pianeta.
BARBARO E CIVILE
Quando esaminano la storia dell'impero romano, pagano o cristiano che sia, gli storici sono abituati a considerare le popolazioni cosiddette "barbariche" nemiche non solo di questa specifica civiltà, ma anche della civiltà qua talis.
Non vedono mai le distruzioni e le devastazioni operate dai "barbari" come una forma di negazione delle contraddizioni antagonistiche della civiltà romana e quindi come un tentativo di ricostruzione della "civiltà" su basi nuove.
Noi sappiamo che le civiltà individualistiche (che potremmo definire anche come quelle dello "sfruttamento") hanno fatto a pezzi quelle collettivistiche: quest'ultime oggi sopravvivono a stento in posti remoti della terra e, per definizione, non fanno la "storia".
Noi non possiamo sostenere che le popolazioni cosiddette "barbariche" che distrussero il mondo romano fossero caratterizzare da un collettivismo analogo a quello del comunismo primitivo. Però possiamo dire che vivevano una forma di collettivismo sufficiente a far fronte all'ondata individualistica della civiltà romana. Se non fosse stata sufficiente l'impero romano non sarebbe crollato o per lo meno non sarebbe crollato in maniera così rovinosa.
Probabilmente proprio il continuo contatto con l'individualismo dei romani aveva permesso ai "barbari" di porsi nei loro confronti in maniera non ingenua, li aveva cioè indotti a trovare delle strategie utili alla propria difesa. Cosa che non è avvenuta da parte degli africani nei confronti delle potenze occidentali o da parte degli indiani d'America nei confronti degli europei.
Solo che questo continuo contatto non solo ha permesso ai "barbari" di comprendere le astuzie dei romani, ma ha anche prodotto un condizionamento negativo: i "barbari" infatti, una volta penetrati nell'impero, si sono sostituiti all'individualismo romano, limitandosi a mitigarne le asprezze (vedi p.es. il passaggio dallo schiavismo al servaggio).
Gli storici sono abituati a vedere la "civiltà" come un qualcosa che si basa su elementi prevalentemente formali: p.es. il valore delle opere artistiche e architettoniche, le espressioni linguistiche e comunicative, i livelli economici e commerciali raggiunti ecc. Tutti questi aspetti, che pur sono "strutturali" ad ogni civiltà, vengono visti in maniera formale, in quanto non ci si preoccupa di verificare il tasso di "umanità" in essi contenuto.
Così, una civiltà "commerciale" o "urbana" viene sempre ritenuta superiore a una "agricola" o "rurale". La nostra civiltà, che è capitalistica e tecnologicamente avanzata, funge da modello per l'interpretazione delle caratteristiche di tutte le altre civiltà, del presente e del passato. E pone anche una serie ipoteca per il futuro, non sapendo immaginare soluzioni alternative allo status quo.
Noi ci riteniamo assolutamente superiori a qualunque altro tipo di civiltà, di ieri di oggi e di domani. Ed è praticamente impossibile trovare uno storico che consideri più "civili" le esperienze tribali prive di tecnologia avanzata, di urbanizzazione sviluppata, di mercati e imprese produttive ecc. Un'esperienza tribale non appare tanto più "civile" quanto più "umana", ma solo quanto più è vicina al nostro modello di sviluppo. Infatti quanto più se ne allontana, tanto più è "primitiva". E per noi il concetto di "primitivo" vuol dire "rozzo e incolto", privo di intelligenza e con scarsa profondità a livello di sentimenti. La rappresentazione che noi abbiamo dell'uomo primitivo, che giudichiamo molto simile a una scimmia, è semplicemente ridicola.
Se mettessimo a confronto i livelli di istintività con cui si reagisce a determinate forme di condizionamento sociale e culturale, ci accorgeremmo che noi "individualisti" siamo molto più vicini al mondo animale di quanto non lo siano stati gli uomini primitivi, che ragionavano sempre mettendo l'interesse del collettivo al primo posto. Una reazione istintiva di fronte alle difficoltà è tipica di chi è abituato a vivere la vita sotto stress, in stato di continua tensione, ai limiti del panico, sentendo tutto il peso delle responsabilità sopra le proprie spalle, senza possibilità di avere significativi aiuti esterni.
Questo per dire che il crollo di una civiltà non andrebbe di per sé giudicato negativamente, poiché bisogna sempre vedere se da questo crollo è sorta una civiltà superiore, e se questa superiorità s'è manifestata sul piano meramente formale della tecnologia, della scienza, dell'arte, dell'economia, dell'organizzazione politica ecc., o non invece sul piano dell'esperienza dei valori umani, sociali, collettivi.
P.es. nel passaggio dal mondo romano al feudalesimo sicuramente vi è stata un'evoluzione positiva nel tasso di umanità degli individui, in quanto si riuscì a sostituire lo schiavismo col servaggio. Tuttavia questa forma specifica di evoluzione non può essere analogamente riscontrata nel passaggio dal feudalesimo al capitalismo, in quanto esigenze collettive rurali sono state qui distrutte da esigenze individualistiche urbane.
Per settant'anni si è creduto possibile che l'individualismo urbano del capitalismo potesse essere sostituito con il collettivismo urbano del socialismo amministrato dall'alto, ma il fallimento di questo risultato è stato totale. Ciò a testimonianza dell'impossibilità di creare una civiltà autenticamente "umana" limitandosi a cambiarne alcune forme. Non si può costruire un socialismo umanistico limitandosi semplicemente a socializzare la proprietà e la gestione dei mezzi produttivi.
Altri aspetti, generalmente dati per scontati, vanno riconsiderati: p.es. il primato della città sulla campagna, dell'industria sull'agricoltura, del lavoro intellettuale su quello manuale, della cultura sulla natura, dell'uomo sulla donna, della scienza sulla coscienza ecc.
PER UNA STORIOGRAFIA OLISTICA
Penetrando nell'impero romano i cosiddetti "barbari" hanno contribuito a modificare le leggi, i costumi e la mentalità del mondo antico (latino), ch'erano stati imposti con la forza su tutta l'Europa e nell'area del Mediterraneo e che se non lo fossero stati le popolazioni locali non avrebbero accolto così favorevolmente l'ingresso degli invasori. Non dimentichiamo che la lotta dell'impero contro i barbari fu voluta soprattutto dal potere politico.
Ancora oggi però sono assai pochi gli storici che ritengono significativa tale influenza. Questo perché il fatto che i barbari abbiano ad un certo punto accettata la religione cristiana, abbandonando il politeismo pagano, abbiano accettato l'alfabeto latino (loro ch'erano addirittura privi di scrittura), abbiano accettato di lasciare ai latini l'amministrazione dello Stato, riservandosi il controllo politico-militare, è per gli storici la conferma dell'irrilevanza dell'apporto culturale dei barbari.
Quasi tutte le popolazioni barbariche entrate nell'impero in verità erano già cristianizzate, seppure nella forma ariana, ma solo quelle che hanno accettato di farsi influenzare dall'ideologia cattolico-romana hanno avuto successo. Questo per gli storici è la dimostrazione che i barbari ammettevano in Europa la presenza di un'ideologia superiore alla loro, quando in realtà tutta la lotta tra chiesa e impero, nell'Europa latina, rifletteva una contrapposizione tra il vecchio arianesimo (già acquisito dalle popolazioni germaniche) e il nuovo cattolicesimo. Ma gli storici, quando parlano dell'arianesimo, lo vedono solo sul piano delle eresie teologiche e non anche su quello dei rapporti tra teologia e politica, e anche quando lo citano come "eresia", non riescono a vedere in essa il lato eversivo, laicistico. Gli storici danno quasi sempre per scontato che chi è uscito sconfitto dalla storia avesse torto.
E' finito il tempo di fare una storiografia che riguardi solo gli avvenimenti politici e quelli socioeconomici (a quest'ultimi s'è data importanza a partire dalla popolarizzazione del marxismo). Occorre fare una storiografia olistica, che includa tutto: mentalità idee concezioni di vita in stretto rapporto col contesto socioeconomico e politico. Bisogna integrare lo studio della filosofia (che nel passato coincideva con la teologia, per cui va studiata anche questa, che ci piaccia o no) con lo studio della storia (Gramsci aggiungerebbe anche lo studio del "senso comune", rilevabile in fonti particolari, come i proverbi popolari, le fiabe ecc.). Bisogna cioè non solo dedurre lo sviluppo del pensiero dallo sviluppo del movimento sociale, ma anche capire in che modo l'ideologia s'intreccia con tale movimento, influenzandolo in maniera decisiva, irreversibile.
Bisogna cercare di fare un lavoro sulle "idee", non solo su quelle che hanno giustificato una determinata realtà, ma anche su quelle che hanno subito delle sconfitte e che col tempo sono state dimenticate: bisogna verificare se queste idee minoritarie potevano costituire una valida alternativa a quelle risultate dominanti o se addirittura sono riapparse nella storia in altre forme e modi (cosa che p.es. è certamente successe nell'evoluzione delle eresie cristiane).
Tutto ciò non per fare la storia coi "se" e i "ma", ma per capire se le decisioni erano obbligate, inevitabili, oppure se esisteva un margine di scelta, un'alternativa non solo teorica ma praticabile. In genere non esistono mai evidenze che s'impongono da sé: la libertà si muove sempre in un contesto chiaroscuro.
OLTRE LA CIVILTA'
Noi non possiamo recuperare nulla di tutto quanto s'è formato e sviluppato prima della nascita della civiltà, utilizzando gli stessi strumenti che l'odierna civiltà ci offre. Per poterlo fare noi dobbiamo uscire non solo dal "concetto" di civiltà, ma anche dalla sua stessa modalità di vita, dalla sua "prassi".
Uscire dalla "prassi" della civiltà implica già un rifiuto della separazione consolidata tra lavoro manuale e intellettuale. Non si può uscire dalla civiltà in maniera intellettuale, limitandosi a criticarla. Se ne può uscire solo ponendo delle alternative concrete, praticabili, al suo modo di essere.
Queste alternative devono essere razionali, conformi a leggi di natura, universalmente valide, cioè alla portata di tutti.
La prima regola fondamentale per uscire dalla civiltà è quella di ridurre al minimo la dipendenza da fattori artificiali che condizionano la nostra riproducibilità.
L'uomo e la donna sono esseri di natura: la loro esistenza dovrebbe essere unicamente legata ai processi di sviluppo della natura.
Se la natura viene ostacolata nei suoi processi riproduttivi da quanto di artificiale gli uomini pongono fra loro e la stessa natura, non si supererà mai il concetto e la prassi di civiltà.
Lo sviluppo della tecnologia, in tal senso, deve essere compatibile coi processi riproduttivi della natura. Purtroppo oggi l'influenza del concetto di civiltà sull'intero pianeta è così grande che pare impossibile ritagliarsi uno spazio in cui poter sperimentare in maniera autonoma un'alternativa sociale e naturale.
Tutte le civiltà della storia hanno posto le proprie fondamenta su aspetti antisociali e innaturali, la cui natura artificiale risulta assolutamente preponderante nel sistema di vita, nelle relazioni sociali e nei rapporti tra uomo e natura.
Non dobbiamo infatti pensare che il concetto di "macchinismo" sia applicabile solo alla rivoluzione industriale del sistema capitalistico. "Macchinismo" in senso traslato o figurato è un concetto che si applica là dove esiste un rapporto di sfruttamento unilaterale dell'uomo sull'uomo e dell'uomo sulla natura.
Persino là dove s'impone il semplice concetto di "forza fisica" (come p.es. nei rapporti tra uomo e donna), lì si può costatare la presenza di qualcosa di artificiale, di non naturale.
E' vero, le prime civiltà non hanno conosciuto l'industrializzazione, come la conosciamo oggi, però hanno sperimentato molte rivoluzioni nell'uso dei metalli e nell'uso della pietra per costruzioni imponenti, attraverso le quali far valere un rapporto di subordinazione tra gli uomini e tra questi e la natura.
Gli effetti devastanti di queste civiltà sono visibili nelle progressive desertificazioni del pianeta. Quanto più si sviluppano le civiltà, tanto più viene devastata la natura e quindi tanto più le stesse civiltà si autodistruggono, poiché il rapporto con la natura è imprescindibile all'essere umano.
Come difendersi dalle civiltà che, vivendo rapporti antagonistici al proprio interno, inevitabilmente sono costrette a scaricare il peso delle loro contraddizioni all'esterno, saccheggiando risorse umane e naturali ovunque esse siano?
Qui è evidente che non basta pensare di potersi ritagliare uno spazio vitale in cui esercitare le proprie esperienze alternative. Occorre anche elaborare dei meccanismi concreti di autodifesa, che impediscano alle civiltà di prevaricare impunemente.
Il vero peccato originale dell'umanità è stata la pretesa di poter decidere il proprio destino indipendentemente dalle esigenze e dalle leggi della natura.
* * *
Gli uomini devono poter dimostrare di essere se stessi a prescindere dai mezzi che usano. Cioè se i mezzi inducono gli uomini ad avere tra loro rapporti innaturali, in cui l'interesse privato prevale su quello collettivo, allora ci si dovrebbe chiedere se quegli stessi mezzi non siano da modificare o da sostituire con altri più adeguati all'esigenza di identità umana.
Nessuno infatti può pretendere di soddisfare questa esigenza a danno di altri.
La moderna civiltà occidentale ha fatto della rivoluzione tecnico-scientifica la modalità principale dei rapporti interumani e dei rapporti tra uomini e natura.
E ha usato questa rivoluzione per affermare il primato del profitto capitalistico, della rendita finanziaria.
Da un lato quindi si è frapposto il macchinismo tra gli esseri umani e tra questi e la natura; dall'altro si è fatto del capitale l'unica vera ragione di vita.
Macchinismo e capitale hanno marciato di pari passo, condizionandosi a vicenda, con la differenza che mentre uno si pone come fine, l'altro è mezzo.
La civiltà basata su questo mezzo e su questo fine, di umano non ha nulla, anche se per potersi imporre in tutta la sua innaturalezza, essa ha avuto bisogno di dimostrare ch'era migliore di quella precedente.
Le civiltà sono frutto di progressivi inganni o di promesse non mantenute.
E' come se il genere umano dovesse sperimentare tutte le forme di illusione sulla propria identità, prima di tornare a vivere quell'unica forma di esistenza in cui era se stesso, in un rapporto naturale con l'ambiente.
La religione è stata una delle grandi forme di illusione. Oggi però lo è la scienza e la tecnica.