LA STORIA ANTICA
dal comunismo primitivo alla fine dello schiavismo
UOMINI ROSSI
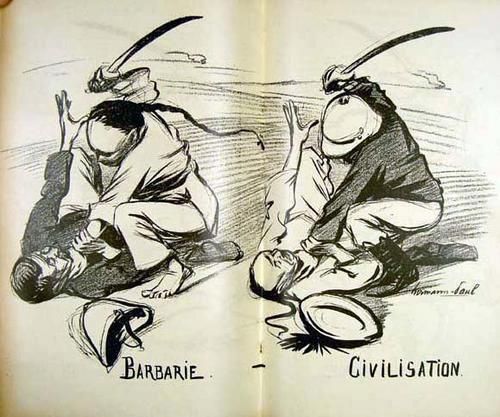
di Roberto Sidoli
Prefazione di Roberto Sidoli
Secondo la concezione marxista-ortodossa della storia universale, quest’ultima può essere paragonata ad una grande e lunga strada a senso unico, anche se composta da alcune diramazioni secondarie che in seguito si ricollegano al sentiero principale, oltre che da una serie di vicoli ciechi che via via vengono abbandonati, più o meno rapidamente.
In questa prospettiva storica, la “grande strada” della storia è formata nella sua essenza da vari segmenti successivi ben distinti tra loro (il comunismo primitivo/comunitarismo nella preistoria della nostra specie, il modo di produzione asiatico, quello schiavistico, quello feudale e l’epoca capitalistica da superarsi nel socialismo/comunismo), ma essa era ed è considerata tuttora un tracciato predeterminato, almeno in ultima istanza: qualunque “viaggiatore”, come una società organizzata, poteva/può anche prendere delle “scorciatoie” ma alla fine, volente o nolente, era/è costretto a rientrare nel sentiero di marcia principale e nelle sue variegate, ma necessarie e obbligate, tappe di percorso. In base ai dati storici allora a conoscenza di Marx ed Engels, questa era l’unica visione complessiva del processo di sviluppo della storia universale che poteva essere (genialmente) elaborata a quel tempo, ma successivamente tutta una serie di scoperte archeologiche e di avvenimenti storici portano a preferire una diversa concezione generale dell’evoluzione del genere umano.
Immaginiamo pure quella “grande strada” che, dopo un lunghissimo segmento (fase paleolitica e mesolitica) di scorrimento unitario, si trovi improvvisamente di fronte ad un “grande bivio”, ad una gigantesca biforcazione da cui si diramano due diverse strade alternative che conducono a mete assai dissimili, senza alcun obbligo a priori per il “viaggiatore” (a motivo del Fato o delle forze produttive) di scegliere l’una o l’altra. Ma non basta. Non solo non vi è più una sola strada obbligata di percorso, ma – a determinate condizioni e pagando determinati “pedaggi” – qualunque “viaggiatore” (qualunque società umana) può trasferirsi nel tracciato alternativo a quello selezionato in precedenza, cambiando pertanto radicalmente le proprie condizioni materiali di “viaggio” nell’autobus che sta utilizzando, essendo anche la scelta presa “al bivio”, giusta o sbagliata, sempre reversibile nell’altra direzione di marcia, in meglio o anche in peggio che sia.
Fuor di metafora, la concezione che qui si propone ipotizza che dopo il 9000 a.C., ossia ben undici millenni fa, nell’Eurasia del periodo neolitico con la scoperta dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’artigianato specializzato si sia creato, e poi riprodotto costantemente fino ai nostri giorni una biforcazione da cui si sono diramate due “strade”, due linee e due tendenze socio-produttive alternative, l’una di tipo comunitario-collettivistico e l’altra di natura classista perché fondata invece sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
Pertanto dopo il 9000 a.C. e fino ai nostri giorni, durante quella che si può anche chiamare l’“era del surplus costante e accumulabile”, non sussiste più alcun determinismo storico, bensì un campo di potenzialità oggettive (date dallo sviluppo delle forze produttive e dalla creazione/riproduzione ininterrotta di quel surplus) su cui si possono innestare, e si innestano poi concretamente, delle prassi sociali contrapposte volte, le une, a condividere in modo fraterno i mezzi di produzione/ricchezza/surplus; oppure le altre, a fare in modo che essi finiscano sotto il controllo e il possesso di una minoranza del genere umano, in entrambi i casi con immediate ricadute anche sulla sfera politico-sociale della società.
Detto in altri termini, a parità di sviluppo qualitativo delle forze produttive disponibili, fin dal 9000 a.C. è stato possibile, e lo è tuttora, sviluppare sia l’egemonia di rapporti di produzione collettivistici oppure quella alternativa di rapporti classisti: è questo l’effetto di sdoppiamento per il quale nulla era/è mai scritto a priori nei libri mastri della storia, sicché i rapporti di produzione praticabili sul piano materiale sono stati esenti da undici millenni da qualunque forma di determinismo storico basato sul “progresso inevitabile” del genere umano, dalla “barbarie” paleolitica al comunismo sviluppato.
Certo, qualunque regressione allo stadio paleolitico basato sulla caccia/raccolta di cibo resta esclusa da quel processo di sviluppo qualitativo delle forze produttive che fornisce quel surplus costante/accumulabile che ha determinato il sorgere e garantisce la riproduzione ininterrotta dell’effetto di sdoppiamento. Ma a parte questo “dettaglio” non trascurabile, negli ultimi undici millenni il corso della storia universale è diventato decisamente multilineare, composto com’è dal “bivio” e dalla compresenza delle due “strade” alternative in campo socioproduttivo e politico, la cui essenza più profonda risulta essere l’emersione permanente di una logica della scelta rispetto alla quale la pratica collettiva (soprattutto politica) degli uomini del passato e del presente (noi stessi...) assume un ruolo decisivo, sotto tutti gli aspetti.
Le caratteristiche fondamentali di questo “effetto di sdoppiamento”, e soprattutto l’insieme delle “orme” ritracciabili nella storia post-9000 a.C., che ne dimostrano la riproduzione all’interno del processo di sviluppo del genere umano, costituiscono le tematiche affrontate nel mio libro del 2009 I rapporti di forza, ai capitoli VI-VII-VIII e XV-XVI scaricabili da Internet al sito www.robertosidoli.net, di cui in questa sede, su supporto cartaceo, s’intende offrire al lettore appena un “assaggio”.
Capitolo primo
L’effetto di sdoppiamento
1. Prima delle società di classe
La prima base materiale che sorregge ininterrottamente dal 9000 a.C. e fino ai nostri giorni la centralità dei rapporti di forza politico-sociali, nelle società collettivistiche del neolitico prima e classiste poi, è costituita dall’effetto di sdoppiamento (o “biforcazione”) che rappresenta il risultato principale del livello di sviluppo raggiunto dalle forze produttive sociali a seguito del progressivo emergere della grande rivoluzione produttiva neolitica (allevamento e poi agricoltura e artigianato) e la parallela comparsa e riproduzione nel tempo di un surplus produttivo, permanente ed accumulabile, a disposizione della nostra specie: il termine in esame indica il permanente campo di potenzialità alternative che si è prodotto allora nella sfera dei rapporti di produzione/distribuzione sociali, e che perdura fino ai nostri giorni, in base al quale sia rapporti collettivistici che classisti sono stati e sono tuttora potenzialmente in grado di esistere e riprodursi, alle volte anche o coesistendo (conflittualmente) all’interno dei diversi gradi di sviluppo via via raggiunti dalle forze produttive.
Per dirla altrimenti, la storia degli ultimi 11000 anni del genere umano si presenta come la storia del “tiro alla fune” e dello scontro tra due opposte tendenze socioproduttive, in grado a volte di coesistere nella stessa area geopolitica ed in presenza di una parità approssimativa nel livello di sviluppo delle forze produttive. I vari livelli di sviluppo raggiunti dalle forze produttive sociali, a partire dal 9000 a.C., non hanno infatti mostrato la comparsa di alcuna “necessità storica” bensì, al contrario, la produzione/riproduzione ininterrotta di un enorme spazio di libertà per la pratica umana sia nella sfera dei rapporti di produzione sociale che in campo politico e militare: parafrasando Engels, si potrebbe addirittura affermare che la libertà consiste, innanzi tutto, nella coscienza della necessaria esistenza di potenzialità alternative, in contrasto reciproco all’interno del segmento delle relazioni sociali di produzione e di potere che si sono via via affermate sul piano storico e concreto.
Per comprendere l’essenza e la portata storica reale dell’effetto di sdoppiamento (biforcazione), bisogna analizzare il processo complessivo di sviluppo del genere umano partendo da quando (circa due milioni e mezzo di anni fa) è comparso l’Homo habilis, dotato di una statura eretta collegata organicamente alla presenza di un pollice opponibile e già in grado di esprimere un discreto sviluppo della massa cerebrale. Il periodo storico iniziato con l’Homo habilis, che arriva fino all’11000 a.C., è stato caratterizzato da un basso livello di sviluppo delle forze produttive sociali: a dispetto del progressivo miglioramento ed affinamento degli strumenti di produzione e distruzione, via via passati dalle rozze schegge di selce lavorate da un solo lato fino all’arco del tardo Paleolitico, il genere umano per più di due milioni d’anni si è dedicato esclusivamente alla raccolta di cibo, alla caccia e alla pesca avvalendosi di rudimentali strumenti in pietra, in osso e in legno. Le diverse tribù di esseri umani raccoglievano collettivamente con dei bastoni i tuberi e sceglievano vegetali e bacche commestibili, e sebbene già 400.000 anni fa esse fossero in grado di utilizzare il fuoco e dal 25000 a.C. si servissero di asce e lance per la caccia di gruppo, tuttavia la loro attività produttiva non è mai stata in grado di produrre un surplus produttivo costante rispetto ai bisogni fisiologici minimali, garantendosi così soltanto una riproduzione sociale stentata, sempre potenzialmente sottoposta ai colpi delle calamità naturali e al rischio di morte per fame/freddo. Tutto questo ha impedito qualsiasi forma di sfruttamento sistematico dell’uomo sull’uomo: siccome la raccolta dei tuberi, dei vegetali e della frutta, la caccia e la pesca era svolta in modo cooperativo tra i pochi membri dei vari clan, si determinava inevitabilmente una distribuzione sostanzialmente egualitaria del prodotto dell’attività produttiva tra i piccoli gruppi umani preistorici «formate in genere da 5 a 80 individui, tutti più o meno affini e/o parenti»1.
I rapporti sociali di produzione che corrispondevano a questo grado molto arretrato di sviluppo delle forze produttive, risultavano pertanto inevitabilmente di tipo collettivistico e contraddistinti dalla proprietà comunitaria della terra e dello spazio geografico utilizzato dai vari clan per la raccolta/caccia, oltre che dalla ripartizione sostanzialmente egualitaria del cibo e del risultato finale del processo produttivo2. Per due milioni e mezzo di anni il genere umano si è riprodotto materialmente attraverso l’egemonia quasi incontrastata delle strutture socioeconomiche del comunismo primitivo e nell’impossibilità d’esistenza dello sfruttamento del lavoro altrui per l’assenza di un surplus permanente ed accumulabile nel tempo che precludeva a priori ogni eventuale appropriazione privata dei risultati del lavoro altrui, assolutamente “improduttivo” per ipotetici “sfruttatori”. Nessuna eccedenza = nessuna forma possibile di appropriazione privata di surplus da parte di una minoranza, e soltanto la presenza di condizioni geonaturali estremamente favorevoli per la caccia e/o la pesca, come nella California settentrionale del periodo tardo-paleolitico, ha permesso alle élite di alcune tribù di cacciatori/pescatori di appropriarsi del surplus generato dal lavoro altrui, sebbene il possesso privato si limitasse a pochi oggetti di uso corrente e alle armi,
Guerre e razzie fra clan esistevano anche nella preistoria, ma giocavano un ruolo limitato nell’insieme complessivo della riproduzione materiale delle “bande” paleolitiche, sicché la preistoria “nulla sapeva” di eserciti e di polizia, di prigioni e di imposte, nonché di strutture politico-materiali inutili sul piano sociale ed il cui costo economico sarebbe stato in ogni caso insostenibile per società così primitive. La gestione degli affari comuni era affidata a discussioni-decisioni collettivea e spesso al parere autorevole degli anziani, depositari dell’esperienza del clan: come ha notato lo storico J. Diamond, «le tribù nomadi di cacciatori-raccoglitori sono in gran parte società di eguali, la cui azione politica si limita al controllo del proprio territorio e a mutevoli alleanze con le tribù circostanti»3.
Dal canto suo il ruolo sociale assunto dalle donne nel Paleolitico risultava notevole in virtù sia della loro importante partecipazione al processo produttivo mediante la caccia di piccoli animali e la raccolta di cibo, che della “magica” procreazione dei figli, visto che il contributo maschile alla riproduzione sessuale rimase sconosciuto per più di due milioni di anni; l'arte del tardo Paleolitico ha espresso tale influenza reale con il culto della Dea Madre, generatrice di vita e dispensatrice di fertilità, rappresentata incinta e nuda.
2. Il Grande Evento Neolitico
La sostanziale continuità storica della preistoria viene spezzata dal Grande Evento della rivoluzione tecnico-produttiva del Neolitico iniziata in forma embrionale dalle donne dell’Anatolia e dell’area siro-palestinese tra il 9000 e l’8500 a.C. e poi replicata con modalità assolutamente autonome in Cina prima del 7500 a.C.
Questa gigantesca rivoluzione socioproduttiva è caratterizzata dalla “domesticazione” delle piante alimentari e degli animali. La sua genesi è preparata, alla fine dell’era glaciale, da una fase intermedia di raccolta sistematica di cereali selvatici iniziata da alcune tribù del Paleolitico (Ohalo, Israele, 21000 a.C.) e del Mesolitico nella zona turco-palestinese (11000-9000 a.C.), ma viene poi resa possibile dalla fabbricazione di «falci dalla lama di selce e dal manico di legno o d’osso; cesti per trasportare il raccolto verso casa; mortai, pestelli e mole per liberare i grani dalla pula; metodi d’essiccazione per evitare che i semi germogliassero dopo la raccolta; e grandi silos sotterranei, alcuni dei quali intonacati per renderli impermeabili»4. Per illustrare concretamente l’importanza di questa lunga fase pre-rivoluzionaria l’archeologo J. R. Harlan ha mostrato negli anni Settanta che, usando un falcetto dalla lama di selce, in un periodo di mietitura di tre settimane una famiglia di sei persone nel Mesolitico avrebbe potuto accumulare frumento selvatico in quantità tale da permettere un consumo pro-capite giornaliero di quattro ettogrammi di cereali: i “motori” delle forze produttive si stavano ormai scaldando, preparando le condizioni per l’entrata nell’era della produzione costante del surplus5.
Dopo questo lungo periodo preparatorio, i clan della zona siropalestinese ed anatolica iniziarono a seminare le prime piante di cereali curandone la crescita e selezionando, per caso o per tentativi, le sementi più produttive, mentre parallelamente allo sviluppo dell’agricoltura le tribù dell’area in questione prendevano ad allevare i primi animali “commestibili” (seguendo l’esperienza della domesticazione del lupo-cane), attirati e allo stesso tempo nutriti da quelle colture di cereali. In tal modo nel Vicino Oriente il genere umano intraprendeva a coltivare le piante del grano, dell’orzo e dei piselli e ad addomesticare la pecora e la capra attorno all’8500 a.C., mentre in Cina processi analoghi avvenivano per il miglio, e il riso e per i primi allevamenti di maiali (8000 a.C.).
I risultati concreti della rivoluzione tecnico-produttiva del Neolitico sono stati eccezionali e di un peso storico straordinario grazie all’aumento della produttività media del lavoro sociale rispetto alla precedente stagione paleolitica di caccia-raccolta (o pesca): è stato calcolato che «alla fine, un ettaro di terra coltivata riusciva a dar sostentamento a molti più contadini (dalle 10 alle 100 volte) di quanto non riusciva a fare un ettaro di terra vergine per i cacciatori-raccoglitori»6. Di conseguenza alcune frazioni consistenti del genere umano hanno potuto iniziare a riprodurre sistematicamente, pur tenendo conto dei fattori atmosferici e climatici avversi, un plusprodotto in eccedenza rispetto ai bisogni minimali di sopravvivenza biologica e ciò ha consentito, ad esempio nell’oasi di Gerico. di utilizzare questo surplus per commerciare con altre zone (ossidiana) e per erigere mura e torri attorno alla città già a partire dal 8300-7500 a.C.
Il gioco era riuscito con tanto successo che attorno al 9000-7500 a.C. alcune importanti zone geo-economiche del globo presero a riprodurre quel salto di qualità produttivo che taglia nettamente in due la storia dell’Homo Sapiens dividendola nell’era pre- e post-surplus permanente. Come ulteriore sottoprodotto positivo l’aumento formidabile della produttività del lavoro sociale e la formazione parallela del plusprodotto agricolo innescavano un circolo economico “virtuoso” che si autoalimentava e si riproduceva su scala allargata. Infatti l’agricoltura ha posto le condizioni materiali necessarie per la domesticazione degli animali che «hanno aiutato l’uomo a produrre più cibo in quattro modi diversi: fornendo latte, carne, concime e forza motrice per gli aratri. Come è ovvio, il bestiame sostituì direttamente la selvaggina come fonte primaria di proteine... Gli animali domestici servono anche a migliorare la produzione agricola. Prima di tutto, come ogni giardiniere o contadino sa bene, non c’è niente di meglio del letame per fertilizzare la terra da coltivare. Anche se oggi abbiamo a disposizione i concimi sintetici prodotti dalle industrie chimiche, in gran parte del mondo le deiezioni animali (soprattutto di bovini, ovini e yak) continuano ad essere la principale fonte di fertilizzante. Lo sterco, inoltre, è stato ed è un apprezzato combustibile in molte società tradizionali. Inoltre, i grandi animali domestici possono servire anche a tirare gli aratri, il che rende possibile dissodare terreni che sarebbero altrimenti lasciati incolti. Tra gli animali da lavoro ricordiamo i bovini, i cavalli, il bufalo asiatico e il banteng di Bali, e gli incroci tra buoi e yak»7. «Piante e animali domestici ci forniscono anche fibre naturali che, opportunamente intessute, diventano vestiti, coperte, reti o corde. In tutte o quasi le società che “scoprirono” l’agricoltura, i cereali erano affiancati da colture come il cotone, la canapa e il lino; molti animali erano allevati per lo stesso motivo: pecore, capre, lama e alpaca per la lana, e i bachi per la seta. Inoltre, gli uomini del Neolitico ricavavano attrezzi e altri manufatti dalle ossa degli animali domestici, e cuoio dalla pelle conciata dei bovini»8.
Ma sono stati soprattutto gli animali domestici ad aver «rivoluzionato la storia dell’umanità anche perché furono gli unici mezzi di trasporto terrestre fino al XIX secolo e all’avvento delle ferrovie. Agli albori dell’umanità, l’unico modo per trasportare cose e persone era portarseli a spalle; grazie agli animali, l’uomo fu in grado di spostarsi con facilità e di portare con sé grandi quantità di merci. Si montarono cavalli, asini, yak, renne e cammelli, e si utilizzarono (insieme al lama) come animali da soma. Buoi e cavalli furono attaccati ai carri, renne e cani alle slitte. Il cavallo divenne il principale mezzo di trasporto in quasi tutta l’Eurasia, ruolo che fu assunto dalle tre specie di camelidi domestici (dromedario, cammello e lama) rispettivamente in Nordafrica e Arabia, in Asia centrale e America andina». Ma non solo: «il contributo più diretto di un animale domestico alle guerre di conquista eurasiatiche venne dal cavallo. I cavalli erano le jeep e i carri armati del passato... Attorno al 4000 a.C., i cavalli montati a pelo furono probabilmente un fattore fondamentale per l’espansione verso occidente dei popoli indoeuropei stanziati nell’odierna Ucraina, un’espansione così inarrestabile da spazzare via tutte le lingue non indoeuropee (tranne pochissime). Quando più tardi i cavalli vennero usati anche come animali da tiro, il carro da guerra (inventato attorno al 1800 a.C.) fu una vera rivoluzione nell’arte militare che si diffuse nel Vicino Oriente, nel bacino del Mediterraneo e in Cina. Grazie ai carri da guerra, ad esempio, nel 1674 a.C. gli hyksos conquistarono l’Egitto/(dove allora non si conoscevano i cavalli) e lo dominarono per qualche tempo»9.
Per ultimo, è stato proprio il surplus disponibile in maniera permanente a permettere la creazione di società contraddistinte da una crescente diversificazione delle attività produttive, in particolare dalla specializzazione di una parte degli uomini neolitici in alcune forme relativamente sofisticate di artigianato.
3. L’interpretazione marxista ortodossa e la nostra
Le conseguenze sociopolitiche della rivoluzione neolitica e del conseguente sviluppo gigantesco delle forze produttive e della divisione del lavoro sono state veramente straordinarie per la storia dell'umanità confermando la tesi marxiana della centralità dello sviluppo degli strumenti di produzione, ivi compreso l’uomo inteso quale principale forza produttiva. Tuttavia gli effetti concreti del salto di qualità tecnologico-produttivo del Neolitico si sono manifestati attraverso modalità ben diverse da quelle indicate da Marx ed Engels.
In base alla narrazione “marxista-ortodossa”, la rivoluzione tecnologica indusse ed innescò necessariamente una sorta di inevitabile “controrivoluzione” planetaria nelle relazioni di proprietà e nel processo di distribuzione del prodotto sociale all’interno delle nuove strutture della fase “post-surplus”, provocando nel medio periodo l’affermazione di rapporti di produzione di classe fondati sull’appropriazione privata dei mezzi di produzione e del plusprodotto da parte di una minoranza della popolazione come nei modi di produzione asiatico e schiavistico: nel primo caso il surplus prodotto dalle comunità di villaggio veniva estorto da un apparato statale centralizzato che poteva assumere forme religiose o laiche e spesso curava la manutenzione delle grandi opere idrauliche indispensabili all’agricoltura, mentre nel secondo caso anche la forza-lavoro era ridotta a mero strumento parlante dei proprietari di terre e di mezzi di produzione.
Nel 1884 Engels ha sintetizzato i risultati della pluridecennale elaborazione storico-teorica sua e di Marx affermando il carattere necessario e “progressista” della rivoluzione-controrivoluzione che si è imposta nei rapporti di produzione durante la fase post-paleolitica: «l’aumento della produzione in tutti i rami – allevamento del bestiame, agricoltura, artigianato domestico – diede alla forza-lavoro umana la capacità di creare un prodotto maggiore di quanto fosse necessario al suo mantenimento. L’aumento della produzione fece aumentare contemporaneamente la quantità di lavoro quotidiano che toccava ad ogni membro della gens, della comunità domestica e della famiglia singola. Si sentiva ora il bisogno di introdurre nuove forze-lavoro. La guerra le fornì; i prigionieri di guerra furono mutati in schiavi. La prima grande divisione sociale del lavoro, con l’aumento della produttività del lavoro e quindi della ricchezza e con l’ampliamento del campo di produzione che aveva determinato, dato l’insieme delle condizioni storiche esistenti, portò necessariamente dietro di sé la schiavitù. Dalla prima grande divisione sociale del lavoro nacque la prima grande scissione della società in due classi: padroni e schiavi, sfruttatori e sfruttati»10.
Questa scissione della compagine sociale per Marx ed Engels ha indubbiamente rappresentato la forza motrice essenziale del progresso storico. È stato stimato che nel III millennio a.C. il contadino egiziano era già capace di produrre il triplo del cibo occorrente per sostenere se stesso e la sua famiglia, facendo sì che il surplus prodotto dalla forza-lavoro consentisse la costruzione di grandi edifici pubblici e delle enormi tombe per l’aristocrazia egizia, oltre a permettere la riproduzione della burocrazia civile e del clero. Sulla base di analoghe masse di pluslavoro/surplus si sono create e riprodotte tutte le successive multiformi classi egemoni la cui funzione storica è rimasta, per Marx ed Engels, sostanzialmente positiva e progressista nei millenni a seguire.
Sempre secondo questo schema marxista-ortodosso, anche il settore della politica e della “gestione degli affari comuni” è stato rivoluzionato inevitabilmente e le comunità solidaristiche del precedente periodo paleolitico, basate su decisioni prese collettivamente e sul potere limitato degli anziani, sono state sostituite da una direzione elitaria e dalla costruzione-riproduzione di apparati repressivi e di controllo sociale rivolti contro la maggioranza oppressa e sfruttata della popolazione. La “costituzione gentilizia”, formata dall’unione di diverse classi e tribù, ha rappresentato la prima e contraddittoria fase di superamento dell’antica organizzazione comunitaria, cui ha fatto seguito in un secondo momento la costruzione di una organizzazione statale con i connessi apparati repressivi, strumenti fiscali e dirigenti/funzionari politici staccati dal resto della società. «Era sorta una società che, in forza di tutte le sue condizioni economiche di vita, aveva dovuto dividersi in liberi e schiavi, in ricchi sfruttatori e poveri sfruttati, una società che non solo non poteva riconciliare questi antagonismi, ma doveva sempre più spingerli al loro culmine. Una tale società poteva sussistere solo o nella lotta aperta continua di queste classi tra loro, oppure sotto il dominio di una terza potenza che, stando apparentemente al di sopra delle classi in conflitto, ne comprimesse il conflitto aperto e permettesse che la lotta delle classi si combattesse, tutt’al più, nel campo economico, in forma cosiddetta legale. La costituzione gentilizia aveva fatto il suo tempo. Essa era stata distrutta dalla divisione del lavoro e dal suo risultato: la divisione della società in classi. Essa fu sostituita dallo Stato… che, poiché è nato dal bisogno di tenere a freno gli antagonismi di classe ma contemporaneamente è nato in mezzo al conflitto di queste classi, è per regola lo Stato della classe più potente, economicamente dominante che, per mezzo suo, diventa anche politicamente dominante e così acquista un nuovo strumento per tener sottomessa e per sfruttare la classe oppressa. Come lo Stato antico fu anzitutto lo Stato dei possessori di schiavi al fine di mantener sottomessi gli schiavi, così lo Stato feudale fu l’organo della nobiltà per mantenere sottomessi i contadini, servi o vincolati, e lo Stato rappresentativo moderno è lo strumento per lo sfruttamento del lavoro salariato da parte del capitale»11.
Si tratta di uno schema interpretativo molto chiaro e pienamente legittimato dai dati empirici disponibili nella seconda metà dell’Ottocento: Tuttavia questo paradigma storico non risulta più adeguato corrispondendo solo in parte all’evoluzione del genere umano verificatasi in Eurasia tra il 9000 ed il 3900 a.C. quale emerge dai nuovi risultati ottenuti dai ricercatori nel corso del Novecento. Una impressionante sequenza di “fatti testardi” (come avrebbe detto Lenin), che non potevano essere in alcun modo conosciuti da Marx ed Engels, suggerisce infatti l’idea della necessità di un inquadramento teorico alternativo notevolmente diverso da quello “ortodosso” e fondato su differenti coordinate teorico-generali di riferimento.
L’irruzione nella storia economica della produzione di un surplus costante ed accumulabile mediante il pluslavoro ha costituito certamente lo spartiacque decisivo a partire dal 9000 a.C. nel Vicino Oriente, in Cina, Egitto ed Europa, offrendo agli uomini del Neolitico la disponibilità di una eccedenza permanente di beni conservabile e riproducibile anno per anno, a meno di avversi fattori atmosferici e climatici. Essa era stata ottenuta in larga parte attraverso processi di produzione collettivistici applicati all’attività agricola e perciò la ricaduta politico-sociale del “Grande Evento” neolitico non è tanto consistita nel passaggio inevitabile a rapporti di produzione classisti che sostituivano antiquate relazioni produttive comunitarie, ma nella creazione di un campo di potenzialità alternative sia per i rapporti di produzione che per quelli di potere. Il livello di sviluppo raggiunto dalle forze produttive sociali e dalla divisione del lavoro, a partire dal 9000 a.C., ha prodotto infatti una specie di biforcazione storica in cui era data la possibilità, nello stesso periodo e nelle stesse aree geopolitiche, della riproduzione di rapporti di produzione sia collettivistici che classisti, come prova il fatto che ancora per cinquemila anni in Eurasia (dal 9000 al 3500 a.C.) si sono storicamente materializzate due forme generali di organizzazioni socio-economiche sulla base di un livello relativamente omogeneo di sviluppo della produzione del surplus e della produttività del lavoro. In altri termini, la progressiva esplosione tecnologico-produttiva e demografica del Neolitico ha consentito, sia a livello potenziale che reale, la presenza/riproduzione del “comunismo neolitico” da un lato e di relazioni socio-produttive di tipo “asiatico” o schiavistico dall’altro per effetto di quella biforcazione in base alla quale il surplus e i mezzi sociali di produzione hanno potuto essere prodotti ed appropriati secondo rapporti di produzione comunitari o classisti. Nessun “decreto celeste” esigeva che la cooperazione nel processo produttivo agricolo e nei lavori di irrigazione/disboscamento tornasse solo a vantaggio di una ristretta sezione della società “post-surplus”, come nessuna legge economica imponeva al genere umano, a partire dal 9000 a.C., di utilizzare il “bottino” del surplus e le fonti del bottino (gli strumenti di produzione, come terra, sementi, bestiame) secondo modalità discriminatorie nei confronti della maggioranza della popolazione invece che egualitarie e cooperative.
Pertanto si sono potute storicamente manifestarsi due tendenze socio-produttive alternative, la linea rossa (collettivistica) e la linea nera (classista), addirittura in alcuni casi parzialmente coesistenti come nelle civiltà Chavin e Harappa di cui si dirà. La tesi appena detta trova una prima conferma nel fatto che la più recente ricerca storiografica ha constatato, di sfuggita e quasi per caso, come nella gestione degli affari comuni delle società neolitico-calcolitiche (età del bronzo) si sono affermate realmente due diversi involucri socio-politici, la chefferie collettivistica e la chefferie protoclassista, che si inseriscono in larga parte in quello “stadio medio della barbarie” descritto da Engels nel 1884 come già caratterizzato dalla presenza dell’agricoltura e dell’allevamento, dalla produzione di ceramiche e dalla lavorazione dei metalli (oro, rame, ecc.).
4. La doppia natura della “chefferie”
La chefferie costituisce una categoria storico-teorica elaborata nel XX secolo dalla scuola statunitense neo-evoluzionista di E. Service e M. Fried allo scopo di definire le forme concrete di organizzazione delle strutture politico-sociali neolitiche-calcolitiche composte ormai da centinaia o migliaia d’individui ed in cui un capo deteneva una posizione di comando ufficialmente riconosciuta, occupata di solito per diritto ereditario. Si trattava di un’autorità centrale permanente che prendeva le decisioni politico-economiche più importanti, curando sia la redistribuzione del surplus e delle prestazioni fornite dagli artigiani specializzati che le relazioni più o meno conflittuali con le tribù vicine,. Nella chefferie la novità principale, rispetto all’organizzazione delle precedenti tribù paleolitiche, consisteva nello sviluppo di un sistema di “economia redistributiva” in cui il capo della comunità e i suoi assistenti centralizzavano e ridistribuivano il surplus collettivo indirizzandolo verso gli scopi ritenuti prioritari dalla struttura politico-sociale in cui erano inseriti. Ora, i dati empirici sulle società del passato hanno evidenziato come questo potere politico-economico di redistribuzione del surplus ha potuto essere utilizzato per finalità collettive oppure al servizio di una minoranza che ne traeva vantaggio sia in termini di tempo libero che di livelli di consumo.
Nella chefferie collettivistica dall’8500 al 3900 a.C. il surplus era impiegato quasi esclusivamente per i bisogni collettivi ed individuali della popolazione tutta, riservando al nucleo dirigente politico dei “privilegi” materiali estremamente modesti e limitati (ma non sempre) ad alcuni prodotti artigianali e ad oggetti rari importati da lontano. Questo nucleo formava il cosiddetto “clan conico”, un’élite sociopolitica che non trasformava la sua posizione di comando-gestione degli affari comuni «in reali vantaggi economici»12. La chefferie protoclassista rappresenta invece l’antenato delle formazioni economico-sociali asiatiche e schiavistiche. Diamond ha notato che «in alcuni casi parte dei beni ricevuti dal popolo non venivano ridistribuiti, ma erano consumati dalla casta dominante e da chi lavorava per loro: si trattava allora di un vero tributo, di un precursore delle moderne tasse che fece la sua prima comparsa proprio tra le chefferies. Non solo: il capo poteva chiedere al popolo anche di partecipare alla costruzione di grandi opere, sia queste fossero di utilità pubblica (come un sistema di irrigazione), sia che fossero ad uso e consumo della classe alta (ad esempio una tomba monumentale)»13. Si costituiva in tal modo una “società stratificata” in cui i processi di centralizzazione e redistribuzione dei beni generavano, nei gruppi di rango politico elevato, dei diritti preferenziali d’accesso e possesso ad alcune risorse materiali strategiche.
Ma se la direzione politica unitaria e la sua azione continua di redistribuzione del plusprodotto ha potuto esprimersi mediante due diverse scale di priorità socio-produttive e sulla base di due differenti rapporti sociali di produzione-distribuzione, allora lo schema classico marxista sul legame dinamico esistente tra processi produttivi, sociali e politici deve venire modificato. Esso era stato sintetizzato da G. Plechanov alla fine del XIX secolo nella successione di fasi:
Rapporti di produzione e distribuzione comunitari e collettivistici come base di partenza paleolitica
↓
Sviluppo delle forze produttive
↓
Divisione sociale del lavoro
↓
Surplus costante e accumulabile
↓
Rapporti di produzione e distribuzione di classe
↓
Relazioni sovrastrutturali di natura politico-statali di classe
↓
Altre sovrastrutture ideologiche classiste (religiose, artistiche, morali, ecc.)
Dopo quanto sopra detto esso va sostituito, almeno dal periodo neolitico-calcolitico in poi, dallo schema alternativo in cui:
Rapporti di produzione e distribuzione comunitari e collettivistici come base di partenza paleolitica
↓
Sviluppo delle forze produttive
↓
Divisione sociale del lavoro
↓
Surplus costante e accumulabile
↓
Effetto di sdoppiamento (biforcazione)
(compresenza concreta di due modelli alternativi in campo economico-sociale)
| ↓ Rapporti sociali di produzione/distribuzione di matrice collettivistica |
↓ Rapporti sociali di produzione/distribuzione di matrice classista |
E’ stata proprio la conoscenza della pratica socio-produttiva del periodo neolitico-calcolitico che ha mostrato come in diverse località dell’Eurasia abbiano coesistito rapporti sociali di produzione/distribuzione e di gestione del potere alternativi tra loro, a prova che per almeno cinquemila anni si sono potute confrontare, in interazione ma anche in opposizione tra loro, una “linea rossa” collettivistica ed una “linea nera” classista.
Inoltre l’esperienza storica del 9000/3900 a.C. ci fornisce un secondo e sorprendente elemento di riferimento sintetizzabile nella superiorità e maggiore dinamicità produttiva raggiunta di regola dai rapporti di produzione comunitari e cooperativistici rispetto a quelli classisti. Infatti le migliori performance tecnologiche, produttive e sociali del periodo neolitico-calcolitico sono state conseguite dalle formazioni economico-sociali collettivistiche, con la sola importante eccezione dell’addomesticamento del cavallo da parte dei predoni Kurgan. Come si spiegherà, sono stati proprio i centri d’irradiazione collettivistica quali Gerico, Catal Hüyük, la cultura Ubaid e Vinca in Europa, a costituire i punti più avanzati nello progresso produttivo del genere umano durante i cinque millenni presi in esame.
Emerge infine, dalla vicenda millenaria neolitica/calcolitica conseguente alla combinazione dialettica tra l’effetto di sdoppiamento ed il maggiore dinamismo storico dei rapporti di produzione collettivistici, il primato dei rapporti di forza politico-militari. Se infatti entrambi i rapporti di produzione potevano riprodursi sul piano potenziale e si sono materialmente confrontati nell’arena internazionale per cinquemila anni, il successo riportato di volta in volta dall’una o dall’altra modalità di produzione/relazione sociale è stato determinato nei diversi contesti storici dal “terzo incomodo”d el rapporto di forza politico-militare via via concresciuto. Parafrasando Marx si può dire che “tra modi di produzione diversi decide la forza”, ovvero che la comparsa di correlazioni di potenza politiche e militari sfavorevoli alle più progredite società collettivistiche (la “linea rossa”) ha causato progressivamente, nel periodo neolitico-calcolitico, il successo quasi generalizzato del meno avanzato modo di produzione classista (la “linea nera”) nella forma asiatica o schiavistica, sebbene la tendenza “sconfitta” abbia più volte lasciato un segno, subordinato ma reale, nelle strutture socio-economico-politiche egemonizzate dalla tendenza rivale.
5. Conclusione.
A fronte della estesa e variegata diffusione su scala euroasiatica di società collettivistiche nel periodo neolitico-calcolitico, dal 9000 a.C. e in continuità con le stesse aree geopolitiche stava emergendo un’altra tendenza socio-produttiva che si differenziava nettamente dalla precedente per tutta una serie di elementi economico-politici fondamentali. Prima di metterle a confronto vanno comunque raccolti i parametri oggettivi utilizzabili per differenziare le società neolitiche appartenenti alla “linea rossa” da quelle facenti parte della successiva e rivale “linea nera” che risultano essere: l’assenza di vistose asimmetrie tra le diverse abitazioni delle strutture sociali; l’assenza di differenze molto marcate nelle sepolture dei diversi membri delle comunità; l’assenza di edifici di grandi dimensioni destinati a fini non-produttivi e religiosi; l’assenza del culto delle armi (ivi compreso il culto del cavallo); la presenza, al contrario, del culto gilanico della Dea Madre e di raffigurazioni artistiche riguardanti donne e bambini.
La combinazione tra i vari criteri di differenziazione sopra proposti risulta di regola molto utile per separare nettamente la “linea rossa” dalla “linea nera”, ma non sempre: esistono infatti degli scenari storici che consentono una duplice interpretazione della loro natura sociopolitica e socio-produttiva, come ad esempio l’ultima fase della civiltà neolitica di Varna (odierna Bulgaria) oppure i rapporti di produzione presenti a Malta tra il 5000 ed il 3000 a.C. e nella società minoica14.
Capitolo secondo
La “rossa” Gerico neolitica
1. La “linea rossa” e i suoi luoghi.
Nel periodo neolitico-calcolitico la più avanzata e dinamica tendenza socioproduttiva era quindi quella “rossa” basata su rapporti di produzione collettivistici, sulla gilania (uguaglianza tra i sessi) e su una determinata forma politica di chefferie, il “clan conico”, finalizzata alla tutela delle relazioni cooperative mediante il controllo di una distribuzione sostanzialmente ugualitaria del surplus, spesso indirizzata verso lavori di comune utilità. Sono state società che spesso si sono riprodotte ininterrottamente per secoli (o addirittura millenni), superando a volte gravi problemi geoclimatici (come alluvioni, processi di desertificazione, ecc.) e coinvolgendo nel loro sviluppo milioni di esseri umani15.
Il punto di partenza del segmento collettivistico delle società neolitiche può essere ritrovato a Gerico, una delle più grandi meraviglie della storia dato che proprio nel centro palestinese, a partire dall’8500 a.C., si è venuta progressivamente a creare la prima civiltà urbana del genere umano in quella che per più di duemila anni era diventata la capitale del mondo. Qui infatti i clan neolitici della città e della limitrofa area siro-palestinese non solo riuscirono a domesticare il grano, l’orzo, il farro e i maiali poco “inventando”, dopo il 9000 a.C., l’agricoltura e l’allevamento, ma effettuarono anche l’altra grande scoperta storica della costruzione di una città e dell’avvio della proto-urbanizzazione. In pochi secoli, tra l’8900 ed il 8400 a.C., i clan collettivistici del luogo edificarono una piccola città con una caratteristica serie di abitazioni ovali, composte da mattoni di fango essiccato con un intonaco levigato dipinto di rosso; in una fase successiva apparvero delle case rettangolari con molte stanze e dei microsantuari per la Dea, mentre la popolazione aumentava progressivamente, in una data anteriore al 7000 a.C., fino a superare le duemila unità viventi su di un’area calcolata in oltre quattro ettari che superava per dimensione quella di buona parte dei centri urbani formatisi nell’Europa occidentale durante il XV secolo della nostra era16. Gli abitanti di Gerico erano circondati e difesi da una cinta muraria munita di torri difensive alte fino a dieci metri, dimostrando come già 10.000 anni fa l’arte muraria avesse raggiunto livelli di sviluppo impressionanti, confermati del resto anche dalle costruzioni realizzate attorno al 9000 a.C. dai cacciatori-raccoglitori di Gobekli Tepe. Né l’esperienza di Gerico rimase isolata essendo circondata da tutta una serie di villaggi “minori” del periodo natufiano, quali Ain Mallaha, Nureybet, Ramad, Munhata e Beidha, mentre la rivoluzione produttiva ed urbana doveva estendersi tra l’8000 e il 6000 a.C. a tutto il Vicino Oriente, dall’attuale Turchia (sito di Asili, 8000 a.C.) a Cipro (sito di Khirokitya, VI millennio a.C.), in presenza quasi ovunque dell’egemonia socioproduttiva di rapporti di produzione collettivistici 17.
La seconda concretizzazione della “linea rossa” neolitica è rappresentata dalla città anatolica di Catal Hüyük (nell’odierna Turchia) sviluppatasi tra il 6600 ed il 5600 a.C. che contava circa 6000 abitanti distribuiti in modo egualitario su un complesso abitativo che si estendeva con circa mille abitazioni su uno spazio di 1,5 Km2. Le omogenee case di mattoni e legno erano di forma rettangolare e consistevano in una o due stanze, mentre gli interni erano decorati con cornici di legno rosso e rivestiti di creta e dipinti. Le case erano tutte contigue, oltre che uniformi esternamente, così che la “circolazione” avveniva sui tetti dove si aprivano gli ingressi, mentre una parte di esse era adibita a microcappelle per onorare la Dea Madre con dipinti parietali e offerte votive che attestano il notevole livello di sviluppo artistico raggiunto. Ma gli abitanti neolitici di Catal Hüyük non erano soltanto abili artigiani nel campo dei monili, dell’ossidiana e della produzione di tessuti; dal 6000 a.C. conoscevano anche l’arte della ceramica, mentre sul piano agricolo utilizzavano su larga scala degli efficienti microimpianti di irrigazione artificiale18. Inoltre, come è stato mostrato dall’archeologo britannico James Mellaart, la civiltà di Catal Hüyük era arrivata a conoscere a metà del VI millennio a.C. la metallurgia: lo studioso inglese ha infatti scoperto nel sito anatolico la presenza di scorie che indicano l’estrazione del rame dal minerale attraverso un processo di fusione. Anche in questo caso le conquiste tecnologico-produttive vennero raggiunte in presenza di rapporti di produzione prevalentemente collettivistici e matriarcali, come dimostrato dal culto della Dea e dall’uniformità delle abitazioni: nonostante l’esistenza di alcune limitate forme di differenziazione socioeconomica, gli abitanti di Catal Hüyük ignoravano precisi segni distintivi della chefferie protoclassista quali l’esistenza di grandi edifici religiosi, di tombe speciali destinate a pochi privilegiati e di abitazioni in loro possesso molto più ampie e sfarzose della media di quelle a disposizione dei lavoratori manuali.
La terza “stazione” storica è formata dalla civiltà Al-Ubaid, sviluppatasi in Mesopotamia tra il 4900 ed il 3900 a.C. e protagonista di un nuovo grande salto di qualità produttivo nella storia del genere umano. Essa precedette ed interagì direttamente con la prima fase di sviluppo della società classista dei sumeri, i quali molto probabilmente vissero a stretto contatto con le popolazioni ubaidiche per un lungo periodo incorporandone le conquiste produttive e culturali a partire dal 3900-3800 a.C. La civiltà Ubaid non si limitò a produrre statuette dal corpo umano con il volto di serpente, probabilmente collegati al culto della Dea Madre, ma riuscì ad ottenere nell’ultima fase della sua esistenza una serie impressionante di successi in campo agricolo e tecnologico in seguito imitati su larga scala ed affinati dalla civiltà sumera (non a caso quest’ultima ereditò dai suoi predecessori collettivistici tutta una serie di termini tecnico-produttivi quali engar (agricoltore), apin (aratro), simug (fabbro) e udur (pastore).
Alcuni storici, tra cui M. Liverani, hanno definito giustamente la brusca accelerazione impressa dalla civiltà Ubaid allo sviluppo delle forze produttive sociali come la “rivoluzione secondaria” del Neolitico provocata in campo agricolo da una serie di innovazioni strettamente connesse tra loro e capaci di sfruttare al meglio alcune condizioni geonaturali potenzialmente molto favorevoli: per facilitare il processo di mietitura di grandi estensioni cerealicole, si introdusse infatti un attrezzo quale il falcetto di terracotta a forma di mezzaluna e con il bordo interno affilato, il cui costo di produzione era estremamente basso in confronto a qualunque altro tipo di lama in selce o rame. Inoltre gli Ubaid seppero sfruttare con estrema efficacia l’intreccio di fiumi e acquitrini naturali che contraddistingueva la parte finale del corso del Tigri e dell’Eufrate, realizzando nel corso dei secoli un’estesa rete di canali e un’ottima sistemazione idraulica del terreno basso-mesopotamico19. Venne anche introdotto l’aratro a trazione animale che permetteva di scavare solchi rettilinei della lunghezza di molte centinaia di metri; al momento della semina lo strumento a trazione animale si trasformava in aratro-seminatore mediante l’installazione di un imbuto a cannello che consentiva di collocare i semi uno per uno ed in profondità dentro nel solco. Un simile complesso di innovazioni «deve aver avuto un impatto sulla produttività agricola della bassa Mesopotamia che è senz’altro paragonabile all’introduzione della meccanizzazione nell’agricoltura moderna. Si potrebbero forse tentare dei calcoli più specifici:… In complesso, non è certo azzardato ritenere che il passaggio dal sistema tradizionale (dissodamento a zappa, semina a getto, irrigazione per inondazione) di dimensione familiare, ad un complesso tecnico-organizzativo come quello ora descritto deve aver comportato un aumento di produttività (a parità di risorse umane impegnate) in un ordine di grandezza stimabile tra il cinque a uno e il dieci a uno. Questo che possiamo ben chiamare una rivoluzione delle tecniche agricole, e che si sviluppò nell’arco di alcuni secoli a ridosso della rivoluzione urbana e delle formazioni proto-statali, è un evento storico di enorme rilievo, ed è in vario modo archeologicamente documentato. È stupefacente constatare quanto poco se ne parli nella corrente letteratura storico-archeologica sull’argomento, prevalentemente accentrata sugli sviluppi della struttura sociale e dell’élite dirigenti, sviluppi spesso estraniati da quelli relativi al modo di produzione»20.
La risposta alla questione sollevata da Liverani sta probabilmente dal fatto socioproduttivo innegabile che la struttura sociopolitica degli Ubaid era incentrata su di un “clan conico” in cui le disuguaglianze socioeconomiche tra gli abitanti erano ridotte al minimo, fatto evidentemente poco apprezzato da larga parte degli storici21. Infatti siamo qui davanti ad «una cultura piuttosto egualitaria e piuttosto severa: priva di vistosi dislivelli, di fenomeni di accentramento, di tesaurizzazione e di ostentazione, o altro. Si pensi alla ceramica, che la produzione in serie, alla “ruota lenta”, depriva di quelle vivaci caratterizzazioni e decorazioni delle culture precedenti. Si pensi all’assenza di vistose differenze nella dimensione e la struttura degli abitati, che ove scavati su estensioni sufficienti (nel caso di Tell es-Sawwan e di Tell’Abada) colpiscono assai più per il loro aspetto omogeneo che non per la presenza di ovvie gradazioni dimensionali. Si pensi all’omogeneità e povertà delle sepolture (ogni inumato è accompagnato da un paio di vasi di tipo standard e da un modesto ornamento personale), senza quella concentrazione diversificata di ricchezza che normalmente fornisce l’indicatore privilegiato per l’emergenza di élite. Si pensi più in generale all’estrema rarità, per non dire assenza (sia in contesti funerari sia di abitato), di materiali e oggetti di pregio e di importazione, come metalli o pietre semi-pregiate. Questo carattere severo e sostanzialmente egualitario della cultura Ubaid può non stupire di per sé, ma deve certamente stupire se rapportato al fatto che proprio allora s’innescava quella decuplicazione dei rendimenti agricoli, quella possibilità di eccedenze sostanziose di cui abbiamo detto sopra. La crescita demografica complessiva, nonché la floridezza generalizzata deducibile dalla dimensione e dalla fattura tecnica delle abitazioni, non hanno adeguato parallelo in una crescita di dislivelli interni – o almeno nella loro sottolineatura mediante pratiche ostentatorie»22.
Ma la “linea rossa” neolitica si concretizzò anche in altri contesti geo-economici e geo-politici, sebbene con modalità e tempi storici del tutto indipendenti da quelli vissuti nell’area del Mediterraneo orientale e del Golfo Persico. Nell’Europa centro-orientale si svilupparono tra il 6000 ed il 3000 a.C. avanzate culture collettivistiche (la c.d. civiltà di Vinca) che si estesero dai Balcani fino al Baltico creando la prima forma storica conosciuta di protoscrittura, coltivando cereali, producendo splendide ceramiche e gioielli in oro ed arrivando nell’ultima fase della loro esistenza ad impadronirsi della tecnica della metallurgia del rame. Secondo l’opinione di M. Gimbutas, C. Renfrew e Gordon Childe questa civiltà era composta da una serie di città e villaggi locali autonomi con forti componenti paritarie tra i sessi, abitati da agricoltori egualitari la cui organizzazione sociale non possedevano alcun ordine gerarchico stabile e rigido23.
Sempre in Europa apparvero anche delle civiltà megalitiche matriarcali, diffusesi tra il 4000 ed il 1000 a.C. in un’area posta tra il Portogallo, la Sardegna, l’isola di Malta e la Gran Bretagna. Le grandi opere realizzate in pietra richiesero sia la presenza di un surplus agricolo costante che di un alto grado di coesione sociale tra le donne e gli uomini impegnati nella creazione di monoliti giganteschi e cerchi di pietra, ma sempre in assenza di strutture statali o di elevati livelli di differenziazione socioeconomica al loro interno.
Secondo alcuni storici, risulta chiara anche la matrice semicollettivistica dei rapporti di produzione e politico-sociali che contraddistinsero le antiche civiltà sorte nelle pianure alluvionali dell’Indo e dei suoi cinque principali affluenti nell’odierno Punjab: le culture di Harappa e Mohenio-daro, dal nome delle due principali città dell’India neolitica che si riprodussero tra il 3500 ed il 1900 a.C., anche se va ricordato che fin dal 7000 a.C. si era sviluppata nell’area la città di Mehrgath (ora sommersa) nel golfo di Cambaye, sede di una sofisticata comunità di agricoltori le cui abitazioni erano già fatte in mattoni.
La civiltà di Harappa era formata da una pleiade di estese città (ne sono state ritrovate circa ottanta) che coesistettero pacificamente per oltre un millennio su di un’area geografica estesa quasi come l’Europa occidentale, raggiungendo livelli “ubaidici” di sviluppo delle forze produttive, visto che l’agricoltura basata su un sistema idrico artificiale garantiva surplus notevoli di cereali e favoriva la crescita di agglomerati urbani con decine di migliaia di persone, come la stessa Harappa che aveva un perimetro di quattro chilometri, vie ben progettate e un magnifico sistema di fognature. Sul piano sociale comode case a due piani in cotto, provviste di stanze da bagno e di un alloggio per il portinaio, che coprivano ben 97 piedi per 83, possono venir messe in contrasto con monotone file di casette in mattoni di fango, composte ciascuna di due sole stanze e di un cortile e che non superavano la superficie di 56 piedi per 30. Senza dubbio questo è un contrasto che riflette una divisione della società in classi, ma, a quanto pare, soltanto fra mercanti o “uomini d’affari” e lavoratori o artigiani. Una sorprendente ricchezza di ornamenti d’oro, d’argento, pietre preziose e porcellana, di vasellame di rame battuto, di utensili e di armi di metall, è stata raccolta dalle rovine. La maggior parte proviene dalle case attribuite ai “ricchi mercanti”, ma una quantità di arnesi di rame e di braccialetti d’oro è venuta fuori a Harappa nei “quartieri degli operai”. Nulla fa pensare a tesori regi»24. Non è casuale che la civiltà semicollettivistica di Harappa sia stata caratterizzata a livello religioso dalla presenza di divinità femminili e dal culto della fertilità, che generalmente è il segno distintivo delle società gilaniche, egualitarie e pacifiche. Si trattava quindi di una civiltà già complessa ma con un basso livello di stratificazione sociale, a cui doveva poi succedere la cultura ariana ferocemente militarista e classista ma incapace di replicare le opere di canalizzazione urbana (a disposizione di tutti gli abitanti) create in precedenza dalle antiche città egualitarie.
In Cina la manifestazione più avanzata del collettivismo neolitico è stata rappresentata dalla cultura di Yangshao, di cui sono stati ritrovati oltre mille siti nel bacino del Fiume Giallo e nel Gansu e che si sviluppò tra il 4800 ed il 2000 a.C. ereditando direttamente le precedenti conquiste della civiltà di Peiligang. Le diverse collettività appartenenti alla matriarcale cultura Yangshao coltivarono per tre millenni il miglio attraverso forme produttive cooperative e comunitarie, iniziando allo stesso tempo su microscala quei lavori d'irrigazione che avrebbero contraddistinto la storia cinese, mentre parallelamente integravano l’attività agricola con l’allevamento di cani e di maiali e con la caccia/pesca. «Tra i numerosi siti Yahgshao il più significativo è senza dubbio quello di Banpo, nei pressi di Xi’an, in cui sono stati rinvenuti i resti di un villaggio distribuiti su un’area di oltre 10.000 mq. Situato a circa 300 m. dal fiume Chan, un affluente del fiume Wei, il villaggio, di pianta grosso modo ovale, presenta la zona abitativa al centro divisa in due aree da un piccolo fossato; tutt’intorno è scavato un fossato più grande profondo sei metri, e ad est di esso si trovavano le fornaci per la cottura delle terrecotte, mentre a nord era situato il cimitero comune. Le abitazioni, a pianta circolare o quadrangolare, erano capanne seminterrate cui si accedeva attraverso uno stretto cunicolo; al centro della zona abitativa era posta una capanna di grandi dimensioni (20 m. per 12,5 m.), probabilmente un edificio comunitario. All’interno del villaggio sono stati trovati un gran numero di manufatti in pietra, in osso e in terracotta. Si ritiene che la comunità di Banpo – come le altre della cultura Yangshao – fosse caratterizzata da un sistema sociale di tipo egualitario, anche se la vita della comunità doveva essere regolata probabilmente da una complessa ritualità. Le tombe, le dimensioni delle abitazioni e le fosse per l’immagazzinamento delle derrate presentano infatti dimensioni simili, e anche i corredi delle sepolture non appaiono contrassegnati da differenze rilevanti riguardo alla loro quantità»25.
2. La “linea nera” e i suoi luoghi
Si può assumere che la “linea nera” del Neolitico sia partita da Nevali Cori, situata nell’attuale Kurdistan, le cui origini risalgono all’8900 a.C. La città-tempio di Nevali Cori era composta quasi esclusivamente da edifici di culto alimentati da un plusprodotto, estorto alla zona agricola circostante, che veniva monopolizzato da una casta sacerdotale strettamente separata dai comuni “sudditi”, visto che solo una parte delle ventidue costruzioni che vi sono state scoperte era usata come abitazione, mentre gli altri edifici erano adibiti a templi o a magazzini ed officine di supporto di questi ultimi. Il centro della teocrazia della città anatolica era disposto attorno ad una struttura rettangolare di pietra, un edificio di culto comprendente giganteschi monoliti con lati perfettamente regolari ed inseriti in un basamento liscio. Le costruzioni “sacre” erano utilizzate con tutta probabilità anche per compiere sacrifici umani.
Questo prototipo di società protoclassista, quasi contemporaneo a Gerico e relativamente vicino alla città palestinese, era la conseguenza dalla diffusione tra i pastori del neolitico di rapporti di produzione patriarcali in cui il maschio più anziano controllava il lavoro e il surplus prodotto da moglie/mogli, figli ed un numero solitamente ristretto di schiavi/schiave. Questo modello alternativo d’organizzazione della vita socioproduttiva e politica si era sviluppato contemporaneamente alla dinamica di riproduzione delle società collettivistiche di Catal Hüjük, Ubaid e Vinca, e a volte in aree geopolitiche limitrofe26. Era questa la cultura propria dei pastori nomadi del Neolitico che avevano la caratteristica comune di rientrare (sia pure con alcune eccezioni) nel raggio d’azione della “linea nera”, a partire dal fatto che l’allevamento e la cura delle mandrie erano occupazioni tipicamente maschili.
«Gli antropologi, naturalmente, rifuggono dalle generalizzazioni, ma persino loro sono costretti ad ammettere che i popoli dediti alla pastorizia di qualunque angolo del mondo condividono delle caratteristiche fondamentali. Tutti sono ossessionati dalle loro pecore, capre, mucche, cammelli o cavalli, a seconda del caso, perché questi animali garantiscono sia l’identità tribale che i mezzi di sostentamento. La mandria è tutto per i popoli dediti alla pastorizia e nulla può frapporsi fra mandrie, pascoli e aree d’abbeveraggio. Se ciò accade, la loro monomaniacalità si trasforma rapidamente in efferatezza, il disprezzo in violenza. In Thinking Animals Paul Shepard elenca i tratti caratteristici delle società pastorali di qualunque parte del mondo: “Aggressività ostile verso i forestieri; famiglie, faide e scorrerie armate nell’ambito di un’organizzazione gerarchica patriarcale; costituzionale della caccia con la guerra; elaborate cerimonie sacrificali; orgoglio e sospetto monomaniacali”. Marvin Harris ha analizzato moltissime culture umane differenti alla ricerca di elementi che le accomunassero. In Cannibali e re afferma che “molte società pastorali prestatali, nomadi o seminomadi, sono espansioniste e ultramilitariste”. Tali società sono solitamente bellicose e a forte dominanza maschile perché la loro principale fonte di sussistenza e ricchezza “sono gli animali da pascolo piuttosto che i raccolti agricoli”. Proprio perché così legate alle mandrie, le pressioni economiche obbligano le popolazioni dedite alla pastorizia a vivere al loro seguito, spostandosi per miglia alla ricerca di acqua, pascoli e altri animali di cui impossessarsi. Nel resoconto sulle varie culture pastorali contenuto nel volume Man, Culture and Animals curato da Anthony Leeds e Andrei Vayda, l’antropologo Homer Aschmann sottolinea il medesimo bisogno di espansione territoriale: “Nella maggior parte delle culture pastorali è riscontrabile uno schema molto forte e definito basato sull’aggressività individuale e collettiva, nonché su strutture istituzionali ed elaborazioni etiche con valore giustificativo”. Sempre Aschmann rileva anche un’ulteriore caratteristica della distruttività delle società pastorali e cioè che la loro tendenza a ingrandire le proprie mandrie va invariabilmente a scapito della qualità dei terreni di pascolo: “Nessuna società basata sulla pastorizia ha mai raggiunto uno stabile equilibrio ecologico se non a patto di accettare un livello di produttività inferiore rispetto a quello esistente al momento dell’introduzione della pastorizia stessa”»27.
Il lato nomade-pastorizio del processo produttivo sviluppatosi nel periodo neolitico-calcolitico ha prodotto delle conseguenze decisive all’interno dell’area eurasiatica, modificando progressivamente i rapporti di forza tra clan agricoli e nomadi fino a indirizzare le relazioni sociali di produzione in una direzione protoclassista ed espansionistica che si adattava perfettamente alle caratteristiche dominanti di larga parte dei clan pastorali. «Fu in Medio Oriente che il potere regale, le guerre e le scorrerie raggiunsero proporzioni inaudite a causa delle influenze culturali delle prime popolazioni che in quei luoghi si dedicarono alla pastorizia. Non dimentichiamoci che i primi addomesticatori di animali di grossa taglia discendevano da una lunga tradizione di specializzazione nella caccia e, pertanto, conservavano intatta la loro perizia di cacciatori-guerrieri. Tale perizia tornò molto utile nel favorire la creazione di vere e proprie mandrie, cioè della loro ricchezza e sicurezza. Dal punto di vista di un cacciatore-guerriero era molto più prestigioso (nonché più facile e veloce) ampliare la propria mandria perpetrando razzie piuttosto che non impegnarsi in un lento e faticoso lavoro di allevamento. Le abilità guerriere erano inoltre utili a mantenere la ricchezza acquisita; una tribù in condizioni economicamente floride doveva, infatti, stare costantemente all’erta per difendersi da possibili razzie altrui. Infine i pastori erano marcatamente più espansionisti dei comuni agricoltori. I coltivatori vivevano in pochi acri in una vallata o lungo la riva di un fiume e ampliavano i propri campi molto lentamente, in genere nel corso di diversi anni. I pastori, al contrario, dominavano con arroganza su un’intera regione grazie alla forza militare, assicurandosi in tal modo l’accesso ai migliori pascoli e alle migliori aree d’abbeveraggio. In Medio Oriente, i pastori si trovavano nella posizione migliore per alimentare le fila della casta dei guerrieri, da cui sorsero poi le élite dominanti e i re. Di conseguenza, l’intera gerarchia sociale e la cultura di quella regione erano imbevute dei valori di fierezza e predominio tipici dei popoli pastorali. Quando tali valori vennero integrati nella religione e nelle istituzioni militari e di governo si rivelarono essenziali alla nascita di nazioni dispotiche pronte a condurre guerre di conquista»28.
Le forme iniziali dei rapporti di produzione patriarcali e protoclassisti fecero un decisivo salto di qualità in Eurasia presso le tribù dei pastori-predoni Kurgan (così chiamati dalla archeologa Marija Gimbutas dalle sepolture individuali poste sotto un tumulo, o alture arrotondate, dette kurgan29) che dimoravano nella zona del Volga e nell’Ucraina fin dal 6000 a.C. In collegamento con la domesticazione del cavallo, avvenuta attorno al 4400 a.C. nelle steppe a nord del Mar Nero, che consentiva di coprire distanze maggiori, attaccare di sorpresa e fuggire prima dell’arrivo dei rinforzi, e col parallelo miglioramento nella produzione di strumenti da guerra come l’arco e le frecce, il rapido peggioramento delle condizioni geoclimatiche dal 4000 a.C. in avanti ha favorito i processi migratori e predatori dei gruppi di nomadi pastori che vi risiedevano. I quali vivevano in una società patriarcale contraddistinta, di regola, dalla dimensione ridotta delle attività agricole e dal notevole peso assunto invece dall’allevamento degli animali e in cui la tumulazione solenne dei “capi”, accompagnata alle volte anche dal sacrificio dei loro schiavi, simboleggiavano relazioni sociali fondate apertamente sulla disuguaglianza e l’aggressività militare. L’introduzione della proprietà privata degli armenti in queste tribù pastorizie ne incentivò l’attività predatoria contro le più avanzate strutture agricole sedentarie con i terreni di proprietà collettiva, mentre i bottini procurati dalle guerre condotte a mezzo della coppia cavallo-arco stimolarono un salto di qualità nella differenziazione di classe: le vinte comunità agricole europee fornirono su larga scala schiavi e schiave, forza-lavoro ed oggetti sessuali, surplus produttivo e ricchezza a questi nomadi predatori, determinando il definitivo trionfo al loro interno dei rapporti di produzione classisti, mentre anche le civiltà “indigene” sopravissute all’invasione dovevano imitare per sopravvivere quel modello di società e di chefferie esportato con tanto successo dai barbari ma bene armati Kurgan.
Le tre grandi ondate d’invasione delle popolazioni Kurgan in Europa e nel Medio Oriente nel 4400-4200 circa, nel 3400-3200 circa e nel 3000-2800 circa a.C.30 e poi quelle successive degli indoeuropei hanno rappresentato i momenti principali della guerra mondiale neolitica che ha opposto per millenni le strutture pastorali patriarcali a quelle agrarie matrilineari ed egualitarie ed è terminata con la sconfitta delle seconde (anche se alcune zone del Mediterraneo come Creta, Malta e la Sardegna hanno potuto sottrarsi per più di mille anni all’invasione di quei popoli pastori sensibilmente più arretrati sul piano produttivo e tecnologico-civile). Raggruppati inizialmente in piccole bande, i pastori Kurgan inflissero danni notevolissimi alle civiltà neolitiche collettivistiche dei Balcani e dell’Europa centrale, essendo gli agricoltori sedentari «facile preda delle improvvise incursioni di nemici a cavallo che non potevano essere né inseguiti né puniti. Molti di questi villaggi furono abbandonati e i loro abitanti divennero cacciatori a cavallo per autodifesa»31.
Dopo il 2000 a.C. sarà il popolo nomade degli ari proveniente dalle steppe dell’Asia centrale ad impadronirsi dell’area indiana, soggiogando progressivamente le popolazioni autoctone ivi stanziate, mentre in Mesopotamia l’arrivo attorno al 3900 a.C. della popolazione dei sumeri ha portato alla rapida scomparsa della millenaria ed avanzata civiltà Ubaid e alla creazione da parte degli invasori della prima struttura statale del genere umano con città dominate da teocrazie in grado di controllare a proprio vantaggio il processo produttivo e la costruzione/manutenzione di opere d’irrigazione su larga scala. In Cina “la linea nera” è stata rappresentata dalle culture di Dawenkou, Hongshan e Longshan. Nella prima il livello di sviluppo delle forze produttive in campo agricolo era praticamente equivalente a quella raggiunta dai quasi contemporanei clan di Yangshao, ma i rapporti di produzione dominanti e la forma delle chefferies politico-sociali appartenevano ormai alla tipologia protoclassista: «il grande divario esistente tra le sepolture di questa cultura per quanto concerne sia le dimensioni che la ricchezza dei corredi, sta ad indicare che già esistevano all’interno delle comunità forti differenziazioni sociali. Inoltre la presenza dei crani di maiale nelle sepolture farebbe pensare a sacrifici funerari riservati a un gruppo ristretto, ormai classificabile come una vera e propria élite»32. Anche la “cultura della giada” della civiltà Hongshan (4000-2500 a.C.) era protoclassista ed elitaria, con città dotate di grandi templi e strutture difensive governate da un’aristocrazia che monopolizzava il potere, gli articoli di lusso fatti con la preziosa giada e le funzioni religioso-sacrificali, stimolando anche la costruzione di numerose piramidi. Attorno al terzo millennio a.C. nel bacino del Fiume Giallo si formarono le culture Longhshan dello Shaanxi, dello Henan e dello Shandong in cui, se gli strumenti di produzione agricola sono «rappresentati ancora da vanghe, zappe, falcetti e i materiali impiegati continuano ad essere la pietra, l’osso, il corno, le conchiglie, consistenti progressi si realizzano invece nella produzione della ceramica (accanto a terrecotte grigie, probabilmente di uso comune, compare infatti un vasellame nero ad impasto fine caratterizzato da una grande eleganza e lucentezza)... e nella stratificazione sociale, ormai profonda e probabilmente consolidata, come sembra indicare l’analisi delle sepolture. Tra il progresso della ceramica e l’approfondimento delle differenziazioni sociali esiste probabilmente una stretta connessione: il vasellame in ceramica nera era destinato certamente all’élite, che quasi certamente lo utilizzava a fini rituali. D’altro canto, il ritrovamento di numerose scapole di animali impiegati a scopo divinatorio – una pratica questa che avrebbe conosciuto un notevole sviluppo nell’epoca successiva – denota senza dubbio la comparsa di un sistema ideologico relativamente complesso, collegato con un’élite politico-religiosa»33.
In Egitto, infine, il periodo che va dal 3500 al 3200 a.C. ha visto, in presenza di un livello stabile di sviluppo qualitativo delle forze produttive, la nascita e la riproduzione di notevoli disuguaglianze sociali tra la popolazione testimoniate dalla ricchezza degli addobbi e dalla particolare forma rettangolare di alcuni sepolcri. Ciò è stato quasi sicuramente l’effetto dell’invasione, dopo il 3500 a.C., di popolazioni d’origine semitica che imposero la loro egemonia politico-sociale determinando la formazione di una chefferie protoclassista dal cui interno sarebbero emersi i primi faraoni, i capi politico-militari che unificarono progressivamente in un’unica formazione statale le diverse città sorte lungo il Nilo. Secondo E. J. Baumgartel questa tesi è suffragata dai dati archeologici e dalla sussistenza nella lingua egiziana di elementi sia semitici che camitici, questi ultimi derivati dalla popolazione presente sul posto prima del 3500 a.C.34.
3. La “linea nera” contro la “linea rossa”
Tenendo conto delle sopracitate coesistenze storiche tra la “linea rossa” e la “linea nera” è possibile trarre una prima riflessione sintetica notando che dal 9000 a.C. in poi l’effetto di sdoppiamento ha reso possibile la riproduzione, sincronica nel tempo e contigua nello spazio, di chefferies sia collettivistiche che protoclassiste a seguito della presenza di un surplus costante e accumulabile che poteva essere utilizzato in forme alternative dovuto ad un livello qualitativo di sviluppo delle forze produttive simile, se non più favorevole, alla “linea rossa”. E’ all’interno di questo campo di possibilità differenti che si è inserita la concreta prassi politica delle diverse civiltà neolitico-calcolitiche nel suo aspetto specifico di controllo del potere decisionale e militare, della redistribuzione del plusprodotto sociale e del possesso dei mezzi di distruzione.
Germi e prodromi della “linea nera” erano già presenti nelle comunità paleolitiche, rivelandosi nel possesso privato di alcuni oggetti di consumo, nelle sporadiche lotte e razzie tra clan preistorici e nei limitatissimi “privilegi” materiali di cui a volte godevano i capi-clan, ma è solo con la comparsa di un surplus costante che questi germi vengono a maturazione come in una serra protetta, trasformandosi in una tendenza reale, sia oggettiva che soggettiva, insita nella coscienza di segmenti più o meno ampi della popolazione essendo diventato possibile utilizzare la forza-lavoro altrui a vantaggio di una minoranza a condizione che quest’ultima controlli il potere decisionale sul surplus e i mezzi di distruzione della comunità. Se le chefferies collettivistiche si erano affermate negli scenari storici in cui mancava il monopolio nell’uso delle armi da parte di una minoranza ed in cui la redistribuzione del surplus non andava a vantaggio di una sola parte della popolazione, le chefferies protoclassiste della “linea nera” vinsero laddove si attuarono concretamente queste due condizioni preliminari di carattere sia materiale che politico.
Sorge a questo punto inevitabile una domanda sulle cause fondamentali dell’affermazione della “linea nera”: cosa ha fatto la differenza e quali fattori hanno spostato la bilancia a favore di una delle due soluzioni storiche possibili? Escludendo i fattori casuali indipendenti dalla pratica umana (come catastrofi naturali, siccità, epidemie ecc.) e prescindendo anche dal livello qualitativo di sviluppo delle forze produttive che era più spesso favorevole alle culture della “linea rossa”, risultò decisiva la presenza di particolari dinamiche belliche e religiose relative, da un lato, alle relazioni “estere” tra le diverse tribù/società e, dall’altro, ai rapporti “interni” via via creatisi tra i sacerdoti e i fedeli dei culti religiosi. La “linea nera” si affermò in primo luogo mediante le guerre di conquista condotte, tra il 4400 ed il 1500 a.C., dalle società pastorizie e patriarcali euro-asiatiche attratte dal surplus permanente consentito dal maggior livello di sviluppo delle forze produttive raggiunto dalle collettività agrarie-sedentarie, mentre la loro superiorità politico-militare, grazie soprattutto all’utilizzo del cavallo, ha determinato la creazione di un monopolio dell’uso delle armi a vantaggio esclusivo dei conquistatori mentre i prigionieri di guerra erano mutati in schiavi e trasformati in forza-lavoro subordinata a disposizione di quelle chefferies protoclassiste che poi dovevano evolversi nei modi di produzione classisti (asiatico, schiavista e feudale).
Ma nel periodo ci fu anche una sorta di “via pacifica” ed endogena di affermazione delle formazioni economico-sociali protoclassiste mediante il “cavallo di Troia” dell’apparato religioso-politico. Per decine di migliaia di anni, dal Paleolitico superiore in poi, forme variegate d’autocoscienza religiosa, come lo sciamanesismo, il culto dei morti e quello della “Grande Madre”, avevano rappresentato la sovrastruttura ideologica delle culture collettivistiche combinandosi felicemente con i rapporti di produzione comunistico-primitivi35. Dopo la produzione-riproduzione di un surplus permanente ed accumulabile, tuttavia, era diventato possibile un utilizzo alternativo, di classe, anche della psicologia religiosa diffusa tra i membri dei clan neolitici. A tale scopo era sufficiente la formazione più o meno casuale di un apparato religioso-politico dotato di un minimo di massa critica numerica e di un prestigio sociale in grado di assegnare legittimità e consenso alla scelta di destinare una parte del prodotto alla costruzione di templi e alla riproduzione materiale privilegiata di una gerarchia religiosa che nel tempo, spostando i rapporti di forza a proprio favore, avrebbe finito per accrescere la sua quota di appropriazione del surplus produttivo, dotandosi anche di apparati militari per la difesa dei privilegi così guadagnati.
Anche senza violenza o con l’utilizzo di un minimo grado di coercizione iniziale si poterono creare così le basi politiche ed ideologiche per la riproduzione di chefferies e stati classisti imperniati sull’appropriazione del plusprodotto e dei mezzi di produzione sociali a vantaggio di una minoranza, come a Nevali Cori nel corso del nono millennio a.C. Non è certo casuale che la prima formazione statale classista, quella sumera, fosse imperniata su di una teocrazia egemonizzata da una élite politico-religiosa ristretta, mentre la conferma a contrario di questa ipotesi va ritrovata nell’assenza di guerre di conquista e/o di apparati ecclesiastici su larga scala nelle chefferies e nelle formazioni economico-sociali collettivistiche da Gerico agli Ubaid.
Ma perché mai una parte del genere umano avrebbe dovuto sfruttare a proprio esclusivo vantaggio le potenzialità alternative create dal “Grande Evento” del 9000 a.C., abbandonando i metodi di produzione/distribuzione collettivistici riprodottisi per due milioni di anni? La ragione fondamentale sta nello sviluppo dei bisogni materiali già relativamente elevato all’inizio del neolitico. L’uomo paleolitico lavorava relativamente poco (tre-quattro ore al giorno in media) e aveva interiorizzato sia un legittimo “diritto all’ozio” che una certa riluttanza ad impegnarsi in attività faticose e prolungate, come erano quelle agricole e pastorizie. Come inevitabile sottoprodotto doveva essere diffusa, più o meno intensamente, la tentazione di scaricare il proprio pesante carico di lavoro su altri esseri umani, dagli eventuali prigionieri di guerra alle donne. Va inoltre notato che già attorno al 9000 a.C. l’uomo paleolitico aveva sviluppato una serie di bisogni di consumo che si possono dire superflui perché non indispensabili alla riproduzione puramente fisiologica, come oggetti ornamentali, vestiti e calzature erano già prodotti e consumati. La disponibilità materiale di questi beni “di lusso” si era accresciuta con l’avvio della produzione di oggetti di ceramica decorati, di gioielli in oro e giada, di bevande alcoliche quali la birra e il vino (dopo il 4500 a.C.) e di suppellettili in legno per le abitazioni. Questa massa di beni di consumo di qualità superiore poteva scatenare in alcuni individui e in alcune tribù di pastori di regola meno evolute sul piano tecnologico-civile delle tentazioni predatorie finalizzate ad appropriarsene senza lavorare.
Insomma, potenzialità socioproduttive e presenza costante del surplus, tentazioni/desideri materiali elitari e rifiuto del lavoro vennero in reciproco contatto nel periodo in esame, creando in una serie crescente di casi storici quelle strutture protoclassiste della “linea nera” che attorno al Mediterraneo dovevano diventare egemoni soprattutto in seguito alle invasioni dei pastori Kurgan.
4. La sopravvivenza della “linea rossa”
Tuttavia l’effetto di sdoppiamento non ha cessato di esercitare la propria influenza sul processo storico universale anche dopo la fine del neolitico-calcolitico. Sebbene in Eurasia dal 3900 a.C. l’egemonia politica, sociale ed economica sia stata detenuta quasi sempre dalla “linea nera” (classista, patriarcale e militarista), in questi ultimi sei millenni la “linea rossa” si è mantenuta carsicamente nel processo di sviluppo socioproduttivo del genere umano, sebbene (quasi) sempre in posizione subordinata, perché non sono venute meno alcune basi materiali e sociopsicologiche che ne consentono la riproduzione come lato secondario e deformato all’interno delle formazioni economico-sociali di classe.
Intanto anche dopo il 3900 a.C. la terra e i campi hanno potuto essere posseduti collettivamente e coltivati in comune, in tutto o in parte, mentre l’attività produttiva combinata ha prodotto masse variabili di surplus potenzialmente utilizzabili a vantaggio dell’intera collettività, e non solo di una sua ristretta minoranza. Ma è stato possibile utilizzare per fini cooperativi anche il “lavoro universale” inteso come «ogni lavoro scientifico, ogni scoperta o invenzione che dipende in parte dalla cooperazione tra i vivi e in parte dall’utilizzazione del lavoro dei morti»36, nonché il “bene immateriale” della conoscenza scientifico-tecnologica che, potendo essere riprodotto e replicato anche dai non-inventori in seguito all’uso, è facilmente (sebbene non inevitabilmente) condivisibile. E poi la manifattura e la grande industria hanno potuto essere oggetto di esperienze diffuse di stretta cooperazione produttiva e quindi di appropriazione collettiva invece che privata. Risultano così verificabili almeno otto tracce, sia pur subordinate e deformate, che attestano come la “linea rossa” non sia mai sparita del tutto dall’orizzonte della storia, coesistendo conflittualmente con la tendenza egemonica socio-produttiva espressa dalla “linea nera”.
La prima traccia riguarda la soggettività di alcune frazioni di produttori diretti che hanno continuato ad essere sostenitori della “linea rossa”, esprimendo una volontà collettivistica antagonista rispetto ai rapporti di produzione e distribuzione classisti. E’ questa la categoria degli uomini rossi in cui vanno compresi tutte le donne e gli uomini che si sono ribellati apertamente contro l’oppressione e lo sfruttamento, conservando e tramandando l’utopia di un mondo di liberi ed eguali sotto forme sia laiche che religiose. In essa vanno inglobati anche gli schiavi, i servi della gleba e i lavoratori salariati che con la fuga o la lotta aperta, sia economica che politica, hanno sfidato i loro padroni, nonché gli “eretici” comunisti periodicamente sterminati nel mondo perchè oppositori delle costanti di fondo che hanno accomunato tutti i modi di produzione classisti dal 3900 a.C. in poi.
La seconda traccia si è manifestata nella riproduzione secolare della cosiddetta “parte subordinata” del modo di produzione asiatico costituita dalle comunità rurali agricolo-artigiane contraddistinte dall’inesistenza della proprietà privata del suolo e caratterizzate da una rete di solidarietà comunitaria e dall’appropriazione collettiva (in varie forme) del prodotto del lavoro comune. L’autorità politica centrale con le sue emanazioni periferiche ne costituiva invece l’altra (e principale) parte che si appropriava, con la minaccia della violenza, del plusprodotto erogato dalle comunità di villaggio, fornendo in cambio limitate prestazioni produttive quali la direzione della creazione/manutenzione delle opere d’irrigazione e la regolamentazione delle forniture d’acqua oppure limitandosi a svolgere attività magico-simboliche.
La terza traccia lasciata dall’“effetto di sdoppiamento” proviene dalle esperienze di stati degli schiavi sorti sull’onda dei rarissimi movimenti di ribellione sociale che sono riusciti a rovesciare, ma solo per brevi periodi, i rapporti di potere padronali in aree relativamente estese. Nel 136-132 a.C. un grande movimento armato di schiavi in Sicilia, dopo aver battuto larga parte dell’esercito romano presente nell’isola, elesse un proprio consiglio direttivo ed un leader indiscusso di nome Euno: durante il breve periodo di tempo in cui gli ex-schiavi controllarono buona parte dell’isola, essi coniarono proprie monete con inciso il nuovo nome preso da Euno (Antioco), ma soprattutto riorganizzarono in senso cooperativo i rapporti di produzione rurali abolendo le relazioni schiavistiche prima esistenti. Anche nel regno di Pergamo (Asia Minore) una rivolta antiromana di schiavi e poveri-liberi guidata da Aristonico, figlio di un precedente sovrano, fondò tra il 132 ed il 130 a.C. un effimero “Stato del Sole” la cui ambizione era quella di diventare un regno della libertà e dell’uguaglianza, riprendendo apertamente elementi sociopolitici collettivistici presenti nel culto della divinità solare diffusa in larghi strati popolari di quell’area. Nel 104-101 a.C. gli schiavi siciliani insorsero nuovamente sotto la guida di Atenione e Trifone riottenendo il controllo di una larga parte dell’isola trasformata in una comunità di uomini liberi (come ammesso dallo storico romano-schiavista Diodoro), sebbene il processo di consolidamento dei nuovi rapporti di produzione collettivistici venne interrotto dalla vittoria delle armate di Roma.
L’effetto di sdoppiamento ha trovato una quarta traccia nella persistenza delle comuni rurali che si sono riprodotte all’interno del modo di produzione feudale in Europa. La comune rurale medioevale di matrice germanica ha attraversato due fasi di sviluppo: durante la prima era comune non solo la proprietà del suolo, ma anche il lavoro ed il prodotto, tranne la parte destinata alla riproduzione, era ripartito secondo i bisogni di consumo della collettività; nella seconda fase “dualistica” la terra era ancora di proprietà pubblica inalienabile, ma veniva periodicamente suddivisa e distribuita tra i membri della collettività così che ciascuno potesse coltivarla appropriandosi individualmente dei frutti del proprio lavoro (al netto delle quote di beni/lavoro destinate alla riproduzione agricola e alla classe feudale). In una lettera indirizzata a Vera Zasulich, nel 1881 Marx ha espressamente rilevato i segni dell’esistenza dell’“effetto di sdoppiamento” in quest’ultimo tipo di comune agricola: «è ovvio che il dualismo inerente alla costituzione della comune agricola può dotarla di un’esistenza vigorosa. Emancipata dai legami forti ma ristretti della parentela naturale, la proprietà comune della terra e i rapporti sociali che ne discendono le garantiscono una solida base, mentre la casa e la corte rustica, dominio esclusivo della famiglia individuale, la coltura particellare del suolo e l’appropriazione privata dei suoi frutti, danno all’individualità un impulso incompatibile con la struttura delle comunità più primitive. Tuttavia, non è meno evidente che, alla lunga, questo stesso dualismo può trasformarsi in un germe di decomposizione... la proprietà fondiaria privata vi si è già insinuata sotto la forma di una casa con la sua corte rustica, che si può trasformare in una piazzaforte dalla quale si prepara l’assalto alla e contro la terra comunale. È un fatto al quale si è già assistito. Ma l’essenziale è il lavoro particellare come fonte di accumulazione privata; lavoro che dà luogo all’accumulazione di beni mobili come il bestiame, il denaro e, a volte, persino schiavi o servi... Ma significa ciò che la parabola storica della comune agricola debba fatalmente giungere a questo sbocco? Nient’affatto. Il dualismo ad essa intrinseco ammette un’alternativa: o il suo elemento di proprietà privata prevale sul suo elemento collettivo, o questo s’impone a quello. Tutto dipende dall’ambiente storico nel quale essa si trova… Le due soluzioni sono, di per sé, entrambe possibili»37.
Una quinta parziale e profondamente deformata traccia della “linea rossa” si ritrova nella riproduzione plurimillenaria delle manifatture e miniere statali. Se con il termine manifattura si indica la produzione combinata in un medesimo luogo fisico, in assenza di macchine utensili collegate a una forza motrice naturale, di oggetti di consumo e/o di strumenti di lavoro da parte di gruppi più o meno consistenti di lavoratori con diversi livelli di divisione sociale del lavoro al proprio interno, il carattere intrinsecamente collettivo di una siffatta produzione ne ha consentito anche l’appropriazione pubblica. Sono state proprio le manifatture statali ad attestare storicamente come la privatizzazione dei mezzi di produzione e del surplus non sia assolutamente collegata in modo “genetico” ed inevitabile ad un processo produttivo combinato, provando con la loro stessa esistenza che l’imprenditore privato è una figura sostituibile nel governo delle forze produttive materiali e sociali. Una prima rudimentale forma di manifattura pubblica si era già sviluppata al tempo della teocrazia sumera nel “tempio” che adottava nel campo della filatura e tessitura della lana e della molitura dei cereali il metodo organizzativo della concentrazione di centinaia di lavoratori in laboratori destinati ad una produzione cooperativa38; ma si possono anche ricordare gli opifici militari dei romani, le grandi manifatture tessili e gli zuccherifici egiziani dell’alto medioevo islamico, l’Arsenale di Venezia (in cui lavoravano ventimila addetti al momento del suo massimo fulgore), le manifatture pubbliche francesi del Cinquecento-Settecento oppure le fabbriche metallurgiche russe del ’700, la cui forza-lavoro era composta in prevalenza da servi della gleba.
La sesta traccia si è manifestata nei processi di cooperazione produttivo-distributiva verificatisi in Europa occidentale e Stati Uniti durante il XIX e XX secolo. Dopo lo scoppio della Rivoluzione industriale, il carattere sociale assunto dalle forze produttive con l’introduzione delle macchine ha fatto riemergere la “linea rossa” all’interno delle più avanzate metropoli capitalistiche, sebbene in forma deformata ed in posizione nettamente subordinata rispetto all’egemonia complessivamente detenuta dai rapporti di produzione classisti: la cooperazione ha infatti dimostrato praticamente e fin dalla prima metà dell’Ottocento (i “probi pionieri di Rochdale”) che «tanto il mercante quanto il fabbricante sono persone delle quali si può benissimo fare a meno»39 in una organizzazione solidaristica d’imprese di consumo e di produzione. Pur tenendo conto dell’adozione da parte del sistema cooperativo di logiche e pratiche di chiara matrice capitalistica, non si può non rilevare che all’inizio del terzo millennio l’International Cooperative Alliance rappresenta circa 750.000 cooperative di consumo e di produzione attive in cento stati con un numero totale di associati superiore ai 730 milioni di persone40.
Ma, settima traccia, l’esigenza oggettiva di una parziale e deformata socializzazione delle forze produttive si è imposta nelle stesse società capitalistiche, superando la resistenza di ampie frazioni della borghesia, con la statalizzazione dei mezzi di produzione. Come aveva notato Engels fin dal 1878, è la natura sociale del modo capitalistico di produzione che obbliga «la stessa classe capitalistica a trattare sempre più come sociali queste forze produttive nella misura in cui è possibile, in generale, sul piano dei rapporti capitalistici... Una cosa è certa: che il rappresentante ufficiale della società capitalistica, lo Stato, deve alla fine assumerne la direzione. La necessità della trasformazione in proprietà statale si manifesta anzitutto nei grandi organismi di comunicazione: poste, telegrafi, ferrovie... (Ma) lo Stato moderno, qualunque ne sia la forma, è una macchina essenzialmente capitalistica, uno Stato dei capitalisti, il capitalista collettivo ideale. Quanto più si appropria le forze produttive, tanto più diventa un capitalista collettivo, tanto maggiore è il numero dei cittadini che esso sfrutta. Gli operai rimangono dei salariati, dei proletari. Il rapporto capitalistico non viene soppresso, viene invece spinto al suo apice»41.
L’ultima traccia della “linea rossa” apparsa in epoca contemporanea è rappresentata dall’esperienza storica della formazione economico-statale sovietica convissuta per sette decenni a fianco del mondo capitalistico. Questo “socialismo deformato”, soprattutto per il primato dell’industria pesante e delle spese militari, ha espresso nel suo carattere contraddittorio sia le luci che le ombre dei rapporti “sovietici” di produzione. Se il suo nucleo originale positivo era costituito dalla proprietà collettiva (socializzazione o nazionalizzazione nel settore statale e cooperativo) dei beni-capitali, dall’assenza di processi di compravendita e di trasmissione ereditaria delle merci, dalla pianificazione parziale del processo produttivo globale, dai prezzi “politici” di molti generi alimentari, affitti e trasporti pubblici, dall’inesistenza di disoccupazione, dall’orario lavorativo ridotto, da una età pensionabile non elevata (55 anni per le donne, negli anni Ottanta) e da ritmi lavorativi molto meno intensi di quelli capitalistici, la sua “linea nera” è stata costituita soprattutto dagli elementi illegali del capitalismo di stato (fenomeni relativamente diffusi di corruzione e arricchimento illecito da parte della nomenklatura di partito e dei manager di stato), dallo sviluppo progressivo delle disuguaglianze sociali extra-legali e “sommerse”, e dal primato attribuito, ininterrottamente dal 1928 in poi, alla produzione di mezzi di produzione ed armamenti a scapito dei beni di consumo, da cui la relativa penuria di merci che ha condotto all’insoddisfazione crescente delle masse popolari.
5. Conclusione
Un veloce excursus attorno a sei millenni di storia ci porta pertanto a concludere che anche nel periodo successivo al 3900 a.C. l’effetto di sdoppiamento ha continuato ad esercitare la propria azione storica, sebbene la “linea nera” sia riuscita a prevalere su quella collettivistica costringendola forzatamente in una posizione subordinata/deformata oppure a sopravvivere in stato latente anche grazie al controllo (quasi) costante esercitato sugli apparati ideologici e statali.
La seconda conclusione che si può trarre è che tra i due litiganti il “terzo incomodo”, cioè la sfera politico-statale, ha costantemente svolto il ruolo decisivo. La coesistenza/opposizione tra la “linea rossa” e la “linea nera” ha prodotto il primato della lotta politica tesa al mantenimento di rapporti di produzione classisti oppure alla loro sostituzione con rapporti di produzione collettivistici, come durante l’esperienza sovietica dal 1917 al 1990. Sono quindi i concreti rapporti di forza politico-militari ad aver fatto la differenza tra le “due linee”, provocando storicamente la prevalenza di rapporti di produzione classisti (asiatici, schiavisti, feudali e capitalisti) che si sono imposti coercitivamente perchè fondati sull’utilizzo/minaccia dell’uso della forza da parte delle classi privilegiate, esercitata di regola attraverso i loro mandatari politici e gli apparati statali da esse controllati direttamente o indirettamente.
L’esperienza della Cina “rossa” rappresenta al giorno d’oggi la migliore conferma di questo “effetto di sdoppiamento”. Dal 1928 fino al 1948 si erano formate delle “basi rosse” controllate dal partito comunista che avevano al proprio interno elementi collettivisti antagonistici rispetto ai rapporti di produzione capitalistici e semifeudali del resto del paese. Dal 1949 al 1976 l’egemonia assicurata dalla ”linea rossa” di Mao Zedong si è mantenuta politicamente, nonostante la presenza di rapporti di produzione capitalistici in parti geopolitiche marginali, come a Taiwan, Hong Kong e Macao. Dal 1976-77 e fino ai giorni nostri una subordinata “linea nera” di matrice capitalistica ha ripreso vigore, seppure sovrastata dalla supremazia di relazioni di produzione collettivistiche statali o cooperative. E così, mentre la proprietà del suolo, delle risorse naturali e (in stragrande maggioranza) del settore bancario è rimasta pubblica, il settore statale e cooperativo è stato affiancato da una sfera produttiva privata posta sotto il possesso-controllo di capitalisti nazionale e di multinazionali straniere. Questa diffusione del settore privato è stata il sottoprodotto della opzione politica generale, espressa dai nuclei dirigenti del PCC, che finora hanno impedito “privatizzazioni selvagge” dei mezzi di produzione con dinamiche simili a quelle verificatisi nella Russia post-sovietica, a conferma (se mai ce ne fosse ancora bisogno) della centralità della sfera politica nella lotta più o meno manifesta tra le due alternative di sviluppo tuttora presenti a livello dei rapporti sociali di produzione (la “linea rossa” e la “linea nera”) uscite dal “Grande Evento” della rivoluzione neolitica.
Capitolo terzo
La roulette della storia
1. Critica delle critiche
Contro la teoria dell’“effetto di sdoppiamento” si potrebbe però muovere l’obiezione che quell’effetto potrebbe esistere da sempre – e quindi durare per sempre. Non è vero. L’“effetto di sdoppiamento” ha preso ad agire nella storia solo dopo il 9000 a.C. quando, a seguito della “rivoluzione agricola” da un lato e della domesticazione degli animali dall’altro, ci si è assicurati la produzione sistematica e costante di un surplus accumulabile anche in forma privata, e non soltanto comunitaria, ed esso scomparirà in quella fase superiore della produzione sociale, da Marx denominata “comunismo”, in cui «con lo sviluppo omnilaterale degli individui saranno cresciute anche le forze produttive e tutte le sorgenti della ricchezza collettiva scorreranno in tutta la loro pienezza... e la società potrà scrivere sulle sue bandiere: Ognuno secondo le sue capacità; a ognuno secondo i suoi bisogni!»42. Questo risultato ultimativo, consentendo la piena soddisfazione dei bisogni sociali del genere umano (consumi, tempo libero, cultura e attività ludiche), disseccherà, almeno a livello di massa, la principale fonte d’alimentazione della “linea nera”, ossia la pretesa di gruppo di un’appropriazione “elitaria” di mezzi di produzione, beni di consumo e tempo libero (a meno che il genere umano non si autodistrugga in precedenza per l’impiego delle mostruose armi di sterminio attualmente a disposizione).
Ma su quali basi concrete si fonda la permanenza della “linea rossa”? Essa si basa su tre elementi materiali, combinati tra loro, che sono oggettivi (esistono già nei fatti) e continuano a riprodursi almeno come potenzialità. Essi sono dati dalla produzione di un sovrappiù sociale costante che autorizza la possibilità di avviare processi di una sua appropriazione collettiva, e poi dal fatto che gli oggetti principali del lavoro sociale umano, dalla terra all’acqua e alle conquiste della scienza/tecnologia, sono sempre stati appropriabili anche per scopi cooperativi sia nelle manifatture/industrie che in altre attività produttive combinate; nonché per la presenza della volontà e pratica dei milioni di donne e uomini rossi che storicamente si sono orientati a sostegno della formazione e riproduzione dei rapporti di produzione collettivistici.
Anche la “linea nera” costituisce il sottoprodotto della combinazione storica di quella stessa premessa materiale perchè, senza la riproduzione costante di un surplus accumulabile a partire dal Grande Evento del Neolitico, non si sarebbe potuta manifestare alcuna appropriazione privata dei mezzi di produzione, né la redistribuzione del prodotto sociale da parte delle chefferies classiste avrebbe potuto consentirne la destinazione a vantaggio di una ristretta minoranza di individui. A seguito del “colpo” vittorioso alla “roulette della storia”, i gruppi privilegiati sul piano socio-politico hanno potuto astenersi (in parte, se non addirittura completamente) dalla partecipazione diretta-indiretta alla fatica del produrre manifestando la prima forma storica di rifiuto collettivo del lavoro, mentre allo stesso tempo sono stati in grado di guadagnare livelli di consumo molto più elevati rispetto alla massa della popolazione, un miglior status sociale e una posizione privilegiata nella scelta sessuale-riproduttiva, oltre a disporre del potere politico e dei mezzi repressivi di controllo.
Una critica più probante potrebbe essere invece così argomentata: solo la “linea nera”, e quindi solo i rapporti di produzione classisti, sono stati in grado di promuovere lo sviluppo delle forze produttive sociali, condizione indispensabile per il processo di liberazione dalla penuria del genere umano e per l’abolizione finale delle differenze di classe. A ragionare così, la vittoria storica della “linea nera” su scala mondiale avrebbe avuto un carattere progressista, al pari della progressiva sconfitta-scomparsa dei rapporti di produzione collettivistici sostenuti dalla “linea rossa”. Detto altrimenti, se mai la futura formazione economico-sociale comunista potesse concretizzarsi, essa avrebbe pur sempre un debito di riconoscenza per la sua nascita verso quelle società classiste che l’hanno preceduta storicamente e che hanno svolto inconsapevolmente il ruolo essenziale di sviluppo delle forze produttive sociali, sia pure infliggendo lacrime, sudore e sangue per millenni e su scala mondiale alle masse popolari.
In effetti sono numerosi testi di Marx ed Engels in cui si sostiene senza esitazione la tesi del carattere progressivo, almeno in ultima istanza, dei rapporti di produzione basati sull’appropriazione privata dei mezzi di produzione e del sovrappiù sociale e nell’AntiDühring Engels ha portato fino alle logiche conseguenze questa tesi sostenendo che i rapporti di produzione collettivistici non sarebbero assolutamente adatti ad assicurare il necessario sviluppo delle forze produttive sociali, mentre i rapporti di produzione classisti, che invece ne sono stati capaci, hanno svolto l’essenziale compito storico di creare le premesse per il futuro successo della formazione economico-sociale comunista. Ora, se Marx ed Engels avevano sicuramente ragione nel portare l’attenzione sulla centralità dello sviluppo delle forze produttive quale supporto indispensabile per la crescita costante del livello di soddisfazione dei bisogni dell’umanità, essi però sbagliavano nell’individuare nei rapporti di produzione classisti il “campione” (volontario-involontario) del processo di liberazione del genere umano.
Intanto va detto che sono stati i rapporti di produzione collettivistici ad accompagnare all’origine la nostra specie nella lunga e difficile dinamica storica che l’ha trasformata da una massa di ominidi alla dimensione attuale. Questa auto-trasformazione progressiva si è realizzata dentro le società collettivistiche del paleolitico mediante una serie di conquiste che vanno dalla lavorazione/percussione di pietra ed ossa alla conservazione e produzione artificiale del fuoco, dalla costruzione di abitazioni in legno alla fabbricazione dei vestiti. Nell’ultima fase del paleolitico sono stati inventati anche l’arco e le frecce, si sono scoperte le diverse tecniche di sepoltura dei morti e l’arte di costruire cesti, vasellami e pitture rupestri (come nelle grotte di Altamira e Lascaux). Si sono già ricordati anche i grandi risultati ottenuti dalle formazioni collettivistiche del neolitico-calcolitico, partendo dalla punta avanzata di Gerico fino ad arrivare alla civiltà Ubaid, con la creazione dell’agricoltura e dell’allevamento, della tessitura e della metallurgia, dell’arte dell’irrigazione e della produzione in ceramica. Più in generale il successo delle formazioni economico-sociali collettivistiche, allora le uniche presenti, trova conferma nella crescita indiscutibile della popolazione mondiale che, secondo stime prudenti, sarebbe passata dai circa 6 milioni del 10000 a.C. ai 60 milioni del 4000 a.C.
Insomma, tutti i dati empirici suggeriscono l’idea che i rapporti di produzione comunitari sono stati perfettamente compatibili con una serie di salti di qualità tecnologico-economici realizzati nell’arco di millenni dalle forze produttive sociali, indicando nella cooperazione del processo di produzione e nell’egualitarismo delle relazioni sociali il supporto e la base sociale indispensabile. Soltanto dopo il 3900 a.C. queste avanzate strutture collettivistiche sono state via via sopraffatte dalle ondate migratorie dei più arretrati popoli nomadi protoclassisti, ma che disponevano della formidabile arma da guerra del cavallo, impedendo così di verificare se sarebbero state ancora in grado di favorire un ulteriore sviluppo della civiltà. Se tuttavia passiamo a considerare le presunte grandi prestazioni produttive espresse dai rapporti di produzione classisti dopo aver raggiunto l’egemonia economico-sociale, incontriamo una notevole sorpresa.
2. Il mancato progresso economico della “linea nera”
Considerando storicamente l’intero periodo che va dal 3700 a.C. fino al 1680 d.C., e quindi più di cinque millenni di storia, risulta evidente una semi-stagnazione del livello di sviluppo delle forze produttive “civili” rispetto al punto di partenza raggiunto nell’epoca tardo-Ubaid. Inoltre le formazioni economico–sociali classiste si sono dimostrate incapaci di utilizzare efficacemente e su larga scala le invenzioni e le scoperte scientifico-tecnologiche che pure venivano in esistenza, ma che avrebbero potuto sconvolgere le fondamenta dei modi di produzione di classe. Lo storico economico Carlo Maria Cipolla riporta il giudizio sorprendente dello studioso di tecnologia S. Lilley: «la prima grande rivoluzione tecnologica cominciò con l’avvento dell’agricoltura attorno all’8000 a.C. Ci diede tutte le tecniche di base dell’agricoltura, inclusa l’irrigazione. Creò le manifatture tessile, metallurgica e ceramica e la tecnica di fermentazione sia per il pane che per la birra. Nel settore dei trasporti portò alla costruzione della nave a vela e del carro a ruote, oltre ad insegnarci come attraccare animali da traino dal carro e all’aratro. Sviluppò l’organizzazione del lavoro al punto da rendere possibile la costruzione delle piramidi. Ma intorno al 2500 a.C. lo sviluppo tecnologico venne praticamente a un punto di stallo, e nel corso dei tremila anni successivi vi fu relativamente poco progresso ulteriore. La metallurgia del ferro sviluppatasi attorno al 1400 a.C. fu di notevole importanza. I Greci innovarono qualcosa nell’applicazione dell’energia animale... Qualche altro meccanismo, come ingranaggi, viti e camme datano dall’età classica. Ma, insomma, quando raffrontati alla rivoluzione che li precedette, questi trenta secoli tra il 2500 a.C. e il 500 d.C. rappresentano un periodo di ristagno tecnologico»43.
Passiamo al 1680 d.C.: sebbene l’Olanda e la Gran Bretagna fossero allora sicuramente le punte avanzate del processo produttivo mondiale in termini di qualità di sviluppo delle forze produttive sociali (sotto l’aspetto quantitativo la Cina, negli stessi anni, le superava di gran lunga), le due nazioni europee avevano superato di poco i risultati tecnologici, produttivi ed economici raggiunti più di cinque millenni prima, nonostante l’enormità di tempo avuto a disposizione e la quantità di forza lavoro semplice e qualificata erogata nel frattempo. Un deciso sorpasso qualitativo era avvenuto soltanto nel settore dei mezzi di distruzione: bronzo, ferro e acciaio, polvere da sparo, fucili e cannoni, navi con artiglieria a bordo ecc., e poi nei mulini ad acqua e a vento, nella stampa e nella carta, nella bussola, negli aratri in ferro, nella scrittura, negli orologi (ad acqua, meccanici, ecc.), nelle lenti, nella ruota, nell’uso del carbone e nella pompa a catena44. Ma proprio questi notevolissimi e indiscutibili risultati raggiunti nel campo militar-tecnologico fanno ancor più risaltare la relativa modestia delle prestazioni espresse invece nel settore produttivo civile, al punto che le fonti principali di energia motrice restavano gli uomini e gli animali (i mulini ad acqua e a vento erano confinati in aree limitate). Se ne può dedurre che le formazioni economico-sociali classiste che si sono succedute fino al 1760 a.C. non sono riuscite a creare una propria significativa rivoluzione tenologico-produttiva, a prova che il processo di sviluppo delle forze produttive sociali non è stato certamente agevolato dall’egemonia delle strutture di classe.
Ma verifichiamolo in dettaglio, a partire dal modo di produzione asiatico che si sa aver costituito quasi sempre una forza statica e conservatrice per quanto riguarda lo sviluppo delle forze produttive. Questa stagnazione sostanziale, che non escludeva progressi tecnologici limitati in alcuni segmenti della produzione complessiva, è stata una delle costanti fondamentali della sua lunga esistenza storica in un’area geografica estesa dall’India alla Cina all’Egitto: l’oppressione costantemente esercitata da una ristretta minoranza sulle comunità contadine semi-collettivistiche ha bloccato per millenni sia lo sviluppo qualitativo del processo produttivo che l’applicazione su larga scala delle nuove conoscenze tecnico-scientifiche scoperte autonomamente o importate dall’esterno.
La prestazione produttiva del modo di produzione schiavistico è stata, se possibile, ancora più penosa e insoddisfacente, come dimostra l’esperienza storica della sua forma più avanzata e significativa: quella romana. I rapporti di produzione schiavili minavano infatti inesorabilmente la principale forza produttiva, quell’uomo-schiavo che non si riproduceva biologicamente nemmeno in quantità sufficiente a ricostituire, generazione dopo generazione, la forza-lavoro necessaria alla produzione, così che l’economia schiavistica poteva sostenersi solo attraverso un continuo afflusso di manodopera presa dall’esterno mediante le guerre di conquista o il commercio di “pelle umana”. Tutti i dati storici dimostrano in modo inequivocabile che nell’impero romano, all’inizio del secondo secolo d.C., gli schiavi erano divenuti insufficienti a coprire le necessità produttive, mentre nel terzo secolo il prezzo della manodopera schiavile era più che raddoppiato rispetto a quello di alcuni decenni prima45.
Per quanto riguarda il modo di produzione feudale, imperniato sulla dipendenza permanente dei servi della gleba all’aristocrazia fondiaria, gli stessi storici borghesi hanno documentato con dovizia di particolari la sostanziale inoperosità dei grandi (e piccoli) feudatari e la loro quasi totale indifferenza per le necessità della produzione, soffermandosi sulla predisposizione “genetica” dell’aristocrazia medioevale allo spreco e al consumo improduttivo del surplus estorto ai lavoratori della terra. E se di recente alcuni ricercatori hanno rivalutato parzialmente il ruolo storico-produttivo giocato dalle strutture feudali affermando che «prima della crescita moderna l’epoca più dinamica nella società e nell’economia europea fu proprio quella feudale»46 se non altro perchè i servi della gleba avevano un diretto interesse economico (oltre che affettivo) alla procreazione dei figli per sostenere l’attività agricola nelle terre delle proprie famiglie o comunità rurali, una volta superata una certa soglia critica tale spinta propulsiva iniziale ha però mostrato alla lunga un esaurimento abbastanza brusco, soprattutto per il carattere oppressivo, parassitario e improduttivo dell’aristocrazia fondiaria47.
Sorprendentemente delle considerazioni quasi analoghe possono essere rivolte anche alla lunga fase manifatturiera del modo di produzione capitalistico che è durata almeno sette secoli (dal 1050 al 1750). Se il modo di produzione capitalistico rappresenta la formazione economico-sociale in cui la “merce numero uno” è rappresentata dalla forza-lavoro salariata non più vincolata da rapporti di schiavitù o servitù, la sua prima ossatura tenologico-produttiva è stata rappresentata dalla manifattura (e in via subordinata dalla “produzione a domicilio” controllata da gruppi ristretti di imprenditori-commercianti) i cui elementi, a detta dello storico Maurice Dobb, «che troviamo in Inghilterra nel periodo di Elisabetta e degli Stuart appaiono già maturi in epoca assai più antica nei Paesi Bassi e in alcune città italiane»48. In Italia, già dopo il Mille in repubbliche marinare come Amalfi e Venezia sono consolidati settori significativi di capitalismo commerciale e manifatturiero con cantieri navali abbastanza avanzati sul piano tecnologico. Una seconda e più estesa zona manifatturiera si sviluppò nel XIII-XIV secolo all’interno delle città fiamminghe con la precoce formazione di una massa di proto-proletari diseredati e senza terra, accompagnata alla diffusione parallela della figura del mercante-manifatturiero a capo di un capillare «sistema di industria capitalistica a domicilio dove l’organizzatore capitalista distribuiva il lavoro ad artigiani subordinati»49. Un terzo polo economico ad egemonia manifatturiera è stato costituito dall’Italia del centro-nord del XIV secolo con la punta di diamante fiorentina: «a Firenze, nel 1338, si diceva vi fossero ben 200 officine per la manifattura del panno, che impiegavano un totale di 30.000 lavoratori, pari a un quarto della popolazione attiva della città»50, mentre grandi manifatture tessili e belliche esistevano anche a Milano, Bologna e in diverse altre città italiane. Infine nella Francia del ’500 «nelle industrie più recenti, come quelle del vetro, della seta, della carta, della stampa, troviamo molto presto imprese di tipo capitalistico come in Inghilterra»51.
Eppure, come nota ancora Dobb, «il tratto più notevole dello svolgimento italiano, tedesco e olandese (e in minor misura, francese) non consiste tanto nella precoce apparizione, in confronto all’Inghilterra, della produzione capitalistica, quanto nel fatto che il nuovo sistema non riuscì a progredire molto al di là della sua precoce e promettente adolescenza. Sembrerebbe anzi che proprio il successo e la maturità raggiunti dal capitale commerciale e usuraio in questi fiorenti centri di scambio abbiano ritardato, anziché favorito, lo sviluppo dell’investimento capitalistico nella produzione, che il capitale industriale, di fronte agli splendori del saccheggio del Levante e delle Indie e del prestito usuraio ai principi, rimanesse sempre nella posizione di un fratello cadetto, senza doti di natura e di fortuna. In ogni caso è chiaro che anche un maturo sviluppo del capitale commerciale e finanziario non è di per se stesso garanzia dello sviluppo, nella sua scia, della produzione capitalistica; anche quando alcuni gruppi del capitale commerciale si sono rivolti all’industria e hanno cominciato a subordinarsi e a trasformare il modo di produzione, ciò non sbocca tuttavia necessariamente in una trasformazione completa»52.
Per uscire da quel “vicolo cieco” produttivo perdurato per ben sette secoli era necessaria una combinazione eccezionale di fattori estremamente favorevoli quale si è prodotta concretamente in Gran Bretagna nel XVIII secolo.
3. Il capitalismo,“fase suprema” delle società di classe
Dal 1750 al 1830 la Gran Bretagna ha costituito il punto di convergenza storico per quel salto di qualità sia produttivo che tecnologico conosciuto sotto il nome di Rivoluzione Industriale: una straordinaria sovrabbondanza di domanda solvibile di prodotti manifatturieri ha stimolato in maniera decisiva l’innovazione tecnica nel campo tessile, siderurgico e minerario, dando origine ad un “circolo virtuoso” che poi si è autoalimentato a spirale. Ma, dopo avere provocato e sostenuto un reale e formidabile ritmo di accelerazione del progresso delle forze produttive del lavoro sociale fino al 1872, le relazioni di proprietà e di distribuzione del modo capitalistico di produzione si sono rapidamente trasformate anch’esse in un ostacolo al processo di sviluppo. Se fino al 1872 il lato progressivo del sistema capitalistico ha prevalso nettamente sulle sue tendenze autodistruttive (recessioni e crisi, caduta del saggio di profitto, ruolo crescente della rendita fondiaria, colonialismo e guerre), successivamente esso è entrato in quella fase d’imperialismo (che dura tuttora) in cui, a seguito della formazione dei monopoli industriali e del predominio del capitale finanziario, «monopoli, oligarchia, tendenza al dominio anziché alla libertà, sfruttamento di un numero sempre maggiore di nazioni piccole e deboli per opera di un ristretto gruppo di nazioni più ricche o potenti... ne fanno un capitalismo parassitario e putrescente: .. (Ovviamente) sarebbe erroneo credere che tale tendenza alla putrescenza escluda il rapido incremento del capitalismo: tutt’altro. Nell’età dell’imperialismo i singoli rami dell’industria, i singoli strati della borghesia, i singoli paesi palesano, con forza maggiore o minore, ora l’una ora l’altra di quelle tendenze. In complesso il capitalismo cresce assai più rapidamente di prima, sennonché tale incremento non solo diviene in generale più sperequato, ma tale sperequazione si manifesta particolarmente nell’imputridimento dei paesi capitalisticamente più forti»53. Inoltre, dopo Hiroshima e Nagasaki i rapporti capitalistici di produzione tendono ad assumere anche un carattere genocida nei confronti del genere umano attraverso l’azione combinata di strumenti quali le armi di distruzione di massa, lo sterminio per fame nel Terzo Mondo e la crisi ecologica ed energetica..
Ma in che senso si può dire che dalla fine dell’Ottocento il modo di produzione capitalistico è giunto al termine della sua parabola storica? Nel senso che, a giudizio di Marx ed Engels, il livello raggiunto di sviluppo delle forze produttive e dei mezzi di produzione usciti dalla rivoluzione industriale potrebbe permettere la ricostruzione (e la riproduzione) di rapporti di produzione socialisti (come prima fase della successiva società comunista) in alcuni stati decisivi dell’Europa occidentale e nell’America settentrionale. Nella prefazione a Per la critica dell’economia politica (1857) Marx ha condensato efficacemente la sua tesi fondamentale secondo la quale «ad un certo grado del loro sviluppo le forze produttive materiali della società entrano in contraddizione con i rapporti di produzione esistenti o, per usare un termine giuridico, con i rapporti di proprietà nel cui ambito si erano mosse fino a quel momento. Da che erano forme di sviluppo delle forze produttive, questi rapporti si tramutano in vincoli che frenano tali forze. Si arriva quindi ad un’epoca di rivoluzione sociale»54. Se la forza fondamentale dei processi di cambiamento economico-sociali più radicali è costituita dalla contraddizione esistente tra le forze produttive ed i rapporti di produzione/ distribuzione e proprietà, quando viene superata una soglia critica di sviluppo le forze produttive, che devono crescere, entrano in rotta di collisione con i vecchi e antiquati rapporti di produzione/proprietà che ostacolano permanentemente o addirittura impediscono la riproduzione allargata della massa di strumenti di produzione, degli oggetti di lavoro e delle capacità tecnico-produttive della forza-lavoro sociale. A questo punto deve subentrare un periodo di rivoluzione sociale che, sebbene con esito non scontato a priori, risulta necessario e inevitabile per modificare il peso specifico e la stessa natura dei rapporti di produzione/distribuzione e proprietà tra le diverse classi sociali.
E’ nelle crisi economiche che il modo di produzione capitalistico esprime nella maniera più visibile e violenta la contraddizione delle forze produttive materiali con i rapporti di produzione sociali, da cui si esce ogni volta con il deprezzamento dell’apparato di capitale esistente. Infatti «nelle crisi commerciali viene regolarmente distrutta una gran parte non solo dei prodotti già ottenuti, ma anche delle forze produttive che erano già state create. Nelle crisi scoppia un’epidemia sociale che in ogni altra epoca sarebbe apparsa un controsenso: l’epidemia della sovrapproduzione. La società si trova all’improvviso ricacciata in uno stato di momentanea barbarie; una carestia, una guerra generale di sterminio sembrano averle tolto tutti i mezzi di sussistenza; l’industria, il commercio sembrano annientati, e perché? Perché la società possiede troppa civiltà, troppi mezzi di sussistenza, troppa industria, troppo commercio»55. Non a caso nel terzo libro del Capitale Marx afferma che «il vero limite della produzione capitalistica è il capitale stesso»56, che sono i rapporti di produzione capitalistici ad ostacolare l’ulteriore produzione della ricchezza, invece di promuoverla. Essi sono «diventati troppo angusti per contenere le ricchezze da essi prodotte. Con quale mezzo riesce la borghesia a superare le crisi? Per un verso, distruggendo forzatamente una grande quantità di forze produttive; per un altro verso, conquistando nuovi mercati e sfruttando più intensamente i mercati già esistenti. Con quale mezzo dunque? Preparando crisi più estese e più violente e riducendo i mezzi per prevenire le crisi»57.
L’esperienza storica di due secoli di crisi economiche capitalistiche, dalla prima del 1825 a quelle del 1846/47, del 1873, del 1929 e del 1973 ne dimostra a sufficienza la ricorrenza periodica e la gravità. Ciononostante i rapporti di produzione basati sullo sfruttamento della forza-lavoro salariata e sulla proprietà privata dei mezzi di produzione hanno continuato a riprodursi in Europa e negli Stati Uniti senza soluzione di continuità, sebbene per Marx ed Engels non fossero più corrispondenti al livello di sviluppo ormai raggiunto dalle forze produttive ed i nuovi e più avanzati rapporti di produzione collettivistici, che potrebbero efficacemente sostituirli, non si sono affermati in Occidente. Come si può giustificare questa contraddizione? Col fatto che, se pur il modo capitalistico di produzione mantiene, come qualsiasi altra formazione economico-sociale di classe, un campo di possibilità alternative che ne permetterebbero materialmente la sostituzione con un modo di produzione “comunista” (almeno nella prima fase inferiore “socialista”), i rapporti di forza politici, in primo luogo quelli politico-militari, a suo favore ne hanno determinato lungo l’intero periodo 1875-2010 la persistenza continua.
4. Forze produttive e “rapporti di forza”
Per Marx ed Engels le crisi economiche, da cui segue il deprezzamento su larga scala del capitale costante investito in mezzi di produzione ed oggetti di lavoro, dovrebbero spianare la strada ad una nuova fase di sviluppo economico-sociale ponendo termine alla “sovrabbondanza” dei capitali e alla “penuria” dei profitti presenti fino al rovesciamento della congiuntura favorevole precedente. Eppure si potrebbe quasi affermare per paradosso che una delle “leggi” dei processi rivoluzionari consista nel non-verificarsi mai nei periodi di crisi economica! Intanto le depressioni economiche più gravi del 1846-48 e del 1873-77, del 1929-33 e del 1973-75 non hanno mai determinato rivoluzioni vittoriose o, almeno, tentativi rivoluzionari, sebbene sconfitti, di sufficiente consistenza, ma poi nel Novecento le rivoluzioni che hanno trionfato per un periodo più duraturo di tempo non hanno mai vinto per la “maturità” delle forze produttive e per l’alto grado di contraddizione con i rapporti di produzione, bensì piuttosto per la superiorità della forza politico-militare delle classi oppresse sfondando lungo le linee di minore resistenza (come in Russia o in Cina o a Cuba). A contrario, nei punti più avanzati dello sviluppo esse sono sempre state rigettate indietro (come in Italia nel 1922 o in Germania nel 1933) oppure contenute (negli Stati Uniti nel 1933, in Francia nel 1968 o in Italia nel 1969) dalla superiorità politico-militare delle forze sociopolitiche borghesi e dei loro apparati di dominio.
E’ ovvio che la contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione determina comunque delle ricadute in campo politico-sociale confermando almeno parzialmente la tesi marxiana (si pensi al livello del consenso popolare verso i ceti dirigenti oppure alla trasformazione “molecolare” e progressiva della composizione di classe, che nel lungo periodo rappresenta una condizione materiale importante per la possibile modifica dei rapporti di forza politici). Tuttavia resta innegabile che tra lo sviluppo delle forze produttive e la concreta dinamica politico-sociale s’interpone sempre il “terzo incomodo” dei rapporti di forza di volta in volta posti in essere tra le masse popolari e gli apparati statali della formazione economico-sociale capitalistica.
Se Marx ed Engels non hanno scoperto l’esistenza delle classi sociali ed il loro antagonismo reciproco (già noti in precedenza), essi hanno però fornito la chiave per interpretare lo scontro ininterrotto tra i gruppi sociali divisi da un diverso rapporto con i mezzi di produzione e con il surplus sociale rapportandolo al livello di sviluppo delle forze produttive sociali. Al proposito essi hanno distinto la lotta economica (solo indirettamente politica) dal conflitto politico di classe volto ad influenzare o conquistare il potere politico e gli apparati statali, separando anche la lotta di classe difensiva dall’accumulazione di forze per lo scontro finalizzato a scopo rivoluzionario. Degna di nota è la descrizione che essi hanno dato dei diversi livelli di lotta per cui è passato il proletariato moderno a partire dall’inizio della rivoluzione industriale e fino alla meta del XIX secolo. «Dapprima lottano i singoli operai ad un ad uno, poi gli operai di una fabbrica, indi quelli di una categoria in un dato luogo contro il singolo borghese che li sfrutta direttamente. Essi non rivolgono soltanto i loro attacchi contro i rapporti borghesi di produzione, ma li rivolgono contro gli stessi strumenti della produzione; essi distruggono le merci straniere che fanno loro concorrenza, fanno a pezzi le macchine, incendiano le fabbriche, tentano di riacquistare la tramontata posizione dell’operaio del medioevo... Ma con lo sviluppo dell’industria il proletariato non cresce soltanto di numero; esso si addensa in grandi masse, la sua forza va crescendo, e con la forza la coscienza di essa. Gli interessi, le condizioni di esistenza all’interno del proletariato si livellano sempre più, perchè la macchina cancella sempre più le differenze del lavoro e quasi dappertutto riduce il salario a un eguale basso livello... (Allora) i conflitti fra singoli operai e borghesi vanno sempre più assumendo il carattere di conflitti fra due classi. E’ così che gli operai incominciano a formare coalizioni contro i borghesi, riunendosi per difendere il loro salario. Essi fondano persino associazioni permanenti per approvvigionarsi per le sollevazioni eventuali. Qua e là la lotta diventa sommossa. Di quando in quando gli operai vincono, ma solo in modo effimero. Il vero risultato delle loro lotte non è il successo immediato, ma l’unione sempre più estesa degli operai agevolata dai crescenti mezzi di comunicazione che sono creati dalla grande industria e che collegano tra di loro operai di località diverse. Basta questo semplice collegamento per concentrare le molte lotte locali, aventi dappertutto egual carattere, in una lotta nazionale, in una lotta di classe. Ma ogni lotta di classe è lotta politica... (Certamente) questa organizzazione dei proletari in classe, e quindi in partito politico, viene ad ogni istante nuovamente spezzata dalla concorrenza che gli operai si fanno fra loro stessi. Ma essa risorge sempre di nuovo, più forte, più salda, più potente e, approfittando delle scissioni della borghesia, la costringe al riconoscimento legale di singoli interessi degli operai, come fu per la legge delle dieci ore di lavoro in Inghilterra»58.
C’è quindi un enorme spazio di manovra potenzialmente a disposizione dello scontro sociale e politico di classe. Marx nel Capitale ha focalizzato l’attenzione su alcuni casi specifici per dimostrare l’enorme grado di “elasticità” sia verso l’alto che verso il basso, ossia in senso migliorativo o peggiorativo, dei livelli concreti di soddisfazione dei bisogni materiali e politici via via ottenuti dai diversi gruppi sociali omogenei sul piano economico-produttivo. La durata della giornata lavorativa ha costituito il primo momento di focalizzazione teorica di questa tematica, essendo il modo di produzione capitalistico fondato sull’appropriazione privata di lavoro non pagato, di pluslavoro estorto dalla forza-lavoro salariata, da cui il “perenne impulso” del capitalista a prolungarlo oltre ogni limite. Ovviamente non si possono superare determinati limiti fisici, quali il riposo minino necessario al lavoratore per riprendere forza, ma il limite massimo è «di natura assai elastica e permette un larghissimo margine d’azione»59 essendosi date storicamente giornate lavorative di 8, 10, 12, 14 e anche 16 ore per sette, sei o cinque giorni alla settimana. 16 ore x 6 giorni fanno 96 ore alla settimana, 8 ore x 5 giorni sono invece 40 ore. La distanza oggettiva che esiste tra 96 ore e 40 ore lavorative settimanali non è di poco conto, ma nessuna “legge astratta” stabilisce a priori quale orario scegliere e solamente i rapporti di forza di fatto esistenti di volta in volta tra le classi sociali e con il potere statale vengono a fissare in un determinato periodo storico l’estensione effettiva della giornata lavorativa. In altre parole è lo stesso Marx a suggerire che un terzo incomodo extraeconomico deve intervenire per stabilire la lunghezza della giornata lavorativa “normale” della classe lavoratrice in una determinata formazione statale e in una data fase storica.
Un’elaborazione teorica analoga vale per Marx anche rispetto al livello dei salari e alla massa concreta di beni di sussistenza ottenuti o forniti ai lavoratori per la riproduzione della forza lavoro propria e dei loro figli, dato che evidentemente quanto minore risulta quella massa, tanto maggiore è il lavoro gratuito appropriato dai capitalisti. «“I salari, dice J. St. Mill, non hanno forza produttiva; sono il prezzo di una forza produttiva; i salari non contribuiscono alla produzione delle merci, assieme al lavoro, più che non contribuisca il prezzo delle macchine stesse. Se si potesse avere lavoro senza acquistarlo, i salari sarebbero superflui”. Ma se gli operai potessero vivere d’aria, non si potrebbero neanche comperare a nessun prezzo. La gratuità degli operai è dunque un limite in senso matematico, sempre irraggiungibile, benché sempre più approssimabile. Ed è tendenza costante del capitale di abbassare gli operai fino a questo punto nichilistico»60. Questa “tendenza nichilistica”, che si esprime nel tentativo costante di ridurre la massa di mezzi di sussistenza all’estremo limite indispensabile fisiologicamente ai lavoratori per riprodursi stentatamente ed in forma ristretta e ridotta, è il modello ideale di capitalismo che ancor oggi si manifesta nelle fabbriche del sudest asiatico, dove la manodopera è pagata pochissimo e costretta a turni di lavoro particolarmente lunghi. Ma sono stati, sono e saranno i rapporti di forza materiali tra le classi sociali a determinare se si afferma la “tendenza nichilista” del capitalismo oppure la controtendenza dei lavoratori ad alzare, fino al massimo grado al momento ritenuto possibile, la quantità e qualità dei beni di consumo che essi possono procurarsi dalla vendita della forza-lavoro.
Salendo ancor più di livello, giuste le indicazioni marxiane, risulta che il principale obiettivo del “grande campo di gioco” consiste nella stessa continuazione o fine della riproduzione del possesso privato dei mezzi di produzione e del surplus da parte dei capitalisti. Anche in questo caso sono i rapporti di forza politico-sociale esistenti tra le classi sociali a sciogliere con la praxis l’enigma del risultato finale di questa “partita” giocata su scala planetaria. Marx ne è così consapevole da elaborare con chiarezza un altro e più diretto contributo alla teoria generale dello scontro di classe. Si è già detto di quello che ha per oggetto la durata della giornata di lavoro, ma quale fattore fa la differenza e decide nei fatti? «E’ evidente: astrazion fatta da limiti del tutto elastici, dalla natura dello scambio delle merci, così com’è, non risulta nessun limite della giornata lavorativa, quindi nessun limite del pluslavoro. Il capitalista, cercando di rendere più lunga possibile la giornata lavorativa, sostiene il suo diritto di compratore... mentre l’operaio, volendo limitare la giornata lavorativa ad una grandezza normale determinata, sostiene il suo diritto di venditore. Qui ha dunque luogo una antinomia: diritto contro diritto, entrambi consacrati dalla legge dello scambio delle merci. E fra diritti eguali decide la forza»61.
Abbiamo letto bene: tra uguali diritti decide la forza. Per Marx la forza, o meglio i rapporti di forza tra gli antagonisti sociali, è ciò che in ultima istanza decide il risultato dello scontro, e non solo lo scontro sulla giornata lavorativa ma ogni lotta tra i due soggetti in conflitto. E’ la forza (i rapporti di forza) che svolge ininterrottamente la funzione di arbitro supremo tra le parti in lotta, al punto che il “diritto del più forte” costituisce per Marx una costante storica in tutte le società di classe, anche se mascherato dalle più sofisticate “vesti giuridiche”. Nella Introduzione alla critica dell’economia politica egli ha messo alla berlina le concezioni borghesi liberaldemocratiche sulla natura “neutrale” dello Stato, illustrandone invece la condizione fondamentale, spesso nascosta e latente, che assicura in ultima analisi anche la riproduzione del modo di produzione capitalistico: «ogni forma di produzione crea i suoi propri rapporti giuridici, la sua propria forma di governo ecc. La grossolanità e la povertà concettuale di quel modo di pensare consistono appunto in questo, che esso mette in rapporto solo accidentalmente, unendoli con un nesso esclusivamente mentale, degli elementi che sono invece collegati l’uno all’altro organicamente. L’unica cosa che gli economisti borghesi hanno presente è che con la moderna polizia si può produrre meglio che non, per esempio, con l’autotutela. Solo che essi dimenticano che l’autotutela è anch’essa un diritto, e che il diritto del più forte continua a vivere, sotto altra forma, anche nel loro “Stato di diritto”»62. Secondo la (corretta) valutazione di Marx, la “legge del più forte” continua ad esistere anche nella formazione economico-sociale capitalistica e non costituisce un retaggio esclusivo dei tramontati modi di produzione asiatico, schiavistico e feudale.
Ma Marx ha fornito anche una embrionale distinzione tra campi di forza (politico-sociali) effettivi e potenziali sviluppando la condizione necessaria per la trasformazione dei secondi nei primi in presenza di determinate condizioni storiche. Nel 1844, in Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, egli aveva affermato realisticamente che, pur se «la critica non è una passione del cervello, ma il cervello della passione»63, «l’arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi e la forza materiale dev’essere abbattuta dalla forza materiale, ma anche la teoria si trasforma in forza materiale non appena s’impadronisce delle masse»64. Infatti, quando ideologie ed utopie acquisiscono ed ottengono un consenso di massa, esse diventano forze materiali come i cannoni, i fucili ed il possesso di mezzi di produzione: ma allora il “numero”, la quantità fisica degli oppressi e degli sfruttati pesa soltanto se collegata alla parallela presenza di una coscienza politica collettiva e di una organizzazione politica adeguata. Sta in questo lavoro da fare la funzione imprescindibile degli “uomini rossi”.
Capitolo quarto
Bisogni, omega e comunismo
1. I bisogni dall’“alfa” all’“omega”
La base materiale del primato della sfera politica e dei rapporti di forza politici e militari nelle società di classe post-neolitiche è costituita dall’enorme estensione assunta dalla struttura dei bisogni e degli interessi materiali delle diverse classi sociali, privilegiate e sfruttate, che vi esistono: questi bisogni materiali ed interessi economici collettivi non sono altro che la pluralità delle esigenze, dei desideri e delle preferenze espresse in modo relativamente omogeneo dai singoli gruppi d’individui in una posizione sociale omogenea, e che hanno per oggetto la distribuzione dei mezzi/oggetti di produzione e dei beni di consumo, del prodotto surplus sociale e del carico di lavoro globale: base concreta che ne influenza e condiziona in maniera determinante i comportamenti di massa e i conflitti relativi ai beni economici intesi in senso ampio, ivi compresi i servizi sociali, i mezzi di trasporto, ecc.
È certamente inutile riscoprire “l’acqua calda” dell’importanza degli interessi economici e dalla lotta per i bisogni materiali nelle società classiste, che risulta una centralità ormai generalmente riconosciuta nello stabilire, almeno in ultima istanza, le simpatie/antipatie e le pratiche collettive dei diversi soggetti presenti in campo economico, sociale e politico, includendo nella categoria della praxis anche l’inerzia e la passività di massa, oppure l’acquiescenza tacita alle pratiche dominanti delle classi egemoni e l’accettazione forzata delle “regole del gioco” proprie della formazione economico-sociale in cui si vive; è invece necessario sviluppare una maniera diversa di raffigurazione del complesso di questi bisogni ed interessi materiali di classe, che parta dal gradino più basso e modesto dei bisogni e preferenze economiche collettive per arrivare, senza soluzione di continuità, ai gradini e livelli superiori più ambiziosi. Per ogni gruppo sociale omogeneo, infatti, non esiste un solo ed unico bisogno materiale collettivo da raggiungere, ma una serie di strati di bisogni per niente uguali tra di loro, sia per la forma della manifestazione storica concreta che per quello della loro capacità di soddisfazione/insoddisfazione.
Il gradino inferiore, o livello alfa, dei bisogni materiali di un gruppo sociale omogeneo, sia di sfruttati che di sfruttatori, è determinato dall’appropriazione della quantità-qualità dei mezzi di produzione e/o di beni di consumo appena sufficiente a garantirne una sopravvivenza di gruppo stentata e precaria; allo stesso tempo esso indica la soglia minima di partecipazione alla ripartizione del prodotto sociale da parte di ciascuna classe/fazione di classe perché al di sotto di essa, in una data formazione economico-sociale e in un certo periodo storico, inizierebbe il processo della sua estinzione, almeno sociale se non anche biologica. Il gradino superiore dei bisogni di classe, o livello omega, è invece contraddistinto dall’appropriazione di mezzi di produzione e beni di consumo tali da portare, in un particolare contesto storico economico-sociale, un gruppo o una classe sociale all’appropriazione totale/quasi totale del prodotto sociale complessivo, e alla riduzione simultanea al minimo (al limite fino a zero) alla partecipazione personale e collettiva al processo di produzione.
Tra questi due estremi si collocano altri livelli dei bisogni/aspettative materiali, tra i quali si possono distinguere, per esperienza storica delle lotte di classe degli ultimi sei millenni, almeno tre livelli-chiave. Il primo è quello di una appropriazione del prodotto sociale (beni di consumo e/o mezzi di produzione) sufficiente a garantire una riproduzione stabile (“normale”) delle condizioni di vita materiali della classe interessata in quel particolare periodo storico (si tratti, ad esempio, di un “salario dignitoso”, oppure di una “rendita fondiaria sicura”, o di un “saggio del profitto medio garantito”); poi segue il livello d’appropriazione di una parte maggiore e crescente, rispetto al passato, del prodotto sociale complessivo, ma senza volontà di acquisire una posizione dominante all’interno della formazione statale di appartenenza (com’erano le aspettative della borghesia mercantile all’interno del sistema feudale medievale); infine sussiste il livello di mantenimento del possesso della porzione maggioritaria delle forze produttive sociali, assicurato anche grazie all’utilizzo politico selettivo dell’apparato di stato e delle c.d. “terre economiche di frontiera” (fisco, moneta, politiche economiche e di commercio con l’estero, ecc.).
È appena il caso di rilevare come i bisogni materiali non costituiscono le uniche forme di desideri ed aspettative espresse dalla specie umana, nettamente scavalcati per importanza dal «bisogno dell’altro uomo»65, ossia dalla necessità di sviluppare le proprie capacità umane affettive/erotiche/amicali, dal desiderio ludico/creativo e dall’empatia/compassione per gli altri esseri viventi. Parallelamente va notato come le stesse lotte per la soddisfazione dei bisogni materiali di classe possono creare sentimenti di fraternità ed eroismo collettivo, di idealismo di massa e di iniziativa sociale diffusa, in grado di provocare entusiasmi collettivi e relazioni armoniose nei gruppi impegnati in conflitti politici e/o sociali che li vedono protagonisti facendo loro sopportare privazioni anche per tempi relativamente lunghi; va infine sottolineato che nei bisogni materiali collettivi vanno distinti quelli che si possono soddisfare soltanto socialmente da quelli che trovano invece esaudimento per via individuale, come per la fame il cibo o per il freddo i vestiti, sebbene pur sempre con una matrice di base almeno in parte comune a tutti gli uomini.
L’esperienza storica insegna come ogni classe o frazione di classe raggiunga ogni volta un determinato livello di soddisfazione delle proprie necessità materiali, collocato ad un particolare gradino della “scala dei bisogni” rispetto a quelli occupati invece dalle altre classi o frazioni di classe (a meno del caso eccezionale del “livello omega”, che presuppone l’appropriazione totale ed esclusiva dei mezzi di produzione e del prodotto sociale da parte di un gruppo sociale): in questo modo il livello reale di soddisfazione dei bisogni materiali di una classe viene ad essere determinato non soltanto dalle aspettative soggettive da lei espresse, ma anche e soprattutto dal punto di caduta della correlazione di forza concreta che sussiste con le altre classi. La classe sociale (o la frazione di classe) che riesce a trasformare a proprio favore il rapporto di potenza generale esistente in una data formazione statale ottiene, come “dividendo” economico, un miglioramento del proprio livello di soddisfazione dei bisogni materiali nella scala dei bisogni di regola proporzionale al vantaggio guadagnato, mentre la classe che perde nella lotta subisce un processo inverso di peggioramento del proprio livello di soddisfazione. facendo emergere dallo stato di latenza un’aspettativa di bisogni collocata in una posizione socioproduttiva meno elevata e “pregiata” di quella posseduta in precedenza.
Di regola, in un dato periodo storico più o meno prolungato, è un solo livello di aspettative/desideri materiali che diventa prioritario nel guidare l’azione collettiva di un certo gruppo sociale e dei suoi mandatari politici, assumendo il ruolo di “bisogno numero uno”, mentre tutti gli altri livelli possibili rimangono subordinati e quasi sempre in stato di letargo; cambiando però i rapporti di forza generali tra le classi, un nuovo “bisogno numero uno” può emergere dalla subalternità o, più spesso, dalla latenza in cui era sprofondato per la presenza di relazioni di classe e correlazioni di potenza considerate in precedenza non compatibili con una sua potenziale centralità.
Ma se ora dall’enunciazione generale vogliamo passare alla verifica storica concreta dei due “poli estremi” (il “livello omega” e il “livello alfa”) della scala dei bisogni materiali delle diverse classi sociali, dobbiamo analizzare sia la loro genesi che le modalità con cui la loro riproduzione materiale si accompagna alla centralità della sfera politica e dei rapporti di forza politico-militari nel processo di soddisfazione-insoddisfazione dei bisogni di classe.
Intanto la genesi materiale del bisogno alfa risiede nella combinazione ininterrotta di pratiche e comportamenti individuali/di gruppo espressi già dai mammiferi e ripresa dai primi ominidi da almeno 9-7 milioni di anni fa, visto che in questo enorme arco temporale gli esseri umani hanno accumulato un’enorme esperienza collettiva che li ha portati ad affinare e sviluppare sempre di più l’istinto di sopravvivenza, che resta la forma primordiale ma socializzata del “bisogno alfa” anche nelle società di classe. Nella sua interazione continua con i compagni di specie, con le forme di vita vegetale/animale e con la natura inorganica il genere umano ha riprodotto e migliorato con molteplici modalità di azione la tendenza basilare finalizzata ad assicurarsi la riproduzione biologica elementare (fame, sete, sesso, prole, ecc.) anche nelle condizioni più difficili e contro i nemici e i pericoli più insidiosi66.
Per quanto riguarda invece la genesi sociale del bisogno omega, fin dal tardo Paleolitico si è prodotta una dialettica tra lo sviluppo delle forze produttive sociali ed il sistema dei bisogni umani che ne ha lentamente prodotto (a tappe) un piano superiore originale, nuovo ed “innaturale”, consolidatosi nel tempo nella forma di una tendenza consumistica volta ad espandere, sia sul piano quantitativo che qualitativo, la produzione di diverse tipologie di oggetti adatti alla loro soddisfazione materiale, perchè l’essere umano, oltre a presentarsi come un animale sociale, è pure un “animale consumista” che non si accontenta della soddisfazione naturale anche dei più semplici bisogni fisiologici. Questa tendenza prende l’avvio dalle prime prove inconfutabili di utilizzo sistematico del fuoco per riscaldarsi, ma anche per consumare cibi cotti: «il fatto di cuocere gli alimenti è, tra le attività umane, una di quelle che certo ha avuto più ripercussioni sulla vita quotidiana, la patologia e lo sviluppo psichico del genere umano», ha affermato la paleontologa C. Perles in un sofisticato studio sull’utilizzo del fuoco durante la preistoria67. Hanno poi fatto seguito il bisogno di abitazioni, vestiti e scarpe non solo per difendersi dal freddo ma anche per comodità personale, la produzione e il consumo di oggetti ornamentali per il corpo ed infine la conquista di tempo libero per il riposo, per le attività ludiche ed affettivo-sessuali, per il godimento di attività artistiche come la pittura, la scultura e la musica, per l’educazione dei figli e la narrazione di storie/leggende tramandate collettivamente di generazione in generazione68.
Questo “diritto all’ozio creativo” ha sicuramente contraddistinto la riproduzione materiale delle tribù di cacciatori e raccoglitori di cibo fin dal tardo Mesolitico, come dimostrano gli studi sulle condizioni di vita di molti popoli contemporanei “primitivi” (come i boscimani del deserto del Kalahari)69.
Se ne può dedurre che già nel Paleolitico e nel Neolitico collettivistico aveva preso il via un “circolo virtuoso” grazie al quale lo sviluppo lento e molecolare delle forze produttive sociali stimolava il progresso quantitativo/qualitativo dei bisogni umani, accelerando a sua volta la crescita di ulteriori forze produttive in una spirale espansiva potenzialmente senza fine, sia pure in presenza dei limitati mezzi di produzione a disposizione degli uomini/donne dei clan preistorici; ad esempio gli abitanti della città neolitica e prevalentemente collettivistica di Catal Huyuk, tra il 6400 ed il 5600 a.C. producevano e consumavano sia pane che vino e birra, utilizzavano sostanze dolcificanti come il miele e si vestivano di stoffe con frange e cordoncini, mentre le donne indossavano orditi a scialle con disegni a colori, ma si fabbricavano anche oggetti “superflui” come le stuoie e i tappeti, mentre nelle case trovavano posto scodelle in ceramica e cucchiai, casse di legno, portauova e cesti, specchi di ossidiana, perle ornamentali, ciondoli, saponi e cosmetici70.
L’esperienza storica del “rosso” paleolitico-neolitico mostra come anche un limitato livello di sviluppo della produzione sia in grado di innescare una crescita almeno equivalente del bisogno di beni superflui, in quanto non direttamente indispensabili per la sopravvivenza individuale e/o di gruppo, producendo un desiderio collettivo di benessere materiale superiore, nei limiti del possibile, allo stretto necessario alla soddisfazione delle necessità fisiologiche di base. E’ anche degno di nota che tale coesistenza sia avvenuta in presenza di rapporti di produzione collettivistici, in cui erano date per scontate e normali l’appropriazione e ripartizione in comune del prodotto sociale, dei mezzi di produzione e dei beni di consumo ed in cui vigeva ancora il predominio di quella “linea rossa” egualitaria e matriarcale-gilanica che verrà poi travolta dalla “linea nera” ad esclusivo vantaggio di una minoranza ristretta di popolazione.
2. Il “bisogno omega” della “linea nera”
A seguito della vittoria su scala mondiale dei rapporti di produzione classisti (asiatici, schiavistici, feudali e capitalistici) la tendenza paleolitica-neolitica rivolta all’espansione del livello dei consumi ha preso un indirizzo particolare, allo stesso tempo elitario, sofisticato e dispendioso: infatti dal 3700 a.C. in poi la disponibilità di un surplus produttivo permanente è stata rivolta alla soddisfazione dei desideri materiali più costosi di una minoranza ristretta della società, anche mediante la produzione di oggetti di lusso e di beni di consumo di particolare valore (capaci quindi di assorbire quantità molto elevate di lavoro umano) dal cui consumo era esclusa la maggioranza della popolazione. A ciò si è accompagnata anche la tendenza a ridurre al minimo, se non a zero, la partecipazione diretta al processo produttivo dei singoli esponenti delle classi venute in possesso delle condizioni materiali di produzione, nonché la loro tendenza alla “tesaurizzazione” di metalli preziosi, denaro e opere d’arte che è tipica delle formazioni economico-sociali classiste; quando non contrastata da un grado sufficiente di contropotere da parte delle masse sfruttate, questa tendenza nichilista allo spreco dissipatore delle classi privilegiate ha potuto manifestarsi nel suo sinistro splendore conquistando un grado molto elevato di soddisfazione concreta in uno “spettacolo” d’esibizionismo consumistico a fronte della parallela miseria dei produttori diretti.
Nel modo di produzione asiatico alle classi socialmente dominanti, facilmente identificabili con le élites politico-militari al potere (sia laiche che religiose) e con i settori più elevati degli apparati statali, spettava la quasi totalità delle condizioni generali della produzione, a partire dal possesso della terra e delle acque, e quindi il surplus estorto ai produttori diretti, in primo luogo rurali. La miseria quasi assoluta dei contadini indiani o cinesi, ma pure egiziani o babilonesi, consentiva loro una riproduzione stentata, a fronte del lusso delle classi privilegiate.
Nel modo di produzione schiavistico l’appropriazione dei mezzi di produzione da parte degli sfruttatori era arrivata a comprendere anche buona parte della stessa forza-lavoro umana, a cui potevano essere ridotti anche dei cittadini liberi che si erano troppo indebitati. Il tenore di vita della grande maggioranza degli schiavi era mantenuto estremamente basso con metodi coercitivi che ne consentivano molto spesso una riproduzione precaria: nella più vasta area schiavistica dell’occidente, la formazione statale romana, la costituzione di grandi proprietà agricole fin dalla fine del terzo secolo a.C. aveva creato le condizioni più favorevoli per l’applicazione in massa del lavoro schiavile sia nei campi che nelle domus padronali dove «esistevano centinaia di schiavi, dai portieri, corrieri, lavapiatti, domestici ai parrucchieri, manicure, maestri, medici, amministratori, fattorini, ecc.»71. Per quanto riguarda il livello di consumi dell’alta società romana era diffuso un consumo di lusso ed uno spreco inaudito (sono celebri le pagine di Petronio nel Satyricon sulla cena straordinaria offerta ai suoi ospiti dal magnate Trimalchione).
All’interno del modo di produzione feudale, la tendenza dell’aristocrazia fondiaria si rivolse sia verso l’appropriazione crescente delle terre dei contadini ancora liberi che all’aumento dei carichi di lavoro e/o delle rendite monetarie dovute dai servi della gleba, il cui tenore di vita era mantenuto generalmente ai limiti della sussistenza da rapporti di forza politico-militari estremamente sfavorevoli a loro. Al contrario, «la vita a corte è tutta seducente e piena di gioia e di trastulli, di dame e di uomini pieni di spirito e di fantasia che passano la vita in occupazioni leggere e di nessun peso: le nugae, gli svaghi»72, mentre la forte concentrazione della ricchezza «favoriva la domanda di servizio domestico..., anche perchè il numero dei servitori veniva assunto, assieme al vestire, come simbolo di opulenza e potere»73.
Anche nel modo di produzione capitalistico il “bisogno omega” iperconsumista, predatorio ed elitario ha infettato la coscienza sociale ed i sogni collettivi dell’alta borghesia contribuendo in misura notevole ad uno sfruttamento (al limite autodistruttivo) della forza-lavoro salariata e ad una riduzione del suo bisogno di consumo alla pura sopravvivenza. Questa «tendenza costante del capitale di abbassare gli operai fino a questo punto nichilistico»74 è arrivata a materializzarsi in forma quasi perfetta nella condizione imposta dalla borghesia agli operai agricoli della Gran Bretagna nei primi tre decenni dell’Ottocento. Ma non si possono considerare storie superate, provenienti da un lontano passato ormai sepolto, se ancora negli Stati Uniti della fine del XX secolo l’impoverimento assoluto, la miseria e lo “stato di emergenza” in cui si trovano ampi strati di lavoratori americani costituiscono dei dati reali innegabili, come documentato nello splendido libro-inchiesta di Barbara Ehrenreich dedicato alle «paghe da fame»75. E’ comunque nell’area coloniale/neocoloniale che la pressione concreta esercitata dalla borghesia monopolistica, dalle multinazionali e dai loro mandatari politici sul tenore di vita dei produttori diretti ha raggiunto i suoi apici ed il “bisogno omega” degli sfruttatori si è manifestato nelle sue modalità più sinistre76. E sono tuttora centinaia di milioni i salariati che in America Latina, Africa e Asia che ottengono per una lunga giornata di lavoro soltanto salari a malapena sufficienti per una riproduzione stentata e dolorosa della loro esistenza77.
Alla “tendenza nichilista” del capitale nei confronti dei propri operai si oppone invece la riproduzione di livelli di consumo superiori (propensione al lusso ed ostentazione di ricchezza) espressi di regola dalla fascia superiore della borghesia industriale e finanziaria. Se agli inizi del modo di produzione capitalistico (ogni capitalista “parvenu” percorre individualmente questo stadio storico) predominano come passioni assolute l’impulso all’accumulazione e l’avarizia, «il progresso della produzione capitalistica non crea soltanto un mondo di godimenti, apre anche con la speculazione e col credito mille fonti di arricchimento improvviso. A un certo livello di sviluppo un grado convenzionale di sperpero, che è allo stesso tempo ostentazione della ricchezza e quindi mezzo di credito, diventa addirittura necessità di mestiere per il “disgraziato” capitalista ed il lusso rientra nelle spese di rappresentanza del capitale»78. Così, sebbene la prodigalità del capitalista non possieda quel carattere di buona fede che era tipica della elegante dissipazione dei signori feudali, incombendo sempre sullo sfondo la più sporca avarizia ed il calcolo più ansioso, lo tendenza allo spreco aumenta insieme all’accumulazione, senza che l’uno sia pregiudizievole all’altra. Come per le altre classi privilegiate della storia, anche il prestigio sociale della borghesia si conquista e si mantiene mediante una elevata capacità di spesa che si esibisce mediante modelli di vita fondati sulla dissipazione di reddito di cui Thomas Veblen, nella sua opera La teoria della classe agiata, aveva descritto più di un secolo fa alcune tipologie: l’utilizzo su larga scala di personale domestico, la moltiplicazione di abitazioni lussuose e di vacanza, il turismo in paesi esotici, l’utilizzo di mezzi di trasporto terrestri-aerei dispendiosi, la fruizione di alimenti/vestiti/gioielli inaccessibili agli altri, l’accumulazione su larga scala di opere d’arte, il godimento di forme di divertimento e di gioco particolarmente elaborate, senza tener conto delle loro forme “deviate” quali l’utilizzo di droghe e la prostituzione d’alto bordo79.
Tuttavia la tendenza nichilista delle classi dominanti ha sempre incontrato due invalicabili ostacoli “naturali” alla propria espansione ed una controtendenza principale in campo politico-sociale. Il primo e costante limite è rappresentato (lo è tuttora) dalla necessità di assicurare comunque un fondo di consumo minimale ai produttori diretti, in assenza del quale nessun processo di erogazione di lavoro da parte loro potrebbe aver luogo e quindi nessun surplus verrebbe prodotto. disposizione delle classi dominanti. Certamente, come ha notato Marx a proposito della formazione economico-sociale capitalistica, «se si potesse avere lavoro senza acquistarlo, i salari sarebbero superflui. Ma se gli operai potessero vivere d’aria, non si potrebbero neanche comprare a nessun prezzo. La gratuità degli operai è dunque un limite in senso matematico, sempre irraggiungibile, benché sempre più approssimabile»80. Certamente non sono mancati tentativi concreti di avvicinarsi alla gratuità della forza-lavoro: secondo il cinico calcolo del generale delle SS Oswald Pohl nei campi di sterminio nazisti la soglia della sua remuneratività minimale (per cibo, vestiario e alloggiamento) avrebbe potuto corrispondere «ad una sopravvivenza media dei detenuti di circa otto mesi. Era quindi sufficiente sostituirli con altri, sempre reperibili nei paesi conquistati, sotto diversi pretesti»81. Tuttavia un simile meccanismo di sfruttamento/sterminio si fondava sulla possibilità di acquisire sempre nuovi schiavi in Europa, dato che in mancanza esso sarebbe subito andato in rovina. Per questo il “bisogno omega” della “linea nera” può arrivare molto lontano, ma mai fino alla “vittoria finale” e così, quando c’è stato il rischio di mettere in pericolo la riproduzione biologica dei produttori diretti, è scattato l’allarme rosso, sia pure egoista ed interessato, dei ceti dominanti e dei loro mandatari politici (il che spiega l’apparentemente innaturale alleanza militare, in senso antinazista, degli alleati anglo-americani con l’Unione Sovietica stalinista).
Il secondo ostacolo alla soddisfazione (quasi completa) del “bisogno omega” delle classi dominanti sta invece nel grado di contropotere politico-sociale che di volta in volta viene esercitato dalla massa degli sfruttati. Persino in scenari e situazioni storiche caratterizzate dai rapporti di forza assai sfavorevoli, essi hanno sempre detenuto un minimo di capacità di opposizione: al limite i piedi per fuggire oppure le mani per sabotare gli strumenti di lavoro. E anche quando la forza-lavoro era uscita da una gravissima sconfitta, continuava molto spesso ad operare la paura collettiva delle classi dominanti per quella opposizione manifestata in modo aperto dalle masse popolari precedentemente.
Per questo il “bisogno omega” della “linea nera” può trovare un limite di compromesso a vantaggio di segmenti più o meno estesi dei produttori diretti, soprattutto quando il livello del surplus rimane per un periodo prolungato su dimensioni quantitative/qualitative elevate. Nell’antichità classica molti degli schiavi più qualificati, che spesso dirigevano le attività produttive dei loro padroni, potevano ottenere di frequente la loro libertà individuale, mentre nel Medioevo le rendite della Chiesa potevano trovarsi in una condizione di privilegio tale, per l’esenzione dai tributi statali e dai carichi militari e la gestione relativamente efficiente degli ordini monacali rispetto ai feudi laici, da permettere ai servi della gleba e agli affittuari liberi-semiliberi delle proprietà ecclesiastiche di godere di un trattamento migliore rispetto a quello dei loro “compagni di classe” posti sotto il dominio feudale. Infine il monopolio prolungato del settore tecnologico-industriale da parte di determinate formazioni statali capitalistiche (come la Gran Bretagna prima, e gli Stati Uniti poi) e lo sfruttamento sistematico degli imperi coloniali-neocoloniali hanno facilitato l’emergere e la diffusione di una aristocrazia operaia nelle metropoli imperialistiche, mantenuta grazie soprattutto ai sovrapprofitti giganteschi guadagnati dai monopoli ed in parte ridistribuiti ai salariati.
3. Il “bisogno omega” degli “uomini rossi”
Ma non sono stati solamente i ceti privilegiati ad esprimere il proprio “bisogno omega”, perchè anche i “pezzenti e la plebaglia”, i produttori diretti e gli sfruttati, che si sono riprodotti in molteplici forme dal 3700 a.C. in poi (i contadini del modo di produzione asiatico, gli schiavi del modo di produzione antico, i servi della gleba del modo di produzione feudale, i lavoratori salariati del modo di produzione capitalistico), hanno espresso costantemente un proprio livello superiore di desideri ed aspettative collettive-materiali, un loro particolare bisogno omega da intendersi come la combinazione (mutevole e dialettica) di due componenti fondamentali: la tendenza collettiva rivolta all’appropriazione integrale del prodotto sociale e l’impulso ad espandere al massimo grado ritenuto collettivamente possibile la quantità-qualità di beni di consumo e di tempo libero a propria disposizione. Ma siccome nel processo millenario di sviluppo delle società di classe i rapporti di forza politico-militari sono stati – lo sono tuttora – quasi sempre sfavorevoli ai produttori diretti, questo livello superiore di desideri/aspettative materiali è rimasto in gran inespresso. Ciononostante, come dal 3700 a.C. in poi sussiste una contraddizione radicale tra il “bisogno omega” degli “uomini neri” (schiavisti, feudatari, capitalisti e loro mandatari politici) ed il “bisogno alfa” dei produttori diretti, allo stesso modo è presente una contraddizione altrettanto antagonistica con il “bisogno omega” dei produttori diretti, sebbene per la loro inferiorità nei rapporti di forza politico-militari il differenziale di potenza, che si è riprodotto quasi costantemente a loro danno, ha reso e rende tuttora latente, timida e semiclandestina l’espressione di quel “bisogno omega”.82
In secondo luogo va detto che nel periodo preso in esame (3700 a.C.-2008 d.C.) lo sviluppo delle forze produttive sociali si è rivelato assolutamente insufficiente per permettere una soddisfazione anche parziale del bisogno materiale più ambizioso ed “edonistico” delle masse popolari: ancora all’inizio del XXI secolo il grado di sviluppo raggiunto dal complesso scientifico-tecnologico nel pianeta non è in grado, anche con un’utilizzazione ottimale delle risorse che eliminasse ogni forma di spreco (dai consumi di lusso alle spese per armamenti), di permettere in tempi medi di elevare almeno del doppio i livelli di consumo e assistenza sociale del proletariato delle metropoli imperialistiche, i cui strati inferiori sopravvivono ancora in una condizione materiale di semi-miseria, di ridurre almeno della metà l’odierna durata della giornata lavorativa media, di estendere almeno parzialmente la nuova e più fortunata condizione materiale dei lavoratori occidentali ai loro compagni di classe d’Asia, Africa e America Latina.
Di conseguenza le forme storiche concrete attraverso cui si è manifestato il “bisogno omega” dei produttori diretti nella sua direzione consumistica ed edonistica sono state molto spesso espresse con modalità mitologiche o religiose, collegate ad utopie terrene o a proiezioni in mondi fantastici od ultraterreni: un limite inevitabile che tuttavia non toglie affatto dignità storica al superamento, almeno nel sogno collettivo, di una condizione di esistenza caratterizzata da livelli feroci di sfruttamento e miseria di massa. Va però detto che alle volte nella coscienza dei produttori diretti ha prevalso l’ascetismo rivoluzionario, il rifiuto radicale di qualunque forma di consumo oltre i limiti naturali e fisiologici. Questo ascetismo ha costituito il sottoprodotto di lotte sanguinose, spesso disperate, contro il nemico di classe nelle quali diventavano fondamentali l’abnegazione e l’eroismo collettivo; e tuttavia, pure in questi scenari l’autoriduzione collettiva e cosciente del livello di consumo praticato nella fase rivoluzionaria ha lasciato sempre aperto uno spiraglio edonistico per i successivi “tempi nuovi”, come ad esempio nella Russia sovietica della NEP (1922-1929) dopo la fase iniziale del “comunismo di guerra” (1918-1921).
Ma da dove nasce il “bisogno omega” degli sfruttati? Innanzi tutto i produttori diretti, le masse popolari e il “proletariato storico” hanno ereditato, e trasformato nel corso del tempo, il bisogno edonistico-consumistico dei loro antenati paleolitici e neolitici: “germi” ed embrioni di consumi superiori, sconosciuti ad ogni altra specie animale, avevano già caratterizzato il loro concreto processo di riproduzione materiale, dai vestiti ai cibi cotti e alle bevande alcoliche che hanno quasi sempre addolcito parzialmente l’esistenza dei “pezzenti”. Ora proprio queste minuscole briciole di abbondanza sono state il primo “carrello elevatore” che ha trascinato verso l’alto le aspirazioni di bisogni-sogni degli sfruttati nel corso degli ultimi sei millenni, mantenendo in vita quella positiva “tendenza consumistica” che da almeno quarantamila anni contraddistingue gli esseri umani. In secondo luogo, come ha notato Hilario Franco jt., è caratteristica propria della umanità il creare immagini ed utopie che superassero le carenze della esistenza quotidiana, essendo l’essere umano un animale che sogna ad occhi aperti, anche se in modo rozzo e intermittente83. Furono e sono solo fantasie collettive, ma alle volte molto concrete perchè, anche in presenza di un livello di sviluppo molto basso delle forze produttive, sono state in grado di produrre variegati modi di pensare e proteiformi pratiche sociali e politiche diventate parti integranti ed inscindibili del sistema plurilivellare di bisogni caratteristico delle diverse materializzazioni del “proletariato storico”.
Un’altra fonte costante di produzione del “bisogno omega” delle masse popolari è stata la stessa esistenza-riproduzione dei gruppi sociali privilegiati nelle società di classe. ovvero più semplicemente l’osservazione empirica del fatto evidente che una minoranza della società aveva il diritto di consumare molto più dello stretto necessario per sopravvivere, e molto spesso senza nemmeno partecipare al processo di produzione, realizzando una sorta di diritto all’abbondanza ed all’ozio riservato a pochi eletti. Le masse popolari hanno sempre avuto “occhi” collettivi sufficientemente aguzzi per osservare le condizioni di vita delle élites privilegiate, comparandole alla loro esistenza quotidiana; le “spie” inconsapevoli delle masse popolari, le serve/i servi al lavoro nelle residenze padronali non sono mai state cieche o mute diffondendo notizie spicciole sul tenore di vita dei loro padroni, mentre molto spesso l’opulenza delle classi agiate veniva esibita in maniera sfacciata, svolgendo in ultima analisi il ruolo di “vetrina consumistica” e di moltiplicatore di desideri e aspettative all’interno delle stesse masse popolari. Ma forse servono prove empiriche e “fatti testardi” che, combinati tra loro, supportino l’esistenza concreta del “bisogno omega” nella coscienza collettiva della grande maggioranza dei produttori diretti, sebbene esso si sia manifestato e si manifesti tuttora in forme mutevoli e a volte contraddittorie nei singoli lavoratori e nei diversi periodi storici.
4. Il “sogno di una cosa”
La prima prova materiale che attesta concretamente la riproduzione costante negli ultimi millenni del “sogno di una cosa”84 (Marx, 1844), la riproduzione storica del “bisogno di comunismo” (edonistico) tra tutti i produttori diretti, urbani o rurali, è costituito dall’enorme diffusione e popolarità goduta dalle feste durante tutti gli ultimi sei millenni di storia del genere umano. Durante alcuni brevi attimi, che si riproducevano di regola ogni anno in periodi normalmente prestabiliti, le masse popolari si riappropriavano dei tempi della propria esistenza attraverso un consumo, finalmente senza restrizioni, di calore umano, erotismo, cibi e bevande alcoliche. Tali feste potevano assumere a volte un aspetto laico ma più spesso religioso, costituendo comunque un momento importante, anche se di breve durata, di liberazione temporanea dalle ansietà quotidiane e di comunanza fraterna (quasi) senza contraddizioni. Ma c’è di più, perchè i culti orgiastici in onore di Dioniso, i Saturnali romani, le Feste dei Pazzi medioevali e i Carnevali occidentali (e dell’America Latina) hanno rappresentato, in diverse epoche storiche, anche dei momenti di cripto-sovversione sociopolitica, brevi e rituali archi temporali nei quali il godimento collettivo dell’abbondanza e dell’ozio era collegato alla fine provvisoria delle gerarchie sociali e politiche esistenti, o alla loro beffarda e dissacrante inversione in una sorta di esaltante “mondo alla rovescia”85.
Un’altra (timida) orma del bisogno omega-edonistico è rappresentata da buona parte delle fiabe e dai racconti popolari di fantasia apparsi in misura considerevole fin dall’epoca schiavistica (si pensi ad Esopo e Fedro), i cui elementi utopici hanno costituito sia delle proiezioni parziali dell’insoddisfazione delle masse verso i rapporti di classe che una protesta spesso vittoriosa (ma solo nella fiaba, ovviamente) contro l’oppressione sociopolitica. Così, sebbene «nel racconto popolare non si faccia menzione di un altro mondo,... la magia ed il miracoloso servono a spezzare i confini feudali e rappresentano metaforicamente i desideri consci e inconsci delle classi inferiori... mettendo in luce la critica sociale sottesa agli elementi immaginativi»86.
Una terza traccia storica lasciata negli ultimi sei millenni dal “bisogno omega” del proletariato storico è rappresentata dalla diffusione della fede religiosa nel paradiso e dall’ardente desiderio di larga parte degli sfruttati di vivere dopo la morte in un altro mondo in cui potessero finalmente regnare abbondanza, pace e tempo libero per tutti gli “eletti” a sostituzione delle vecchie e odiose strutture di classe. Il paradiso, questo “nuovo millennio” utopistico religioso in cui “gli ultimi saranno i primi”, ha costituito per quasi tre millenni il punto di focalizzazione immaginario del livello superiore dei bisogni materiali di larga parte degli oppressi del mondo ebraico, dell’impero romano ed in seguito dell’area geopolitica cristiana e musulmana, mentre rimane ancor oggi un punto di riferimento concreto per importanti frazioni di lavoratori del mondo.
Il “bisogno omega” delle classi proletarie, nel suo lato edonistico, ha trovato un’altra condensazione storica nella grande popolarità e nell’enorme diffusione su scala planetaria assunta dalle laiche/semilaiche leggende sull’esistenza di luoghi, più o meno remoti nel tempo e/o nello spazio, contraddistinti dall’abbondanza di beni, dall’assenza di fatica e dall’armonia universale: sono le descrizioni dei paesi di Cuccagna, espressione fantastica ed utopica del loro timido – ma ineliminabile – livello superiore di bisogni materiali. Nel mondo di Cuccagna «tutti gli uomini sono uguali, ossia se la spassano tutti, senza fatica e senza lavoro,... senza lasciarsi più ripetere dai ricchi quanto la ricchezza sia poco invidiabile, quanto sia nocivo il troppo dormire, quanto funesto l’ozio, quanto necessaria la miseria affinché non si paralizzi ogni forma di vita. Il popolo ha continuato a illustrare e, anzi, a caricaturare la sua fiaba più nutriente: i tranci delle viti sono legati con salsicce, le montagne sono diventate di formaggio, i fiumi scorrono gonfi dei migliori moscati. La tavola che si imbandisce da sé, le favolose distese indiane qui sono divenute installazioni pubbliche, condizioni di una vita felice in assoluto»87.
Con il marxismo e la sua prima “ricezione di massa”in Europa tra 1878 e 1892, la tendenza utopistica-edonistica dei produttori diretti ha raggiunto la maturità, venendo finalmente collegata ad un realistico progetto rivoluzionario su scala planetaria e ad una concreta dinamica di sviluppo delle forze produttive sociali. La “corrente calda” del marxismo, secondo la splendida definizione fornita da Ernst. Bloch, mantiene ormai da 140 anni un ruolo rilevante come forza motrice dell’azione collettiva di milioni di esseri umani e come sintesi collettiva dei desideri/sogni/aspettative materiali più ambiziose ed avanzate di una parte consistente dei lavoratori salariali e dei contadini poveri del pianeta che nel 1875, nella Critica al programma di Gotha, Marx ha condensato ad un grado di elaborazione teorica molto avanzata indicando le caratteristiche fondamentali del futuro comunismo sviluppato, allo stesso tempo gioiosamente creativo ed umanistico: «dopo che è scomparsa la subordinazione servitrice degli individui alla divisione del lavoro, e quindi anche il contrasto tra lavoro intellettuale e fisico; dopo che il lavoro non è divenuto soltanto mezzo di vita, ma anche primo bisogno della vita; dopo che con lo sviluppo omnilaterale degli individui sono cresciute anche le forze produttive e tutte le sorgenti della ricchezza collettiva scorrono in tutta la loro pienezza, solo allora l’angusto orizzonte giuridico borghese potrà essere superato e la società scrivere sulle sue bandiere: “Da ognuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni”» 88 Per alcuni decenni, nel corso del Ventesimo secolo, il processo di sviluppo economico-sociale dell’Unione Sovietica è stato vissuto da un settore significativo della classe operaia internazionale come un processo di costruzione materiale di questo “Paradiso in Terra”, con richiami espliciti a quei simboli appartenenti agli strati più antichi della cultura popolare: il mito millenaristico dell’Eden, del Paradiso terrestre, del paese di Cuccagna».
Ma la riproduzione della tendenza collettiva dei produttori diretti e del “proletariato storico” alla riappropriazione totale del prodotto sociale e dei mezzi di produzione ha trovato anche verifica empirica nell’insofferenza di massa contro le ingiustizie sociali nelle grandi ribellioni collettive tese a creare forme avanzate di giustizia e di uguaglianza sociale, attraverso l’erogazione collettiva e su larga scala delle loro capacità ed energie psicofisiche. Sono le manifestazioni storiche (periodiche e quasi sempre sconfitte) di quella «coscienza enorme» dei produttori diretti di cui parlava Marx nei Grundrisse, che si manifesta quando la forza-lavoro collettiva riesce a «riconoscere i prodotti come prodotti suoi e a giudicare la separazione dalle condizioni della sua realizzazione come separazione indebita e forzata» (MARX, Grundrisse)
L’ultima “orma” storica del “bisogno omega”, all’interno della coscienza dei produttori diretti, emerge dalla storia plurimillenaria degli uomini rossi, dei “profeti” laici/religiosi e del “popolo organizzato” dei sovversivi, di quella parte – più o meno consistente a seconda degli scenari storici – delle masse popolari tesa esplicitamente all’espropriazione dei gruppi sociali privilegiati. Sotto questo aspetto è significativo che al filone dei “sovversivi” atei (da Evemero a Meslier, da Mably a Babeuf, da Blanqui a Marx, da Lenin a Mao) si sia affiancata l’esperienza di quel “comunismo religioso” che dai profeti Amos ed Isaia, attraverso Gioacchino da Fiore, Jacopone da Todi e fra Dolcino nel Medioevo, e poi i taboriti e gli anabattisti nel XV-XVI secolo ed il semicollettivismo di Jacques Roux e dell’abate Fauchet durante la rivoluzione francese, giunge alla cosiddetta “teologia della liberazione” del XX secolo.
Del resto la sussistenza millenaria dei bisogni omega si è via via rivelata proprio attraverso la larga popolarità goduta tra le masse dalle gesta dei banditi sociali, dei fuorilegge che hanno lottato – in modo reale o presunto – a fianco dei poveri e contro i ricchi è questa una tradizione che è continuata quasi fino agli inizi del Novecento e su scala planetaria, passando dai fuorilegge cinesi in lotta per difendere i diritti del popolo ai cangaceiros del nord del Brasile, dai banditi-patrioti della Grecia e della Serbia del ’700-800 in lotta contro l’apparato statale ottomano ai briganti-contadini dell’Italia meridionale del 1860-65. Come ha notato giustamente E. Hobsbawm, «il banditismo è una forma piuttosto primitiva di protesta sociale organizzata, forse la più primitiva che si conosca. Certamente questo è ciò che i poveri, in molte società, scorgono nel banditismo e perciò proteggono i banditi, li considerano loro campioni, li idealizzano e ne fanno dei miti: Robin Hood in Inghilterra, Janosik in Polonia e Slovacchia, Diego Corrientes in Andalusia, sono tutti, verosimilmente, personaggi reali, idealizzati. Da parte sua il bandito cerca di adeguarsi al ruolo affidatogli, anche se non è un ribelle sociale consapevole. Naturalmente Robin Hood, il prototipo del ribelle sociale “che prese ai ricchi per dare ai poveri e non uccise mai se non per difesa o giusta vendetta”, non è l’unico nel suo genere. Un uomo deciso, che non intenda sopportare il fardello tradizionale dell’uomo qualunque in una società classista, miseria e rassegnazione, può disfarsene unendosi agli oppressori e servendoli oppure ribellandosi a loro. In ogni società contadina ci sono banditi dei padroni e banditi contadini, per non parlare dei banditi al servizio dello Stato, sebbene solo i banditi contadini ricevano il tributo dell’aneddotica e dei canti popolari»89. Ma se la funzione storica reale dei “banditi contadini” è stata quasi sempre limitata, ciò che rileva in questa sede è notare che per presso le masse popolari urbane e rurali il “fuorilegge-eroe” ha canalizzato, almeno in parte, la latente e seminascosta volontà di ribellione dei produttori diretti, tenuti a bada dalla paura collettiva della repressione statale ma certamente in grado di manifestare, almeno un’ampia simpatia e consenso di massa agli audaci ribelli che sembravano sfidare ed intaccare i rapporti di produzione classista, almeno nei loro aspetti più rivoltanti. Ma, per dirla ancora con Hobsbawm, « proprio questa situazione esprime la tragedia del banditismo sociale. La società contadina lo crea e lo esige quando avverte la necessità di un campione e di un protettore, ma è proprio allora che egli è incapace di aiutare. Il banditismo sociale, infatti, è una protesta, ma debole e senza un contenuto rivoluzionario, non diretta contro il fatto che i contadini siano poveri ed oppressi, ma contro il fatto che qualche volta lo siano in misura eccessiva. Dai banditi-eroi non ci si aspetta una uguaglianza. Essi possono soltanto riparare i torti e dimostrare che qualche volta si può ritorcere l’oppressione»90.
Banditi sociali, ma anche attesa collettiva dell’apocalisse divina contro i ricchi e gli sfruttatori.
Un’ennesima traccia lasciata dal lato antagonista del “bisogno omega” antagonistico è infatti fornita proprio dalla grande diffusione tra le masse popolari della letteratura apocalittica, in larghe zone del pianeta e per periodi di tempo molto prolungati, di origine ebraico-cristiana. Dalle profezie di Amos alle chiese millenaristiche dei nostri giorni, il mito della distruzione apocalittica dei ricchi e dei potenti per l’intervento provvidenziale della forza divina onnipotente ha goduto di grande popolarità tra una parte significativa degli oppressi, esprimendo contemporaneamente il loro desiderio di sovversione nei confronti dei rapporti di produzione e di potere classisti che la loro parallela e sincronica impotenza-paura collettiva di fronte alla forza d’urto, ritenuta invincibile in assenza di un intervento soprannaturale, degli apparati di governo posti a difesa dei privilegi materiali delle classi dominanti. Uno degli scritti del Nuovo Testamento, la lettera attribuita all’apostolo Giacomo, è diventata famosa per le violente invettive contro i ricchi e gli oppressori: nessun accenno al “porgere l’altra guancia”, ma invece un preciso richiamo al “Dio degli eserciti” perchè guidasse la guerra di classe contro i ricchi, come peraltro, con forza e modalità simili, si muovono le invettive dell’Apocalisse di Giovanni rivolte contro “Babilonia”, la Roma schiavista di allora.
Sommando tutte le variegate e a volte contraddittorie forme di espressione agonistica (lotte, organizzazioni e movimenti rivoluzionari, produttivi o utopistici) si può concludere che il “bisogno omega” degli “uomini rossi” non è mai mancato nella lunga storia delle società di classe, coinvolgendo almeno fugacemente, ed in forme iperprudenti, larga parte dei produttori diretti vissuti dal 3700 a.C. in poi. Un lucido conservatore come Ernst Nolte ha recentemente creato la categoria storica della «sinistra eterna» per definire le tendenze collettivistiche espresse apertamente, nel corso del processo storico degli ultimi millenni, dalla parte più generosa e combattiva dei produttori diretti: «il contrasto tra “ricchi” e “poveri” è il contrasto sociale, elementare, in senso assoluto; non vi è nessun paese in nessun tempo in cui esso non compaia, in un modo o nell’altro»91.
Si è già accennato al fatto che il bisogno omega-collettivo del proletariato storico, nelle sue due articolazioni concrete, si scontra ininterrottamente con delle potenti controtendenze che spesso lo rendono latente nella sfera dei desideri/aspettative delle masse popolari, o che viceversa lo indirizzano in una direzione profondamente individualistica.
Innanzi tutto la tendenza edonistica insita nelle masse popolari ha assunto inevitabilmente, almeno fino al 1850-90, delle forme mitiche-mistiche proprio per il livello assolutamente insufficiente e arretrato raggiunto dalle forze produttive sociali negli ultimi cinque/sei millenni: persino all’inizio del terzo millennio dell’era cristiana, la possibile esistenza del comunismo sviluppato e di una distribuzione gratuita e senza controlli (che non sia quello interiore di ciascun individuo) dei mezzi di consumo, secondo la regola del “a ciascuno secondo i suoi bisogni”, si scontra frontalmente con l’ancora basso livello di sviluppo delle forze produttive sociali, persino nelle più avanzate metropoli imperialistiche. Nel migliore degli scenari, la creazione reale di rapporti di produzione e di distribuzione comunisti-sviluppati su scala mondiale costituirà l’orizzonte del genere umano solo alla fine di questo secolo (sempre escludendo catastrofi planetarie…) e la soddisfazione generalizzata e su scala mondiale del livello più elevato dei bisogni materiali dei produttori diretti dovrà essere rimandata forzatamente ad un futuro abbastanza lontano: il nuovo Eden terreno richiede ancora un nuovo e formidabile sviluppo della tecnologia e della scienza, in assenza del quale tutte le forme di distribuzione sociale pienamente comuniste (gratuità+assenza di controllo statale) faranno la triste ed ingloriosa fine delle cucine popolari gratuite create per breve tempo nella Barcellona del 1936, descritte dall’(allora) anarchico catalano Abad de Santillan come «un incubo ininterrotto» che «rovinò l’economia della regione»92.
Invece il lato rivoluzionario del “bisogno omega” è rimasto quasi sempre latente e clandestino – almeno nella grande maggioranza degli scenari storici creatisi negli ultimi sei millenni – nella coscienza/sogni della grande maggioranza del “proletariato storico”, principalmente per la presenza quasi ininterrotta, durante questo lungo arco temporale, di rapporti di forza politici e militari sfavorevoli agli oppressi e della derivata paura di massa che essi creano e riproducono costantemente. Solo momenti storici molto particolari hanno permesso a frazioni consistenti delle masse popolari di manifestare apertamente, nell’arena politico-sociale, i loro bisogni di classe più avanzati ed arditi e proprio per questo maggiormente repressi/autorepressi, dato che l’azione rivoluzionaria di larghe frazioni degli sfruttati presuppone un precedente e radicale mutamento dei rapporti di forza a loro favore oppure un gigantesco aumento del livello dello scontento e dell’indignazione tra i produttori diretti capace di vincere i loro timori collettivi. Per questo il desiderio di liberazione dallo sfruttamento ed il bisogno di appropriazione integrale del prodotto del proprio lavoro sono sempre stati una costante repressa/autorepressa delle società classiste, perché pericolosa e potenzialmente devastante per chi lo esprimeva. E tanto repressa e pericolosa per gli sfruttati, che spesso assumeva la forma prudente della “fuga” sia nel mondo delle utopie che dalla società in cui vivevano con la fondazione di effimere società fraterne in cui i fuggiaschi si riappropriavano della propria vita e del prodotto del proprio lavoro. Lo iato così prodotto tra i bisogni collettivi e la pratica umana ha reso molto spesso inoffensivi, nella vita ed azione politico-sociale, alcuni splendidi desideri “sovversivi” tesi a raggiungere l’abbondanza, l’ozio e la felicità, trasformandoli in bisogni rassegnati. Radicali, ma impotenti; radicali, ma resi inerti sul piano della praxis storica politico-sociale.
Si aggiungano i fallimenti storici dei loro tentativi di emancipazione collettiva che provocano inevitabilmente un riflusso politico-sociale (più o meno prolungato nel tempo) ed un letargo dei bisogni radicali all’interno delle coscienze del “proletariato storico”. La risacca e la delusione collettiva, di dimensione mondiale, provocata dal crollo del socialismo deformato di matrice sovietica è sotto questo aspetto un caso esemplare, ma non certo unico, trovando almeno un suo precedente storico celebre nel processo di trasformazione in senso iperpacifista ed iperlegalitario di quasi tutto il movimento anabattista, in precedenza rivoluzionario e antagonista, dopo la sconfitta della Comune di Munster del 1534. E poi anche i processi di miglioramento reali e prolungati che, rispetto al passato, sono pure avvenuti nelle condizioni di vita materiali delle masse popolari che ha consentito l’aumento (in termini assoluti e/o relativi) di soddisfazione dei loro bisogni materiali, almeno in determinate formazioni statali e in particolari periodi storici. Di regola il raggiungimento di conquiste materiali consistenti e durature, anche se ottenute mediante lotte di massa più o meno aspre, ha determinato uno stato di congelamento più o meno prolungato del “livello omega” dei bisogni proletari e la comparsa di sensibili processi di riduzione qualitativa dell’intensità con cui le aspirazioni “massimalistiche” sono state percepite dalla maggioranza dei produttori diretti interessati. La storia politica-materiale della classe operaia occidentale nel periodo successivo agli anni del “miracolo economico, con il netto miglioramento registratosi allora nelle condizioni generali di vita, specialmente se rapportata con la loro situazione materiale precedente, ha mostrato un parallelo processo di sua integrazione politico-sociale nelle regole del gioco fondamentali della formazione economico-sociale capitalistica, così che le manifestazioni, pur presenti, del suo “bisogno omega” si è presentata sotto forma di lotte “a bassa intensità” che accettavano sostanzialmente di rimandarne in un tempo lontano la soddisfazione concreta.
Si può così in sintesi affermare che se il “livello omega” costituisce una parte integrante della piramide plurilivellare dei bisogni collettivi espressi da gran parte del “proletariato storico”, quasi sempre esso si è manifestato mediante forme utopistiche (laico-religiose) sotto l’aspetto edonistico e con modalità di regola criptiche/semiclandestine, per quanto riguarda il campo delle tendenze antagoniste. Negli ultimi sei millenni, visti specialmente gli sfavorevoli rapporti di forza politici generalmente esistenti tra i possessori delle condizioni della produzione ed i produttori diretti, i “bisogni radicali” in campo economico hanno svolto quasi sempre un ruolo storico limitato nel processo storico e hanno assunto la forma di luce utopico-edonistica tenue e diffusa, diventando forza motrice di reali rivolte di massa solo in casi particolari e per periodi storici abbastanza brevi, con l’eccezione dei gruppi eroici di proletari impegnati attivamente in senso rivoluzionario, quasi sempre minoritari-iperminoritari rispetto all’insieme delle masse sfruttate.
La situazione è parzialmente cambiata nell’ultimo secolo, a partire dal 1914/1917.
Le orme concrete lasciate dai bisogni omega degli “uomini rossi” sul piano storico diventano infatti molto più intense a partire dallo scoppio del primo macello/guerra mondiale imperialistica, evento epocale sul quale Giorgio Gattei ha scritto un saggio molto interessante intitolato “I marxisti e la Grande Guerra: tracce” e segni di presenza numerosi, proteiformi molteplici e variegati,
Gli uomini rossi hanno infatti prodotto e realizzato dei processi rivoluzionari vittoriosi proprio a partire da quell’epocale Ottobre Rosso del 1917 che, nel subcontinente russo, ha costituito la grande e radicalissima risposta della classe operaia mondiale alla gigantesca e sanguinosa “provocazione” all’atto di forza imperialistico iniziato nell’agosto del 1914:rivoluzione vittoriosa per la soddisfazione dei bisogni omega, seppur con un costo umano e materiale tremendo, che hanno dato vita via via a processi difficilissimi, connessi anche a gravi errori e a volte tragedie devastanti,di costruzione di rapporti collettivistici, in America Latina (l’eroica Cuba socialista di Fidel e Raul Castro), in Asia e Africa, non basati sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, non fondati sulla “socializzazione delle perdite, privatizzazione dei profitti” tipica del reale capitalismo di stato e sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
In più di un quarto dell’umanità, nel subcontinente cinese, gli “uomini rossi” hanno ad esempio visto in parte realizzati i loro bisogni più radicali sul piano socioproduttivo, attuando almeno parzialmente il “sogno di una cosa” (Marx,1843) che era stato perseguito per molti secoli dai loro “padri”politici, partendo dai Sopraccigli Rossi e dai Turbanti Gialli dei primi secoli dell’era cristiana.
Ma anche nelle metropoli imperialistiche del 1914/2014, dove la “critica delle armi” operaia è stata stroncata costantemente nei suoi momenti più avanzati (Berlino 1919 e Amburgo 1923, l’Italia del biennio rosso 1919/20, la Spagna della lotta eroica al fascismo del 1936/39, ecc.) , gli “uomini rossi” e l’avanguardia degli operai occidentali sono riusciti per un lungo periodo, dal 1945 fino al 1979/80, a modificare e trasformare parzialmente, in modo limitato ma reale, con modalità riformistiche ma concrete, almeno i rapporti sociali di distribuzione capitalistici esistenti nei punti alti del processo di sviluppo imperialistico: visti e presenti i rapporti di forza politico militare sfavorevoli (presenza militare USA, superiorità nucleare dell’imperialismo statunitense, ecc.) i bisogni omega sono ripiegati a un livello più arretrato.
Il Welfare State, lo stato sociale e assistenziale ha rappresentato in ogni caso una notevole conquista socioproduttiva della classe operaia occidentale e degli “uomini rossi”, ottenuta attraverso grandi lotte sociali e politiche. Una conquista precaria e limitata, certo, non avendo investito e distrutto per tutta una serie di ragioni (a partire dalla forza militare della borghesia occidentale) i rapporti sociali di produzione e di potere esistenti nel capitalismo di stato reale dell’Europa, ma in ogni caso un progresso acquisito con una pratica di massa e pluridecennale , la cui importanza può essere ora meglio valutata e apprezzata in una prospettiva storica, oltre che attraverso le sofferenze materiali e concrete dei “non garantiti”, dei precari,delle famigli operaie povere del Terzo millennio (negli Stati Uniti nel 2013 una famiglia operaia su cinque ormai dipende dai food stamps, dai buoni alimentari pubblici per la sua sopravvivenza materiale),proprio analizzando la controriforma – stavo per dire cattolica – liberistica e privatizzatrice che si è via via irradiata per tutto il mondo capitalistico, partendo dal Cile del golpe sanguinario di Pinochet e dei “Chicago boys”.
Lo stato sociale ha costituito pertanto il sottoprodotto instabile di una dura lotta di classe delle masse operaie occidentali, favorite fino al 1979 anche dalla presenza dello “spauracchio sovietico” e di quell’“impero del male” (Regan) che costringeva la borghesia occidentale ad effettuare alcune concessioni parziali alle masse popolari, per evitare una pericolosa radicalizzazione politica degli operai; una conquista di cui rimangono ancora oggi, nel 2015 e all’alba del terzo millennio, sia delle parti residue materiali ancora esistenti, seppur in via di sempre maggiore ridimensionamento (si pensi solo alla guerra scatenata dal governo Renzi contro l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori), che un ricordo collettivo, una memoria storica ancora viva e ben presente in larga parte dei lavoratori e degli stessi giovani, degli stessi precari ipersfruttati operanti nelle metropoli imperialistiche, nei disoccupati e negli immigrati.
Siamo tuttora in presenza di un’orma e di una traccia socioproduttiva che ha influito sensibilmente, anche se certo non in modo decisivo né permanente, sullo stesso processo di riproduzione materiale delle formazioni economico-sociali capitalistiche, a partire dal 1914/18 in poi.
Ma non solo.
Si può dire che la stessa “linea nera” egemone all’interno delle metropoli imperialistiche, almeno nella frazione politico-sociale più lungimirante e intelligente (Keynes, Roosevelt, le direzioni delle socialdemocrazie europee fino al 1979, ecc.), ha saputo almeno in parte utilizzare le lotte, le rivendicazioni, i bisogni materiali e le passioni collettive dei lavoratori occidentali e delle loro avanguardie rosse, collettivistiche e antagoniste, allo scopo di stabilizzare e limitare la crisi generale del modo di produzione capitalistico.
Dal 1945 al 1979 si è in pratica venuto a creare e a riprodurre un particolare paradosso storico, per cui se da un lato il vero limite del capitale risulta lo stesso capitalismo, come aveva notato in modo geniale Marx nel terzo libro del Capitale,dall’altro lato lo stesso capitalismo ha in parte sfruttato e utilizzato le lotte e la coscienza collettiva dei produttori diretti e degli “uomini rossi” al fine di superare le contraddizioni interne di carattere economico del sistema, oltre che ovviamente per tener buoni gli “operaiacci” e neutralizzare l’azione politico-sociale dei “sovversivi”.
Primo paradosso storico: nella sua frazione politica più intelligente, il sistema capitalistico nel 1945/79 ha utilizzato per la sua stabilizzazione produttiva, per vedere aumentato il potere d’acquisto delle masse e ridurre la “forbice” tra lo sviluppo della produzione e la domanda solvibile di massa, proprio l’azione degli stessi “uomini rossi”, trasformando pertanto “il veleno” (rosso) “in cibo” (capitalistico).
Secondo paradosso storico: proprio la parziale, limitata ma reale soddisfazione di una parte significativa dei bisogni materiali dei produttori diretti delle metropoli imperialistiche, dal 1945 al 1979, ha via via resi più accomodanti verso il processo di riproduzione delle società capitalistiche anche la parte più avanzata di questi ultimi, neutralizzando in gran parte i loro bisogni omega e isolando i “rossi” , la frazione irriducibile e antagonista dei lavoratori e dei giovani. Per fare un solo esempio, quella classe operaia italiana che tra il 1943 e il 1948 era pronta nella sua maggioranza politica a “dare l’assalto al cielo”, mitra alla mano e almeno fino all’attentato a Togliatti nel luglio del 1948, nel 1973/79 invece sostanzialmente accettò persino la disastrosa linea politica del “compromesso storico” perseguita con ottusa e autodistruttiva ostinazione dal gruppo dirigente del PCI, con la sostanziale accettazione della NATO divenuta persino uno “scudo difensivo” contro l’Unione Sovietica, ormai vista e considerata sotto una luce negativa.
Siamo in presenza di una complessa dialettica storica tra bisogni e paure sociali, tra bisogni proletari e controbisogni borghesi, di un “tiro alla fune” e di una guerra il cui esito finale risulta ancora oggi incerto e aperto, sia in senso positivo che negativo. Già nello scorso secolo , con la splendida poesia “Lode alla dialettica”, Bertolt Brecht sottolineò che:
“L’ingiustizia oggi cammina con passo sicuro.
Gli oppressori si fondano su diecimila anni.
La violenza garantisce: Com’è, così resterà.
Nessuna voce risuona tranne la voce di chi comanda
e sui mercati lo sfruttamento dice alto: solo ora io comincio.
Ma fra gli oppressi molti dicono ora:
quel che vogliamo, non verrà mai.
Chi ancora è vivo non dica: mai!
Quel che è sicuro non è sicuro.
Com’è, così non resterà.
Quando chi comanda avrà parlato,
parleranno i comandanti.
Chi osa dire: mai?
A chi si deve se dura l’oppressione? A noi.
A chi si deve, se sarà spezzata? Sempre a noi.
Chi viene abbattuto, si alzi!
Chi è perduto, combatta!
Chi ha conosciuto la sua condizione, come lo si potrà fermare?
Perché i vinti di oggi siano i vincitori di domani
E il mai diventa; oggi!”
La trama complessiva entro la quale si è via via espresso il bisogno omega nel corso dell’ultimo secolo, sempre nei punti più avanzati dello sviluppo capitalistico, risulta formata anche da altri tasselli e segmenti, secondari ma non irrilevanti.
Ad alcuni di essi si è già accennato in precedenza, come nel caso della pratica (e bisogno) collettivi delle cooperative produttive di consumo e di centri sociali autogestiti, degni di tale denominazione e non degenerati in microimprese capitalistiche, oppure nell’utilizzo comunitario libero e gratuito di Internet e del software; ma vale la pena anche soffermarsi sul vasto fenomeno della “musica rossa”, e cioè sul processo di creazione e di fruizione collettiva della musica non come fenomeno artistico fine a sé stesso, ma viceversa come particolare espressione dei bisogni di comunismo e di ribellione contro le strutture di produzione/potere classiste contemporanee.
Bandiera Rossa e l’Internazionale, certo; ma alle sonorità per così dire “classiche” del movimento operaio ante-1914, si sono aggiunte molte altre espressioni artistiche che hanno acquisito una diffusione di massa e costante, riprodotta nel tempo e non transitoria, all’interno del gigantesco popolo degli ascoltatori di musica, anche per il loro valore e contenuto politico-sociale.
L’elenco risulta lungo, anche rimanendo solo agli artisti più famosi .
Si può partire dalle canzoni impegnate di Woody Guthrie negli anni Trenta del Ventesimo secolo (“la mia chitarra uccide i fascisti”) per arrivare al primo Bob Dylan, a Woodstock nel 1969, a Arlo Guthrie e di Country Joe McDonald; ai Jefferson Airplane e al geniale John Lennon del 1970/73 (“Immagine”, ma non solo); ai Pink Floy di “Money”, “Animals” e di “The Wall” fino al punk-rock dei Clash, per non parlare poi di una parte significativa di rap afroamericano; in Italia risultano tra l’altro ancora ben vivi, e diffusi a livello di massa, i migliori prodotti di cantautori impegnati degli anni Sessanta/Settanta, oltre che dei loro emuli più famosi come Jovanotti.
Si tratta di una sorta di colonna sonora rossa e antagonista che, da alcuni decenni e fino ai nostri giorni, accompagna carsicamente il vissuto quotidiano, la memoria e la fantasia collettiva di milioni di lavoratori, di giovani e meno giovani delle metropoli capitalistiche, come del resto – seppur in maniera molto minore, sul piano qualitativo – le espressioni più avanzate sul piano politico di altre forme di arte: dalla pittura (Guernica di Picasso) alla poesia (Neruda, Hikmet, Garcia Lorca, ecc.), dal teatro (Brecht) alla letteratura, fino al cinema impegnato. Il film sovietico “La corazzata Potamkin” non ha certo costituito una “boiata pazzesca” e non è stato ancora dimenticato, al pari di molte altre opere artistiche di matrice collettivistica prodotte nell’ultimo secolo e ai nostri stessi giorni: serve ormai l’opera di un nuovo Ernst Bloch che, anche in questa sfera particolare, sappia esprimere un’estesa fenomenologia di un segmento di praxis umana al cui interno il principio speranza e lo spirito di ribellione contro le relazioni sociali classiste scorrono e si presentano carsicamente, ma con forza finora insopprimibile e come un fiume senza fine, per usare un’immagine usata dai Pink Floyd alla fine del 2014.
Capitolo quinto
“IS THERE ANYBODY OUT THERE?” (Pink Floyd)
Lotta e contaminazioni tra le due “linee” socioproduttive
Come mi aveva fatto notare tempo fa Giorgio Gattei, in sintonia con le riflessioni espresse dal compagno Fidel Castro su questo tema specifico, almeno dal 1847 e dalla legge britannica sulla limitazione della giornata lavorativa a dieci ore la formazione economico-sociale capitalistica ha spesso utilizzato, in modo deformato e parziale, alcuni e particolari strumenti socioproduttivi che appartengono storicamente alla moderna “linea rossa”, attraverso ad esempio la formazione di un parziale “stato sociale” (legge delle dieci ore e misure social-paternalistiche di Bismarck) e la pianificazione parziale e per via politica del processo produttivo, a partire dal 1914 e da W. Rathenau; e a loro volta, dalla NEP leninista del 1921, anche il moderno movimento comunista e la formazione economico-sociale socialista a modo loro si sono serviti anche di alcuni “arnesi” e strumenti socioproduttivi sviluppati via via dal capitalismo mondiale, fin dal dodicesimo secolo e dai tempi del protocapitalismo veneziano e genovese, come nei casi specifici del mercato – non “libero”, certo, ma questo è un altro discorso – della moneta e delle banche.
Almeno a partire dal 1947, in altri termini, la praxis storica mondiale ha mostrato in modo sorprendente e originale non solo la dura e costante lotta creatasi tra “linea nera” (ad esempio quella incarnata da Bismarck, mandatario politico del capitalismo tedesco 1870/1880) e “linea rossa” (ad esempio la SPD, la socialdemocrazia tedesca in pieno sviluppo e divenuta in larga parte marxista dopo il 1878 e fino al 1907/1910), ma anche il simultaneo, parziale ma interessante processo di contaminazione reciproca che si è via via formato tra le due tendenze sociopolitiche prese in esame: e cioè l’acquisizione parziale di elementi “rossi” da parte della “linea nera”, borghese, per tentare di superare le proprie dinamiche endogene di crisi, e il processo inverso di “spionaggio-acquisizione” che ha interessato dopo il 1917 e l’Ottobre Rosso anche l’alternativo e diverso sistema socialista, la prima e “immatura” (Marx, Critica al programma di Gotha) fase del modo di produzione comunista.
Siamo in presenza di tematiche importanti anche sul piano politico immediato, che tra l’altro si possono allargare in un processo a spirale prendendo in esame, da una prospettiva diversa, anche altri argomenti pregnanti quali:
- l’intervento proteiforme dello stato borghese in campo economico (“socializzazione delle perdite e privatizzazione dei profitti”, “too big to fail”, complesso militar-industriale, svendita delle aziende statali, ecc.) quale nuova principale controtendenza, dal 1940 in poi, rispetto alla caduta tendenziale del saggio di profitto e alla crisi generale del capitalismo;
- l’intervento costante della lotta di classe operaia e della “paura dei rossi” (cartismo inglese e legge del 1847 delle dieci ore per donne e bambini, SPD tedesca e determinate misure “social-paternalistiche” di Bismarck, ecc.) nel contraddittorio processo di formazione del welfare state;
- il venir meno della “paura dei rossi” da parte della borghesia dopo il 1979 come concausa dell’attacco capitalistico contro lo stato sociale occidentale, dal 1979 fino ai nostri giorni (Renzi e articolo 18/privatizzazioni, ecc.);
- il primato della sfera politica (Lenin, 1921) sull’economia anche all’interno del lungo processo di transizione del capitalismo di stato, da Walter Rathenau fino ai nostri giorni (settembre 2008 e collasso bancario, i “quantitave easing” delle iperpolitiche Federal Reserve e Banca Centrale Europea, ecc.);
- la piena comprensione della sfera politica nel senso marxiano e leninista, intesa pertanto in qualità di “espressione concentrata dell’economia” e delle lotte/rapporti di forza mutevoli tra le classi;
- la NEP leninista (1921-28) e la NEP iperaccelerata della Cina Popolare, dal 1978 in poi, come specifiche “curve di apprendimento” acquisite via via dal movimento comunista contemporaneo in campo politico-economico.
Abbiamo trovato molta carne al fuoco per i marxisti, ma ora serve un laboratorio teorico collettivo per “cucinarla” al meglio: “is there anybody out there?”
Roberto Sidoli, gennaio 2015
Ringraziamenti
Un particolare ringraziamento a Giorgio Gattei, senza il cui apporto questo libro non sarebbe venuto alla luce; e simultaneamente un ringraziamento e un abbraccio caloroso a Patrizia Vaiti, Massimo Leoni e Daniele Burgio, amici e compagni da tanto tempo.
NOTE
Fonte: www.robertosidoli.net