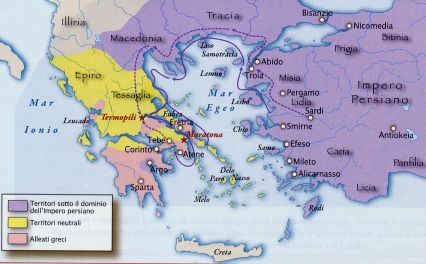LA GRECIA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Storia ed evoluzione della Grecia classica
COLONIE E MADREPATRIA NEL MONDO ANTICO
Tema di questo articolo saranno le colonie, ovvero le città fondate da altre città. Si cercherà di fare il punto sugli aspetti essenziali concernenti un tale vastissimo argomento. In particolare, cercheremo di approfondire i seguenti aspetti:
- perché una città decideva di fondare delle proprie colonie;
- come funzionavano queste ultime al loro interno;
- in particolare, perché furono fondate e come furono governate le prime colonie;
- quale relazione intercorse tra i primi mercati “internazionali” (ovvero gli scambi a lungo raggio) e il fenomeno della diffusione della cultura statale-urbana in zone fino ad allora allo stadio tribale;
- quali potevano essere gli sviluppi delle colonie.
Si cercherà così di inquadrare i caratteri salienti di un fenomeno che percorre trasversalmente, sia nel tempo che nello spazio (ovvero tanto in Occidente quanto nel Vicino Oriente), tutta la storia antica, costituendone un aspetto essenziale, alle volte (come nel caso cartaginese) ponendosi addirittura all’origine di nuove e fiorenti civiltà.
1) La fondazione delle colonie e i loro rapporti con la madrepatria
I motivi per i quali una città poteva decidere di fondarne un’altra (o più di una) erano essenzialmente di due tipi (peraltro, non necessariamente escludentisi a vicenda): l’eccesso di popolazione rispetto alle proprie capacità produttive e ai propri territori; l’esigenza di creare nuovi mercati per le proprie merci e/o di approvvigionamento di prodotti non reperibili al proprio interno o nelle zone vicine.
Come è facile immaginare, da queste differenti esigenze sorgevano di solito tipologie di colonie molto diverse tra loro (lo vedremo ancora avanti). Dal primo tipo di esigenza nascevano infatti solitamente colonie di insediamento, ovvero finalizzate a mantenere una popolazione in eccesso rispetto alla madrepatria, principalmente attraverso attività agricole e produttive, ma anche, in seconda battuta, commerciali; dal secondo tipo invece sorgevano colonie di natura commerciale, la cui economia era per l’appunto finalizzata in primo luogo (almeno inizialmente) al commercio con la madrepatria.
Un’altra distinzione, altrettanto importante rispetto alla precedente, va fatta. Il commercio antico difatti, poteva avere una base sia statale sia privata (con una serie di sfumature intermedie). Nel primo caso i mercanti erano in realtà, in sostanza, degli agenti commerciali, dotati di scarsa autonomia decisionale rispetto ai loro mandatari e responsabili: gli alti funzionari di stato (o del tempio, nel caso delle città mesopotamiche, la cui economia era in sostanza diretta dai sacerdoti) che ne dirigevano il lavoro monitorandone i risultati. Nell’altro, invece, i mercanti erano effettivamente ciò che oggi intendiamo con tale termine: liberi imprenditori che agivano in proprio, con fondi e con profitti o perdite privati. (Ovviamente si dava anche il caso di compartecipazioni tra pubblico e privato, di forme miste di impresa).
E' chiaro inoltre come, laddove a livello di organizzazione politico-sociale prevaleva la dimensione privata (stati europei occidentali), fosse quantitativamente prevalente la forma privatistica del commercio; mentre laddove (stati vicino orientali) prevaleva quella pubblica o statale, il commercio era prevalentemente organizzato in forme pubbliche o miste (ad esempio nella forma dell’appalto, nella quale i poteri pubblici assegnavano una commessa a imprenditori privati spartendo con essi profitti e rischi dell’impresa).
Possiamo quindi individuare schematicamente, sulla base di queste distinzioni preliminari, quattro tipi di colonie: (a) colonie commerciali con un’economia (e quindi anche con un’organizzazione del commercio) prevalentemente (a1) privatistica o (a2) pubblica; e (b) colonie di insediamento con un’economia prevalentemente (b1) privatistica o (b2) pubblica. Queste quattro varianti costituiranno la base della casistica che utilizzeremo qui avanti.
2) Il funzionamento delle colonie
Come gli stati, o meglio come le città-stato d’origine, anche le colonie erano delle città, più meno simili e più meno autonome rispetto alle prime.
Possiamo anzi dire, almeno in linea di massima, che somiglianza e autonomia fossero due variabili che andavano di pari passo tra loro. Più difatti le colonie erano diverse rispetto alla madrepatria, ovvero strutturalmente carenti di qualche attributo, più di conseguenza tendevano anche a esserne dipendenti politicamente. Più al contrario assomigliavano strutturalmente ad essa, più tendenzialmente erano politicamente e amministrativamente autonome.
Secondo un tale schema, possiamo dire che le colonie di popolamento furono in linea di massima le più autonome e le più simili alle città d’origine (il cui modello, pur spesso con cambiamenti legati a esigenze o scelte particolari, tendevano a replicare). Il loro scopo essendo quello di trovare un sostentamento a parte della popolazione della madrepatria, esse tendevano difatti a condurre una vita indipendente e separata da essa, nonostante gli indubbi legami affettivi e culturali (nonché commerciali) che ancora a essa le legavano. In linea di massima insomma, si può dire che, per ovvi motivi, tra questo tipo di colonie e le città fondatrici non esistessero di solito legami particolarmente forti.
Al contrario, le colonie commerciali rimanevano a lungo (se non per sempre) fondamentalmente dipendenti dalla madrepatria sul piano economico. A un tale tipo di dipendenza inoltre, poteva aggiungersene anche una di carattere politico, qualora esse, più che vere e proprie città-stato, indipendenti e autogovernate, fossero anche giuridicamente delle semplici stazioni commerciali. È il caso di molte colonie fenicie, la cui lontana origine si radicava nell’abitudine dei mercanti di fissare lungo i propri tragitti dei punti di sosta (specie notturna) sicuri e conosciuti: punti che alla lunga si trasformarono in luoghi di insediamento stabile nei quali si svolgevano, oltre a tali soste, anche scambi tra regioni lontane (i mercanti di una determinata zona infatti, giungevano in esse per scambiare, con mercanti provenienti da zone più remote, i propri prodotti) (Averardo Chierici, Il grande mercante, Mursia, pag. 167 ssg). Come facile immaginare, queste cittadelle rimanevano (almeno fino a un certo momento del loro sviluppo) legate politicamente e amministrativamente a una città più grande, che aveva dato impulso alla loro fondazione, e rispetto alla quale costituivano per così dire dei quartieri extra-territoriali, dipendendone.
Un discorso simile va fatto riguardo alle colonie più antiche, che furono fondate come zone di scambio e transito delle merci dalle città mesopotamiche in zone remote (ad esempio nelle regioni anatoliche, ricche di legname e di metalli) per permettere l’approvvigionamento di materie e prodotti di cui esse erano sguarnite. Similmente a quelle appena descritte, anche tali colonie vennero fondate, e rimasero a lungo, come “porti franchi”, empori commerciali situati in zone potenzialmente ostili, i cui abitanti erano per la maggior parte mercanti di professione inviati dalla madrepatria come intermediatori commerciali.
3) Le prime colonie della storia
Quanto a queste ultime colonie, esse ci appaiono particolarmente interessanti perché, al pari delle città-stato da cui sorsero, furono caratterizzate da un tipo di organizzazione rigidamente verticale che – almeno nella sua integralità – non si ripeté pressoché più nel corso della storia successiva.
Come noto, i primi stati della storia si svilupparono in Mesopotamia, e più precisamente nella parte meridionale di essa, detta Sumer. I villaggi agricoli infatti, prima autonomi tra loro, a un certo punto (fine del IV millennio a.C. – inizio del III) iniziarono a confederarsi e a creare unità più vaste, ruotanti attorno a un centro urbano (la cui sede, inizialmente, fu probabilmente il villaggio più grande) nel quale risiedevano i membri delle classi dei lavoratori specializzati il cui fine era fornire ‘servizi’ (intendi, lavoro non finalizzato direttamente alla produzione di cibo) atti a implementare l’attività dei centri agricoli o villaggi. Ovviamente, le comunità rurali, pur continuando a sussistere secondo le loro antiche strutture sociali, erano costrette a limitare la propria libertà sia decisionale, sia economica, fornendo alla città parte delle loro eccedenze alimentari al fine di mantenere i lavoratori in essa presenti. La città, invece, era organizzata al proprio interno sulla base di una rigida gerarchia sociale, con al vertice un potere centrale (del re o del sommo sacerdote, figure che per molto tempo rimasero indistinte) e al di sotto di esso, via via, una piramide di poteri istituzionali e funzionariali molto articolata.
Le attività che avevano luogo nei centri urbani ruotavano attorno all’artigianato (ovviamente praticato a un livello superiore, da un punto di vista tecnico, rispetto a quello che aveva luogo nei villaggi), al culto (per i popoli antichi, infatti, la benevolenza degli dei era un aspetto essenziale della vita sociale: nelle città si era quindi formata una potente casta sacerdotale), all’amministrazione pubblica (crescendo infatti il territorio dello stato, sia urbano sia agricolo, e la sua popolazione, sempre più pressanti erano le esigenze di organizzazione, registrazione, ecc.), alla pianificazione dei lavori pubblici (in particolare, in Mesopotamia, delle canalizzazioni)… e ai mercati!
Questi ultimi, che sono l’oggetto della nostra trattazione, erano essenziali al pari degli altri servizi, in quanto servivano a rifornire la comunità statale di materie prime necessarie (o in ogni caso richieste) ma non presenti sul suo suolo. I primi mercati insomma, furono senza dubbio mercati esteri, non interni.
Ma ciò che ci interessa qui non sono i mercati in sé (d’altronde, le prime vie di mercato – legate soprattutto al commercio dell’ossidiana – capaci di collegare regioni molto lontane tra loro erano antichissime e risalivano alle volte anche a 30.000 anni prima di Cristo) bensì le colonie commerciali fondate da tali centri urbani per favorire e rendere possibili i propri traffici.
Come già accennato, più che città-stato, queste colonie furono delle mere stazioni di commercio, ovvero centri semi-urbani che riproponevano, seppure in forma decisamente ridotta, l’organizzazione statale della madrepatria, con la differenza rispetto a essa di non costituire unità amministrativamente e politicamente autonome.
Come la madrepatria, esse avevano una zona agricola nella quale veniva prodotto il surplus necessario a mantenere le élite urbane. Ciò perché oggetto dei traffici con le zone circostanti, abitate da popoli indigeni non ancora giunti alla fase urbana, non erano in linea di massima prodotti alimentari, ma materie prime (rame, stagno, legname, ecc.) che in gran parte venivano poi portate alla città d’origine. Ne consegue che, per sopravvivere, i coloni dovessero provvedere al pari della madrepatria al proprio sostentamento agricolo. Almeno all’inizio, anche i contadini furono elementi provenienti dalla madrepatria e la città colonica fu quindi una piccola isola composta da individui di un’altra zona, che parlavano una propria lingua, avevano i propri dei…
Le attività che si svolgevano in città erano poi presumibilmente analoghe a quelle cha avvenivano nelle città d’origine, anche se ovviamente con un maggiore sviluppo delle attività di mercato (con gli indigeni) e senza che vi fosse un sovrano indipendente, dal momento che questo risiedeva nella città fondatrice. Al più, la colonia poteva avere un reggente, dipendente dal re vero e proprio.
Molto interessante, e anzi centrale, è qui la trattazione del rapporto esistente tra madrepatria e colonie dal punto di vista economico. Le colonie infatti, erano essenzialmente degli intermediari tra la madrepatria e le zone circostanti, e il loro compito era di scambiare i prodotti artigianali forniti dalla madrepatria (ma presto prodotti anche in loco, seppure tramite le materie fornite dalla prima) con le materie prime di cui erano ricchi i territori degli indigeni. Una volta ottenute queste ultime, compito dei mercanti era, in certi periodi dell’anno, portarle in patria. In cambio di tale lavoro, la madrepatria ricompensava questi mercanti al pari dei funzionari urbani. Essi erano quindi funzionari del potere statale come qualsiasi altro lavoratore dello stato d’origine. In questo, appunto, queste prime colonie riflettono la natura arcaica e ancora totalmente centralizzata delle prime società statali e urbane della Mesopotamia.
Una differenza rispetto ai lavoratori della madrepatria sta tuttavia nel fatto che questi mercanti, vivendo a grandi distanze, non potevano essere pagati con alimenti, in quanto questi sono inevitabilmente facilmente deperibili. Essi erano quindi, probabilmente, compensati con altri manufatti (strumenti di lavoro, oggetti di lusso), che in parte potevano utilizzare per sé e in parte potevano scambiare con gli indigeni, creando così un mercato proprio, cioè non finalizzato a soddisfare le esigenze della madrepatria.
Torneremo tra poco (nel prossimo paragrafo) sul tema del valore che questi manufatti potevano avere per le popolazioni “primitive” con cui queste popolazioni evolute entravano in contatto, e quindi sul particolare valore economico che essi acquisivano in determinate circostanze. Per ora limitiamoci a osservare che, col tempo, collo svilupparsi delle forze produttive (artigianato e mercati) diventerà sempre più difficile per lo stato centrale esercitare un controllo rigoroso su di esse, e ciò ovviamente favorirà la nascita in queste società altamente statizzate di una prima forma di iniziativa economica privata o semi-privata – e ciò anche se va detto che l’autorità centrale resterà in esse sempre molto forte e continuerà a esercitare un ruolo essenziale a livello sia politico che economico.
Ovviamente, se la madrepatria non riusciva a esercitare un controllo sulle attività che si svolgevano all’interno dei suoi territori, è chiaro che ancora meno essa potesse esercitarlo nei confronti di attività che si svolgevano a centinaia di chilometri di distanza. Per questo le colonie, se non furono spazzate via prima (dalle popolazioni locali, da popoli invasori, o da altri fattori) o semplicemente non decaddero o non furono abbandonate, nel corso dei secoli conobbero spesso rispetto alla madrepatria un destino autonomo sul piano sia politico, sia economico, diventando a volte centri di potere più ricchi e importanti delle stesse città che le avevano fondate (anche su questo punto torneremo avanti).
In ogni caso, nelle loro fasi iniziali, queste colonie furono semplici stazioni di transito e scambio di merci destinate a rifornire delle zone lontane, e la loro caratteristica essenziale furono le ridotte dimensioni e una struttura “a fortino” intesa a difenderle dall’ostilità delle popolazioni circostanti. Sono un esempio di questo tipo di realtà le più antiche strutture urbane delle zone anatolica e siriaca (III millennio a.C.), laddove tuttavia col tempo “con la seconda urbanizzazione (quella del Bronzo Antico III) […] oramai pienamente integrate sul piano economico, etnico e politico con l’entroterra agricolo, [tali città] potranno godere di una maggiore stabilità e anche acquistare una più precisa caratterizzazione regionale.” (M. Liverani, L’origine delle città, Editori Riuniti, pag. 64).
4) I commerci come fattore della diffusione urbana
Sin qui abbiamo parlato delle colonie, ora vorremmo soffermarci su un altro argomento a questo strettamente legato, il ruolo cioè che esse ebbero nel favorire la diffusione della cultura statale e urbana nelle zone di traffico. Il processo di urbanizzazione di tali regioni infatti, fu determinato da due fattori concomitanti: il primo e più generico, fu l’influenza che la cultura superiore dei coloni esercitò sulle popolazioni indigene, ancora a uno stadio tribale e di villaggio, e che spinse queste ultime a emularne volontariamente l’organizzazione politica e sociale; il secondo fu decisamente più complesso e si basò sulle trasformazioni interne conosciute gradualmente da tali società in conseguenza dei contatti instaurati con i coloni.
Non è difficile immaginare l’effetto che facevano su una società meno evoluta gli oggetti di scambio forniti dai coloni. Gli scambi tra indigeni e coloni si basavano infatti, come detto, almeno inizialmente, sui prodotti d’artigianato dei primi contro le materie prime dei secondi ed erano fortemente sbilanciati a favore dei primi. Probabilmente gli oggetti che questi fornivano alle popolazioni originarie assumevano per esse un forte valore simbolico, di prestigio, tanto da conferire a coloro che fungevano da intermediatori un ruolo sociale di spiccata preminenza, che andava oltre le stesse appartenenze tribali e si poneva al di sopra delle logiche dell’organizzazione tribale o di villaggio.
A questo si aggiunga che, col tempo, anche gli indigeni iniziarono a sviluppare una classe di artigiani specializzati, in grado di lavorare le proprie materie prime e di fornire ai propri acquirenti oggetti già lavorati (in particolare, le popolazioni primitive si specializzarono nella fusione del metallo, cosa molto vantaggiosa per i mercanti mesopotamici, che non erano perciò costretti a trasportare grandi e pesanti quantità di minerale, ma più comode e leggere barre di metallo già colate).
A partire dal fenomeno del commercio insomma, anche queste popolazioni iniziarono a sviluppare una vasta classe/casta di lavoratori privilegiati in quanto specializzati che, grazie al proprio prestigio sociale, si pose al di sopra dei membri della comunità agricola, della quale divenne col tempo guida. Anche qui, come in Mesopotamia, assistiamo così alla nascita e allo sviluppo di centri urbani sedi di poteri superiori a quelli dei villaggi agricoli autogestiti: in altri termini alla nascita delle prime strutture urbane.
Si deve notare tuttavia, come vi sia una differenza essenziale tra questi centri urbani di “seconda generazione” e quelli “di prima”. In Mesopotamia infatti, la città nasce dalle campagne, che in essa – o meglio nel lavoro specializzato – cercano sostegno: la città sorge cioè per servire la campagna, anche se col tempo (grazie al fattore carismatico e all’uso della forza militare) il rapporto si rovescia e la città diviene in sostanza sfruttatrice della campagna, tanto che questa perde gran parte, se non tutti i vantaggi economici che derivano dal suo apporto (intendi: i vantaggi che le derivano sono ampiamente compensati dai servizi che essa deve rendere alla città, in termini di tassazione e di corveé!).
Al contrario, qui la città sorge sotto l’impulso del commercio, che ne costituisce in gran parte l’origine. La vita sociale urbana deriva il suo potere sin dall’inizio dal prestigio derivante ai suoi membri dalla vicinanza e dal contatto con una società evoluta, dall’accesso facilitato alle sue merci e al suo sapere. I membri delle classi urbane comandano dunque sulle campagne, non in quanto al servizio di esse, ma in quanto superiori ad esse. Ed è il concetto di ricchezza, di valore di scambio (i prodotti dei coloni sono dotati infatti di grande valore) il fulcro stesso del loro potere sociale.
In altri termini, la casta urbana nasce qui già come una casta parassitaria, di dominatori puri. Col tempo, chiaramente, essa assume (come in Mesopotamia) anche ruoli dirigistici e funzionali rispetto al resto della società, di carattere ancora rurale, ma questo non basta a riempire il solco che la separa dalla popolazione agricola, un solco che è ancora più profondo di quello che caratterizza le società urbane mesopotamiche.
Da ciò, di nuovo, il carattere fortificato delle città anatoliche (spesso cittadelle arroccate sulle alture dei monti), sorte chiaramente sotto l’impulso e l’influenza delle colonie di Uruk e degli altri centri sumerici. Non a caso, le città e le società urbane anatoliche del periodo pre-ittita sono caratterizzate dalla presenza di un’aristocrazia che vive in primo luogo del commercio dei metalli (un carattere che in seguito sarà proprio anche delle società ittite) e attraverso il quale acquisisce i mezzi necessari a costruire le armi, strumento indispensabile per l’asservimento delle popolazioni agricole.
Ma questa vicenda genetica, pur tipica di queste società urbane “di seconda generazione”, serve anche a chiarire il ruolo che ebbe (e certamente non solo qui, ma anche nelle società mesopotamiche) il possesso dei prodotti “di lusso” nel favorire il processo di differenziazione sociale e con esso, implicitamente, quello di specializzazione del lavoro che costituì la base e l’essenza stessa della nascente cultura statale. Anche in Sumer difatti, la ricchezza materiale tendeva a concentrarsi nelle mani delle popolazioni urbane e l’introduzione di beni di lusso e dell’idea stessa del valore di scambio (ciò che è pregiato infatti, ha un grande valore di scambio sul mercato) contribuì non solo a rimarcare la distanza tra poveri e ricchi ma anche a istituire una gradualità di prestigio e potere sociale.
5) I possibili sviluppi delle colonie
Un altro argomento interessante da affrontare è il destino delle colonie, in particolare la possibilità che, col tempo, esse si sviluppassero al punto da divenire più potenti delle città fondatrici, o in ogni caso da poter competere con loro sul piano economico e politico.
Seguendo la nostra casistica, possiamo dividere il nostro argomento in due parti: le colonie di popolamento da una parte e quelle commerciali dall’altra.
Riguardo alle prime, possiamo osservare come esse giungessero a volte a un grado di prosperità superiore alla città d’origine. Né ciò deve stupire, dal momento che, date le proprie intrinseche esigenze di popolamento, questi nuovi stati venivano di solito fondati in zone quanto più possibile fertili e ricche di materie prime e traevano di solito ulteriore vantaggio dalla vicinanza di popolazioni meno evolute con cui potevano perciò instaurare rapporti commerciali largamente favorevoli (è il caso questo, di molte colonie greche sorte in Italia meridionale tra VIII e VI secolo a.C.).
Anche le colonie commerciali giungevano spesso a un grado di prosperità tale da eguagliare o surclassare la madrepatria (un esempio a questo proposito, su cui torneremo tra poco, è costituito da Cartagine), ma ciò ci appare in un certo senso più degno di nota, dal momento che esse nascevano (anche qualora fossero sin dall’inizio politicamente autonome) essenzialmente come punti d’appoggio e di transito per i traffici della madrepatria, attorno a cui (quantomeno inizialmente) inevitabilmente gravitavano.
Come poteva avvenire allora una simile emancipazione? Attraverso quali meccanismi la colonia poteva superare la propria originaria condizione di dipendenza (di fatto, se non giuridica) rispetto alla madrepatria?
Essenzialmente i meccanismi erano due, e la loro azione poteva essere singolare o combinata. Da una parte la colonia poteva estendere i propri confini e quindi la propria potenza economica a livello regionale (la crescita territoriale andava di solito di pari passo con quella della popolazione: fattori che comportavano entrambi una maggiore capacità produttiva e quindi maggiori commerci sia in entrata o import, sia in uscita o export), dall’altra essa poteva inserirsi sulla traiettoria di nuovi traffici, oltre a quelli che la madrepatria aveva voluto intercettare attraverso la sua fondazione (e ciò sia per ragioni fortuite, sia per la propria capacità di sfruttare canali di scambio già esistenti o crearne di nuovi).
Un esempio mirabile di questo tipo di evoluzione è costituito da Cartagine, colonia fenicia fondata nel IX secolo a.C. che col tempo divenne il centro economico (e in seguito anche politico e militare, con la fondazione dell’Impero cartaginese) di una vastissima area di città d’origine fenicia sia europee che africane prima essenzialmente dipendenti dalle città della costa siriana (Tiro e Sidone in primis).
Fondata appunto nel IX secolo a.C. da Tiro, per ragioni sia commerciali che di sovrappopolamento, Cartagine illustra bene in concreto i meccanismi sopra descritti. D’altronde, le ragioni della sua affermazione non furono legate solo a fattori intrinseci ma anche alla decadenza delle città fenicie della costa siriana, causata dalla loro annessione all’impero assiro nell’VIII secolo, cui fecero seguito i Babilonesi e poi i Persiani.
In ogni caso Cartagine poté beneficiare, oltre che del fatto di collocarsi in un punto di interscambio essenziale per i traffici tra est (soprattutto la Siria, che a sua volta commerciava con Egitto e Mesopotamia) e ovest (nord Africa, Spagna e Francia) e di essere punto di arrivo delle merci provenienti dall’Africa interna, anche di una vasta area agricola circostante, nella quale infatti si estese col crescere della prosperità e della popolazione. Per tale ragione, a differenza delle città fenicie vere e proprie, essa possedeva non solo un vasto potere commerciale ma anche un ampio territoriale e militare (la sua vasta popolazione infatti poté fornirle anche molti soldati, necessari per la propria affermazione a livello politico e militare).
Così, mentre le ricche ma relativamente anguste città-stato siriane caddero preda dell’imperialismo straniero, Cartagine al contrario beneficiò di una spirale di crescita nella quale i fattori commerciali, territoriali e politici si sostennero a vicenda, fino a divenire la capitale di un impero economico vastissimo, molto più estesa e popolosa dell’altra nascente potenza mediterranea, quella romana.
Anche le colonie greche italiche del resto, conobbero (e già dai primi periodi, data la grande distanza) uno sviluppo autonomo rispetto alle città della madrepatria, tanto che la loro storia seguì un percorso parallelo ma fondamentalmente indipendente da esse. Tuttavia, nonostante i propri sviluppi e la propria indiscutibile prosperità, la Magna Grecia non poté mai rivaleggiare con la Grecia sul piano della potenza e dell’influenza internazionale, ostacolata come fu dalla rivalità con i Cartaginesi, gli Etruschi e le popolazioni italiche per il predominio della penisola italiana e delle coste occidentali in genere.
Spesso, tuttavia, le colonie ostacolarono, anziché favorirle, le mire di potenza delle stesse città che le avevano fondate, divenendo a loro volta un centro di irradiazione non solo di nuovi e fiorenti commerci ma anche di nuove colonie… Ma questo, si sa, è il carattere fondamentale della storia: una continua evoluzione, un continuo rivolgimento.