LA GRECIA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Storia ed evoluzione della Grecia classica
LA STRUTTURA DEGLI STATI ELLENISTICI
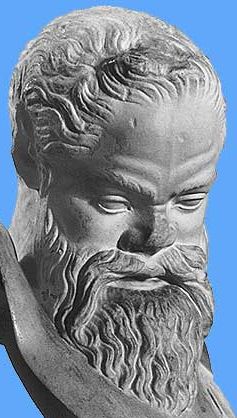
Alessandro il Grande aveva fornito ai Greci e ai Macedoni (loro alleati in guerra nonché dominatori, dal tempo in cui suo padre, Filippo II, li aveva soggiogati) un immenso territorio su cui estendere le proprie influenze politiche, i propri interessi economici e i propri stili di vita: un territorio che si spingeva ben oltre i confini dell’Impero persiano, che dalla Tracia e – almeno fino a qualche decennio prima – dalla Macedonia giungeva fino alle regioni antistanti all’India occidentale.
La morte prematura e inaspettata di Alessandro, avvenuta poco dopo il termine (senza dubbio provvisorio) delle sue imprese di conquista, aveva decretato il definitivo collasso del fragile impero da lui creato (nelle sue intenzioni, prosecuzione di quello persiano) e la sua frammentazione in parti minori, dai confini sempre incerti e instabili.
Erano poste così le premesse di un lungo periodo storico, chiamato Ellenismo, le cui caratteristiche essenziali sarebbero state da una parte la dominazione greca e occidentale su buona parte del territorio prima persiano, e dall’altra la formazione di Regni in costante rivalità per il possesso di porzioni di quello che un tempo era stato l’Impero alessandrino.
Non intendiamo qui occuparci della storia di questi Regni, ovvero della storia ellenistica, il termine della quale si pone di solito (in modo un po’ arbitrario) con l’annessione di gran parte dei territori ellenistici al grande Impero romano (un fenomeno che ebbe inizio nel II secolo a.C.), quanto piuttosto della loro struttura interna, senza entrare nello specifico delle loro differenze.
Cruciale, nella nostra trattazione, sarà la trasformazione che durante il periodo ellenistico gli stati asiatici (prima persiani) conobbero sotto la pressione della dominazione occidentale, e quella che parallelamente gli stati occidentali (non solo le città-stato greche) conobbero per influenza e in direzione delle strutture statali asiatiche.
Vedremo infatti che, se l’Oriente fece propri alcuni aspetti essenziali della vicina civiltà occidentale, quest’ultima a sua volta fece propri molti aspetti delle civiltà e del tipo di organizzazione tipicamente orientali. L’Ellenismo quindi, costituì il primo esempio di fusione e reciproca integrazione tra mondi rimasti, fino ad allora, tendenzialmente contrapposti.
Oltre
a ciò, vedremo come durante l’Ellenismo prendessero
forma molti aspetti non solo della successiva civiltà romana,
ma anche dell’odierna civiltà capitalistica
globalizzata: in particolare la separazione sempre più netta
tra una ristretta minoranza di ricchi e una vasta maggioranza di
“proletari”, ovvero di cittadini espropriati dei mezzi
alla base del proprio lavoro, ridotti in schiavitù o comunque
in una condizione di subalternità rispetto ai primi.
LA NATURA DEGLI STATI ELLENISTICI
Per cogliere le peculiarità sociali e politiche del mondo ellenistico, dobbiamo innanzitutto analizzare, seppure molto velocemente, i caratteri salienti della società greca e più in generale europea occidentale, e quelli – da questi davvero molto distanti – delle società asiatiche e più in generale extraeuopee. Questo perché, come già si è detto, l’Ellenismo fu in gran parte il risultato dell’incontro e della reciproca contaminazione tra queste diverse, e opposte, tradizioni politico-culturali.
a) Stati asiatici
Quella delle regioni vicino-orientali viene solitamente descritta e definita come un’“economia di stato”. Essa era infatti accentrata e diretta dalle più alte cariche statali, il che significa dal sovrano e dalla corte, sulla base di un’organizzazione verticistica fortemente burocratizzata che aveva nei poteri locali i propri intermediari.
In un libro dello Pseudo-Arsitotele un tale tipo di economia veniva definita, in modo senza dubbio pertinente, “regia” o “satrapica”. Essa si fondava infatti sulla riscossione periodica di tributi da parte dello stato e dei suoi funzionari locali (i satrapi, appunto). Gli apparati statali, dal canto loro, fornivano ai sudditi dei servizi cui, da soli, essi non avrebbero potuto facilmente provvedere, cosa che giustificava la pressione tributaria a loro carico.
Un esempio di tale tipo di organizzazione ci viene fornito dallo stato egizio o dalle città-stato mesopotamiche (presto peraltro costituitesi in Imperi di più grandi dimensioni). In entrambi i casi lo stato si occupava degli impianti necessari all’irrigazione del campi, coordinandone la realizzazione e la manutenzione, e rendeva così possibile uno svolgimento efficiente e ottimale delle attività agricole. Al tempo stesso però, esso pretendeva dai propri sudditi, che da tali opere traevano vantaggio, dei tributi non solo in natura, ma anche alle volte – almeno da che essa fece la sua comparsa – in moneta: tributi che avevano come scopo sia quello di mantenere i vasti apparati burocratici dello stato con il loro stuolo di funzionari, sia di glorificare con opere monumentali (quali le piramidi egiziane o gli ziggurat sumerici) l’autorità somma del sovrano.
In questi sistemi, le terre erano formalmente tutte (o quasi) proprietà del re, mentre i ‘satrapi’ (coloro cioè che esercitavano il potere su una certa porzione del territorio statale) governavano per conto del sovrano seguendone le direttive. Essi dunque, anziché “piccoli sovrani” locali (come i feudatari del Medioevo europeo) erano in ultima analisi dei meri funzionari statali, seppure di altissimo livello, e come tali costituivano la lunga mano del potere regio sulle varie province.
Quanto infine alla grande massa della popolazione, essa viveva in villaggi che, pur dotati di una discreta autosufficienza produttiva (self-sustaining), già conoscevano il commercio con i propri vicini attraverso la reciproca apertura dei mercati e, talvolta, attraverso l’opera di mercanti di professione che si spostavano da un luogo all’altro su mandato della propria comunità.
Cruciale era, inoltre, il ruolo svolto dal commercio sulle grandi distanze, ovvero tra stato e stato (che spesso peraltro assumeva la forma di dono rituale tra sovrani…). Tali traffici, controllati appunto dallo stato e non certo dalle piccole comunità di villaggio, potevano svolgersi sia attraverso l’intermediazione di una casta di mercanti professionisti, sia attraverso l’opera di popoli (come ad esempio i Fenici) che del commercio sulle lunghe distanze avevano fatto la propria specializzazione e una delle principali fonti di guadagno.
Nel complesso, ancora al tempo dell’invasione e della conquista di Alessandro Magno, l’economia dei vicini stati mediorientali (oramai da alcuni secoli assoggettati all’imperio del popolo persiano) era dunque caratterizzata da un basso grado di sviluppo dell’iniziativa privata, ovvero da una decisa prevalenza economica dello stato (del Re) a livello globale, e dei villaggi o piccole comunità a livello locale. Un’imprenditoria privata e ‘anarchica’, priva cioé di limitazioni da parte di poteri superiori era, seppure forse non del tutto assente, un aspetto comunque marginale nella vita di tali regioni. In questo – come vedremo – l’Asia si distingueva nettamente, non solo economicamente ma anche culturalmente, dalle vicine regioni occidentali (e in particolare dalla Grecia).
b) Stati occidentali
Molto differenti da quelle appena descritte erano, pur nella loro reciproca diversità, le società occidentali: in esse infatti il potere direttivo dello stato (ovvero del re) era, soprattutto se messo a confronto con le vicine regioni asiatiche, “debole”.
La concezione occidentale del potere non contemplava infatti (se non in circostanze eccezionali) la possibilità di un predominio assoluto di un membro della comunità sugli altri. Al contrario, dalle oligarchie o aristocrazie (sistemi basati sul predominio politico di una minoranza nobiliare) fino alle democrazie (esito peraltro di un lungo percorso storico, avvenuto per la prima volta in Grecia), il potere politico era il frutto della concertazione tra un numero più o meno ristretto di individui spesso sottomessi a un unico sovrano, i poteri del quale però, se paragonati a quelli dei despoti orientali, erano quasi irrisori. Il sovrano si poneva infatti, rispetto ai membri della nobiltà, essenzialmente come un primus inter pares, svolgendo solitamente il ruolo di arbitro nelle loro contese, né quasi mai le sue decisioni avevano per questi un carattere vincolante e insindacabile.
Composto e governato da cittadini anziché da sudditi, lo stato occidentale contemplava la proprietà privata delle terre, che anzi era largamente preponderante su quella pubblica. I cittadini erano dunque qui proprietari dei suoli su cui risiedevano e avevano per tale ragione la possibilità di svolgere attività economiche autonome. Col tempo inoltre, si era sviluppata una vita cittadina di carattere non solo politico (…le città essendo da sempre sede delle decisioni politiche della classe dei liberi, ovvero appunto dei proprietari di terre) ma anche artigianale e proto-industriale.
Con lo sviluppo economico delle città inoltre, sempre più vaste divennero le attività commerciali (anche quelle mercantilistiche, cioè di grande portata) che andarono ad affiancarsi alla più antica economia di consumo tipica delle campagne e che, cosa non trascurabile, ebbero sin dall’inizio un carattere privatistico anziché (come invece negli stati asiatici) statalistico o comunque comunitario.
Certo, solo in alcune regioni, in particolare in quelle di cultura ellenica, la vita cittadina – e con essa le classi mercantili e artigianali – si sviluppò in modo davvero consistente. In Grecia, ad esempio, uno dei fattori (anche se non l’unico, né il principale) che spinse molti cittadini a sostenere i progetti di conquista di Alessandro Magno verso i vicini regni asiatici, fu l’interesse a trovare nuovi sbocchi commerciali e a implementare i propri guadagni.
Altri stati invece (quali ad esempio la Macedonia, l’Epiro o la Tracia) rimasero fondamentalmente vincolati a un’economia agricola e a una struttura sociale gentilizia o nobiliare, ovvero - potremmo dire per analogia con il Medioevo cristiano - “feudale”. In tali regioni, il potere del sovrano e dello stato centrale rimanevano fortemente limitati da quello della nobiltà e il territorio fondamentalmente frazionato tra i domini di quest’ultima. Ciononostante, l’influenza culturale ed economica esercitata dal vicino mondo greco favorì anche in questi paesi lo sviluppo dei traffici e delle città, e con essi quello di istituzioni statali centrali (regie) capaci di limitare in modo consistente l’autonomia e il peso politico della nobiltà (esempio di un tale tipo di processo, fu la riforma dello stato macedone posta in atto dal sovrano Filippo II, padre di Alessandro Magno, condizione di possibilità della successiva conquista della Grecia).
c) Stati ellenistici: organizzazione sociale e ruolo dello stato nell’economia
Preso atto di queste due diverse matrici politiche ed economiche (europea l’una, extra-europea l’altra), veniamo ora ai Regni ellenistici. In essi tali tradizioni vennero in qualche modo a convergere, non per un calcolo preordinato ma in ragione della fusione di due universi rimasti fino ad allora separati, con la nascita di un mondo omogeneo, almeno dal punto di vista dei popoli dominatori, che dall’estremo est (India occidentale) giungeva fin oltre le regioni balcaniche.
In particolare, attraverso dinamiche che descriveremo qui avanti, gli stati prima persiani svilupparono, sotto l’influsso delle élite politiche e culturali occidentali, una vita economica (sia mercantilistica, sia industriale) ad esse in precedenza sconosciuta, mentre le regioni occidentali (Grecia esclusa) si organizzarono in stati di più vaste dimensioni e istituzionalmente più solidi. Tanto nelle regioni a est quanto in quelle a ovest inoltre, si ritrovano, seppure certamente in modi e gradi differenti, analoghe forme d’alleanza tra i grandi possidenti terrieri, e più in generale i grandi poteri economici, e i membri del funzionariato di stato: un fatto – come vedremo – basilare nell’organizzazione sociale ed economica del mondo ellenistico.
Senza
dubbio inoltre, se consideriamo che l’”Occidente
ellenistico” comprende i Balcani, la Grecia e regioni come la
Tracia (situata subito a nord est di quest’ultima), mentre
l’”Oriente” partendo dall’Egitto arriva, se
non fino all’India, quantomeno fino all’attuale Iran
(l’antica Persia), possiamo dire che l’Ellenismo fu un
fenomeno più orientale che occidentale. Esso fu infatti
principalmente il prodotto dell’esportazione di stili di vita e
di pensiero greco-occidentali nelle adiacenti regioni asiatiche, e
solo in modo più marginale il prodotto dell’influenza
della cultura asiatica sulle vicine regioni occidentali. Cominceremo
quindi la nostra esposizione dagli stati asiatici, dedicando
all’Occidente europeo uno spazio decisamente inferiore.
Tra gli stati ellenistici orientali, quello il cui funzionamento conosciamo meglio e più a fondo è, senza alcun dubbio, l’Egitto. Anche se restano aperti profondi interrogativi sul tipo di società sorta in conseguenza della conquista occidentale, molto evidente appare qui l’alleanza tra le classi imprenditoriali greco-macedoni e il funzionariato statale.
Ciò che fu vero in generale un po’ per tutto il mondo ellenistico orientale, e cioè che i coloni occidentali goderono di speciali agevolazioni, fu per l’Egitto ancora più vero. In una tale area difatti, i poteri dirigistici dello stato si erano mantenuti più saldi che nella maggior parte delle altre regioni asiatiche. Una volta insediatisi ai vertici del potere, dopo la conquista del paese, i greco-macedoni ebbero dunque, qui ancor più che altrove, buon gioco a favorire con decreti e provvedimenti ‘dall’alto’ l’insediamento dei propri connazionali ai vertici sia della vita economica che di quella politica e istituzionale.
Se difatti, sul versante politico, i conquistatori occidentali finirono quasi sempre per ricoprire le più alte cariche amministrative, su quello economico e sociale la cessione a essi di buona parte delle terre del sovrano (che avveniva di solito nella forma dell’appalto, ovvero a condizione del pagamento di interessi allo stato) favorì l’incremento delle ricchezze e lo sviluppo di un’imprenditoria occidentale anche in queste regioni. Né va dimenticato che, per i greci e i macedoni, venivano di solito ritagliati degli spazi particolari e riservati, attraverso la fondazione di città-stato che godevano di grandi autonomie nei confronti dei poteri del sovrano e che tendevano a ricreare le condizioni politiche delle loro regioni d’origine.
Certo, come si è già ricordato, negli stati asiatici il sovrano concedeva da sempre ai suoi funzionari la gestione di ampie porzioni del proprio territorio. Ma non si deve dimenticare che i popoli occidentali – e i Greci in particolare – avevano, nel corso dei secoli, sviluppato tecniche produttive decisamente all’avanguardia per la propria epoca e, assieme a esse e anche come conseguenza della loro elevata produttività, un’economia mercantile di gran lunga più florida rispetto a quella, di solito gestita dallo stato, delle regioni orientali. La pratica antica della concessione delle terre regie a singoli individui, quindi, assunse con la dominazione greca e occidentale dei risvolti che non aveva mai avuto prima. Essenzialmente tali risvolti furono: a) uno sfruttamento più intenso dei suoli; b) lo sviluppo di un’economia di tipo cittadino, ovvero artigianale e imprenditoriale, in contrapposizione a quella eminentemente agricola dei villaggi (un fenomeno che, ovviamente, era già iniziato prima dell’insediamento degli occidentali, ma che fu da questi potentemente incrementato); c) la crescita esponenziale dei mercati sia interni sia internazionali (le eccedenze di beni prodotti infatti, erano in gran parte finalizzate agli scambi commerciali).
Gli occidentali portarono dunque con sé un decisivo incremento della produzione attraverso l’esportazione di nuove tecniche agricole e di più avanzate forme di divisione del lavoro, e un altrettanto decisivo incremento del commercio e dell’uso della moneta. Il tutto in un quadro di sviluppo sia dell’economia cittadina che di quella agricola.
Se questi furono a grandi linee i risvolti economici della colonizzazione greco-macedone delle regioni ellenistiche orientali, non si devono però assolutamente trascurare gli aspetti politici e istituzionali di tale evento, anche perché – come si è già detto – essi furono condizioni di esistenza essenziali per gli sviluppi economici appena descritti.
Abbiamo appena visto come – soprattutto in Egitto – gli enormi poteri dirigistici dello stato furono in gran parte utilizzati dalle élite coloniali per favorire l’esportazione dei propri stili produttivi e della propria stessa idea di società, ma non abbiamo ancora parlato dei vantaggi che la macchina statale (ovvero il complesso dei suoi funzionari, da sempre casta egemone ed economicamente privilegiata, nelle cui mani stavano le redini dello stato) traeva da queste trasformazioni.
Da sempre gli stati asiatici avevano una struttura tributaria, basata cioè sulla riscossione periodica di tributi dai propri sudditi. In questo, l’economia ellenistica non apportò cambiamenti sostanziali alla precedente organizzazione. Ma prima di tale periodo, la quantità di beni prodotti e quindi di surplus tassabile, era molto probabilmente inferiore. Ora invece, la crescita della produzione aveva determinato maggiori possibilità di arricchimento anche per gli apparati statali. Inoltre, come se ciò non bastasse, la pressione tributaria si fece più forte anche in proporzione all’accresciuta capacità produttiva. Così come, del resto, aumentò il lavoro richiesto dai grandi proprietari (in realtà appaltatori delle terre pubbliche) alla forzalavoro locale: una condizione indispensabile per far crescere la produttività!
Gli stati ellenistici tuttavia, oltre che dal fatto di incassare più ricchezze furono caratterizzati dal fatto di dover sostenere maggiori spese rispetto al passato. I loro apparati infatti, conobbero una notevole crescita, soprattutto in conseguenza della situazione venutasi a creare (e presto divenuta cronica) con lo smembramento del regno alessandrino in tanti sotto-regni in costante conflitto tra loro. Soprattutto un tale stato di guerra pressoché ininterrotta determinò delle spese militari prima impensabili, e con esse l’esigenza di un apparato di controllo delle proprietà ai fini della loro tassazione molto più articolato e complesso che in precedenza (fu in epoca ellenistica, ad esempio, che venne inventato il catasto…).
Anche la macchina governativa poi, crebbe notevolmente in complessità: ad esempio, venne creato una sorta di ministero delle finanze e dell’economia (retto da un funzionario chiamato dioketes) preposto alla contabilità statale nonché – probabilmente – all’istituzione di politiche economiche (si parla a volte per quest’epoca, non senza un po’ di esagerazione, di “dirigismo statale” in economia).
In conseguenza del nuovo splendore delle attività commerciali, anche e soprattutto nei traffici con gli altri paesi, i dazi doganali (sia monetari, sia in natura) conobbero poi una vera e propria impennata: gli stati infatti, capirono presto di poter trarre da tali traffici dei considerevolissimi guadagni e agirono di conseguenza. Altre fonti di arricchimento rimasero poi quelle tradizionali, legate alla tassazione (soprattutto in natura) delle attività agricole e delle transazioni interne.
Per farsi un’idea della situazione creatasi nel periodo ellenistico, possiamo dire che le grandi metropoli (ad esempio, Alessandria d’Egitto), che in tale periodo sorsero in gran numero o che comunque crebbero molto di dimensione, si dotarono di grandi arterie di traffico e di grandi mercati popolari, per il rifornimento alimentare della propria vasta popolazione. Si creò insomma, una civiltà metropolitana molto simile, anche ‘visivamente’, a quella europea moderna.
Una tendenza negativa per lo sviluppo dei mercati e delle attività produttive (i presupposti della quale risiedevano peraltro nelle tradizioni economiche e politiche delle civiltà stataliste asiatiche) fu quella all’appropriazione da parte dello stato delle produzioni e dei traffici economicamente più remunerativi.
Quello dei monopoli fu un vero e proprio flagello per l’economia degli stati ellenistici! I governi di questi ultimi difatti, ad un certo punto della loro storia, ‘scoprirono’ che, più ancora che coi tributi dei privati cittadini, avrebbero potuto arricchirsi assumendo essi stessi d’ufficio lo svolgimento delle attività imprenditoriali di questi ultimi. Ovviamente, il fatto che lo stato fosse - ad esempio - il maggior produttore e venditore di grano, comportava per esso introiti molto maggiori che non il doversi accontentare delle imposte sui proventi (peraltro cospicui) delle attività commerciali di privati cittadini. Ma una tale pratica, resa peraltro possibile dagli enormi poteri di cui tradizionalmente lo stato era dotato, tendeva a cancellare la fonte primaria dello sviluppo produttivo: ovvero il fattore della concorrenza tra liberi imprenditori, condizione essenziale per il pieno dispiegamento delle energie e della creatività individuali. La produzione, imprigionata nelle maglie della burocrazia statale, finì così per diminuire e la riccheza degli stati e delle società ellenistiche per declinare.
Ovviamente, quasi mai i monopoli dello stato riuscirono a essere ‘integrali’: rimanevano pur sempre dei liberi imprenditori privati che svolgevano attività concorrenziali rispetto a quelle dello stato stesso. Né, del resto, si deve dimenticare come anche la distinzione tra pubblico e privato fosse – da sempre – un fatto alquanto incerto nelle regioni asiatiche e medio-orientali (le terre ad esempio, in Egitto, erano quasi tutte proprietà del Sovrano, il quale poi per consuetudine le dava in gestione o in appalto a privati cittadini). Tuttavia, una delle tendenze di lungo corso dell’Ellenismo fu quella all’appropriazione da parte dello stato di larghi settori dell’economia (di solito, quelli più remunerativi), e ciò con conseguenze molto gravi per la loro produttività e ricchezza - se non nell’immediato, quantomeno sui tempi lunghi.
Infine, ci resta da delineare un quadro molto veloce delle trasformazioni subite dagli stati occidentali sotto l’influenza dei vicini stati orientali, mostrando la fondamentale uniformità creatasi tra queste due diverse aree del mondo dal punto di vista politico, economico e sociale.
Come già si è accennato, se l’Oriente ricevette in dono dall’Occidente nuovi stili economici e nuove tecniche produttive, quest’ultimo ricevette dal primo una nuova idea di stato. Con la sola eccezione della Grecia, che rimase politicamente divisa tra città-stato autonome (federate però, come ai tempi delle guerre del Peloponneso, in due opposte leghe: quella achea e quella etolica), le altre regioni dell’Ellenismo occidentale cercarono di superare la loro antica organizzazione feudale e nobiliare e di costituirsi in veri e propri stati attorno a un potere centrale forte, accrescendosi inoltre di solito da un punto di vista territoriale.
Anche se i confini di questi regni rimasero sempre piuttosto incerti, la Macedonia fu senza dubbio alcuno – per tutto il periodo ellenistico – la maggiore potenza occidentale, seguita a ruota dall’Epiro.
La
Grecia invece, nonostante il prestigio di cui godeva come culla della
civiltà e patria di alti ingegni, divenne una potenza
abbastanza secondaria sia dal punto di vista economico che da quello
politico. Essa gravitò soprattutto attorno alla Macedonia, ma
fu anche il ponte dell’espansionismo dell’Egitto verso le
regioni nord-occidentali. Ricoprì dunque una posizione
estremamente ambigua, di cui spesso approfittò per continuare
a svolgere un ruolo rilevante sul piano degli equilibri
internazionali. Nonostante infatti la perdita dell’antico
primato mediterraneo, essa rimase spesso l’ago della bilancia
delle contese internazionali, soprattutto a livello locale.
RICCHEZZA E POVERTÀ NEL MONDO ELLENISTICO
Oltre a quelli considerati finora, vi sono nel mondo ellenistico (complessivamente inteso) altri aspetti degni di attenzione. Non solo dunque la fusione tra Oriente e Occidente, ovvero la nascita di un’alleanza per così dire strategica tra poteri economici privati e poteri statali, ma anche il sorgere di una prima società a due livelli: basata cioè su una separazione sempre più netta tra ricchi e poveri – tra proprietari ed espropriati.
Ovviamente sarebbe eccessivo riproporre in questo contesto una polarità, quale quella tra capitalisti e proletari (individui, come tali, costretti al lavoro salariato), che si adatta per intero solo al mondo europeo moderno. Tuttavia, se anche per tutta l’età antica non si può parlare di un vero e proprio proletariato, per molti periodi di esso (tra i quali, e in primo luogo, quello in esame) è possibile parlare di un diffuso (e col tempo di solito crescente) fenomeno di “proletarizzazione” delle masse, causato da un sempre più marcato sfruttamento da parte dei poteri superiori, sia economici sia istituzionali.
Laddove la struttura della società era prevalentemente agraria (cioè soprattutto in Oriente, e nei grandi stati feudali occidentali), sia che lo stato avesse consolidato da poco i propri poteri (ad esempio in Macedonia) sia che ricoprisse da sempre un ruolo economicamente e politicamente egemone (ad esempio in Egitto), i poteri statali e latifondistici si trovarono di fronte a grandi masse di contadini facilmente assoggettabili ai propri scopi. In questi contesti, l’alleanza tra stato e grandi proprietari fu molto forte, e un tale fattore rese possibile uno sfruttamento delle masse dei lavoratori molto maggiore rispetto ai periodi precedenti. Inoltre, anche la pressione tributaria aumentò notevolmente.
Anche la Grecia poi, e più in generale le città-stato elleniche, nelle quali si era sviluppata nel corso dei secoli una rigogliosa imprenditoria privata sorretta da una florida classe media, conobbero processi simili a quelli appena descritti. La nascita tra VI e IV secolo di una vasta classe media impiegata, oltre che in attività politiche, anche in attività di carattere artigianale e commerciale, era stata la grande particolarità storica della civiltà ellenica rispetto agli altri stati antichi, sia vicini che lontani.
Tuttavia la diffusione di un tale tipo di attività in tutto il bacino mediterraneo, a partire proprio dal periodo ellenistico, minò il precedente e indiscusso predominio commerciale e produttivo ellenico, con la nascita di potenze ‘industriali’ anche al di fuori dell’ambito propriamente greco e di quello dei vicini stati occidentali (già da alcuni decenni divenuti concorrenziali rispetto all’imprenditoria greca). Anche l’Egitto e la Siria infatti, avendo intensificato la propria produzione agricola e manifatturiera, erano oramai divenuti in grado di esportare oltre i propri confini merci prima esportate soprattutto dalle regioni greche e occidentali. Senza contare il fatto che le loro maggiori dimensioni territoriali e la loro maggior ricchezza di materie prime e di manodopera li rendevano di solito, dal punto di vista della capacità produttiva, molto superiori alla Grecia stessa. In breve tempo, il predominio ellenico fu dunque non solo cancellato ma anche rovesciato.
Tale situazione di fortissima concorrenzialità colpì ovviamente innanzitutto la piccola e media imprenditoria e i piccoli proprietari terrieri. Solo la grande imprenditoria riuscì a sopravvivere al rialzo del costo delle materie prime e alla diminuzione dei mercati di sbocco delle proprie merci. Questa situazione determinò un generale declino in Grecia delle classi medie nonché di conseguenza un deciso rafforzamento dei grandi poteri economici e finanziari. E anche se sempre più spesso le poleis greche, in età ellenistica, si diedero una veste democratica, i poteri decisionali finirono per accentrarsi in realtà in un ambito sempre più ristretto di persone: i membri cioè di un’aristocrazia economico-politica che ricordava molto quella dei grandi stati ellenistici (sia d’Occidente che d’Oriente).
Una precisazione va fatta in merito al ruolo del mercato in età ellenistica. Si è già detto che la conversione di molte regioni a stili economici e produttivi d’origine greco-occidentale, comportò la creazione di un maggior surplus di ricchezza, in gran parte investita poi nei commerci sia interni che esterni agli stati.
Un simile discorso potrebbe però indurre a credere che, in tale età, si verificasse un fondamentale innalzamento della ricchezza media della popolazione. Al contrario, vari fattori resero una tale ricchezza il privilegio quasi esclusivo di una fascia minoritaria di essa. Per produrre di più era infatti necessario chiedere maggiori sacrifici alla massa dei lavoratori (molti dei quali erano schiavi), e inoltre drenare a essa maggiori ricchezze aumentando la pressione fiscale e diminuendo il “salario” (si passi il termine storicamente improprio) dei lavoratori.
Inoltre, date le scarse capacità tecnologiche e la bassa produttività dell’epoca, le merci rimasero di solito abbastanza care da rimanere sostanzialmente inaccessibili – con la sola eccezione forse, di alcuni generi di prima necessità – alla grande massa della popolazione. L’accesso ai mercati dunque, fu un fatto che riguardò soprattutto la popolazione ricca o comunque benestante, composta essenzialmente da alti funzionari statali e da cittadini facoltosi (oltre che dai soldati: una categoria socialmente privilegiata, data l’importanza rivestita dalla guerra nel mondo ellenistico).
Anche
l’impiego che veniva fatto della gran parte delle ricchezze
prodotte testimonia di una loro fondamentale “fruizione
d’élite”: esse venivano infatti in massima parte
impiegate, o per opere che dessero lustro alle casate regnanti (e a
volte, seppure più in piccolo, dei cittadini ricchi) o per
opere di carattere militare (come la progettazione e la costruzione
di macchinari bellici innovativi). Resta comunque il fatto che, senza
la maggiore vivacità dell’economia e della produzione
del periodo ellenistico, molti aspetti (sia positivi sia negativi) di
tale civiltà non sarebbero forse stati possibili.
L’EREDITÀ DELL’ELLENISMO, DA ROMA AD OGGI
La società ellenistica fu forse dunque, un primo esempio di società statalizzata in cui si sviluppano grandi poteri economici e imprenditoriali privati e vasti traffici internazionali: stato e “borghesia” infatti, procedettero in essa paralleli, l’uno come complemento e condizione di possibilità dell’altro.
Un altro esempio di un tale tipo di organizzazione ce lo fornisce, nel mondo antico, la società romana imperiale, non a caso diretta erede di quella ellenistica. Scrive a tale proposito Paul Leveque: “(…) le nuove condizioni - sviluppo di una borghesia capitalista di origine greca e, in Egitto, introduzione della moneta - determinano trasformazioni profonde, particolarmente evidenti nelle città. La sovrapposizione di una classe di conquistatori a una massa di indigeni vinti (ma per la maggior parte abituati da lunga data a dominazioni straniere) conferisce al mondo ellenistico un aspetto assai peculiare e ne fa sovente la prefigurazione dell'impero romano.” (Paul Leveque, “Il mondo ellenistico”, 1980 - Editori Riuniti).
Anche nel mondo romano imperiale infatti, si assistette a un rafforzamento degli apparati di controllo dello stato sul proprio territorio, oltre che a un rafforzamento dell’alleanza (di cui la classe degli equites o cavalieri fu un chiaro esempio) tra stato e classi imprenditoriali, capaci di accumulare cospicue ricchezze grazie agli appalti legati alla riscossione delle imposte, alle opere pubbliche, alle attività militari, ecc.
Anche e ancor più in epoca moderna, lo stato ha costituito una solida e indispensabile base d’appoggio per lo sviluppo delle proprie classi imprenditoriali (oramai pienamente trasformatesi in senso capitalistico), tanto che alcuni studiosi (per esempio Max Weber) considerano lo stato moderno alla stregua di un’impresa economica.
Ma è nell’ambito della trasformazione dei paesi dell’Est (ovvero del blocco prima comunista) in direzione dell’industrializzazione e del capitalismo, che l’Ellenismo ci fornisce forse i più interessanti e originali spunti di interpretazione storica. Non apparirebbe infatti infondato un parallelismo tra la vicenda degli stati ellenistici (nei quali le tradizioni occidentali vennero trapiantate dell’alto ad opera di una nuova élite di dominio, che vi esportò i propri stili culturali ed economici) e l’industrializzazione ‘forzata’ – in nome peraltro di ideali di progresso sociale ispirati al marxismo – di paesi in cui, per tradizione millenaria, forte era il potere di controllo dello stato sul proprio territorio e sulle sue attività economiche.
Anche in questo caso, si può forse dire che le pregresse strutture stataliste furono utilizzate ai fini di una modernizzazione forzata e ‘dall’alto’ dell’economia.