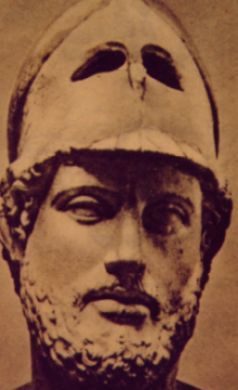LA GRECIA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Storia ed evoluzione della Grecia classica
La polis greca
| La Grecia micenea o achea dei secoli XVI-XII a.C. viene comunemente
equiparata alle formazioni statali dispotiche d'Oriente, ad essa coeve (Assiria,
Babilonia, Egitto, il regno Hittita). Molti tratti, in effetti, sono
comuni: un forte potere monarchico, grande proprietario terriere,
supportato dall'esercito e da funzionari statali; vasti territori
soggetti a sfruttamento, sotto il controllo universale di una
contabilità burocratica, ecc. Tuttavia, nella società greca più antica vi erano anche delle caratteristiche non riscontrabili in alcuna società orientale. Si pensi, ad es., al rapporto tra Micene (principale capitale del mondo acheo) e le altre città minori, ovvero il suo re (simile all'Agamennone dell'Iliade) e i principi di rango inferiore (come i vari Menelao, Ulisse, Achille...). |
|
In Oriente esisteva una grande differenza fra i monarchi veri e propri, che si consideravano alla stregua di "fratelli", e gli altri potentati, giudicati dei vassalli o "figli" del re. Quest'ultimi dovevano al loro "padre" la subordinazione politica, il tributo economico, l'aiuto militare e la collaborazione diplomatica.
Certo, anche i re micenei avevano una grande autorità. Basti pensare che Micene e Tirinto (altra residenza reale) erano le due uniche città fortificate da cinte imponenti, mentre le altre città ne erano quasi prive, a testimonianza della loro inferiorità. Inoltre lo stile miceneo dominava le arti e i mestieri di tutta la Grecia.
Nondimeno l'autorità sovrana dei micenei era fondata più sulla leadership morale che non sul dominio economico o sulla forza militare. Nessun tributo venne mai pagato a Micene da altre città. Tra i documenti ritrovati a Pylos, vi è una lettera del XIII sec. a.C. che il re hittita aveva scritto, con tutta la deferenza possibile, al re della Grecia achea, per chiedergli l'estradizione di un vassallo ribelle. Ebbene, il re acheo -come si evince dal documento- mostrava di non avere il potere di obbligare i propri sudditi, presso i quali il fuggiasco s'era rifugiato, a estradarlo. Egli al massimo poteva raccomandarli di consegnarlo, ma non forzarli, come invece si aspettava il re hittita.
Questo rispetto della dignità dell'individuo, del suo libero arbitrio, benché riguardi ancora una ristretta cerchia di aristocratici, costituirà più tardi una caratteristica fondamentale della struttura politico-sociale della polis. In fondo l'universo dell'Iliade, che rispecchiava la tradizione micenea, era dominato da una sorta di "cultura cavalleresca", del tutto estranea al centralismo assolutistico.
La polis era un tipo di organizzazione socio-politica formatasi nella Grecia e nella Roma antiche. Essa si fondava sulla sovranità economica e politica della comunità dei proprietari e dei liberi produttori, cittadini appunto della polis, e la sua organizzazione si estendeva all'intero territorio. Tale sovranità implicava, per ogni cittadino, la possibilità (e spesso anche l'obbligo) di partecipare, con l'uso del voto nelle assemblee popolari, alle delibere riguardanti le questioni politiche vitali della città. La polis costituiva l'unità organica della struttura politica e della società civile. Essa contribuiva allo sviluppo del patriottismo, del sentimento di uguaglianza fra tutti i cittadini e al rispetto consapevole delle leggi fissate, normalmente, da una Costituzione scritta.
La monarchia micenea avrebbe anche potuto trasformarsi in un dispotismo assoluto. Ciò non avvenne anche per una ragione molto concreta: una potente ondata migratoria dal nord s'abbatté sulla Grecia achea nei secoli XIII-XI a.C. I possedimenti reali furono suddivisi tra gli immigrati, ovvero tra le comunità d'invasori e, all'interno di queste, tra i membri la cui proprietà privata della terra stava per diventare la base del nuovo sviluppo economico della Grecia.
Col passare del tempo, nella misura in cui cresceva il progresso economico e la stabilità politica, le comunità rurali si allearono, dando vita a delle formazioni che prefiguravano la polis ("protopolis") e che si ponevano come garanti della proprietà dei loro membri. La comunità dei proprietari liberi costituiva una sorta di embrione della futura società civile.
L'ideologia dei liberi proprietari, abitanti della "protopolis", trovò la sua migliore espressione nel poema di Esiodo, Le opere e i giorni (sec. VIII-VII a.C.). Già da tempo gli studiosi hanno rilevato lo spirito "borghese" della morale di Esiodo, la cui "protopolis" rappresenta una società debolmente stratificata, ove si distingue un ceto elevato che vanta sì origini aristocratiche, ma che, nel contempo, resta aperto a ogni proprietario agiato.
La principale massima morale è "Lavora e avrai successo". Nella "protopolis" il lavoro è non solo una via verso il benessere e la reputazione sociale, ma anche una sorta di dovere religioso, una forma di espiazione dell'antico peccato di Prometeo, imposta dagli dèi, che amano i lavoratori e odiano i fannulloni. Il lavoro apprezzato dagli dèi è una convinzione che prefigura, se vogliamo, quella "etica protestante" il cui ruolo nella formazione del capitalismo è stato ben sottolineato da Max Weber.
La "protopolis" si trasformò in polis classica nei secolo VII-VI a.C., quando in Grecia le varie comunità dei liberi proprietari stabilirono formalmente, attraverso delle Costituzioni scritte, la sovranità sui loro rispettivi territori e introdussero l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Fu così che, per la prima volta, la società civile apparve sulla scena storica, in una forma praticamente identica alla struttura politica.
Nella stragrande maggioranza delle società antiche il potere militare e amministrativo dominava la proprietà, cioè la controllava e la distribuiva. Nella polis invece il potere veniva esercitato dalla comunità dei proprietari cittadini ed essa era chiamata ad esprimere direttamente la loro volontà.
La seconda componente aristocratica della polis, correlata alla morale di Esiodo, era l'atmosfera di competizione che vi regnava, cioè l'aspirazione dell'individuo, socialmente incoraggiato, alla gloria, alla notorietà, guadagnata anche in campi estranei alla politica e alla produzione materiale (come le gare atletiche, l'arte, la scienza). Lo stile di vita era agonistico e l'individuo cercava di affermarsi in una competizione tra uguali.
All'epoca della "protopolis" questo stile di vita si traduceva nel desiderio di distinguersi nella guerra, nella caccia, nei festini, nella produzione di oggetti di lusso, nel mecenatismo, nell'organizzazione delle competizioni poetiche, nel finanziare regolarmente i giochi olimpici, che erano assai costosi. Gli aristocratici, praticamente, emulavano lo stile di vita miceneo, così vivacemente descritto da Omero.
Nella misura in cui la democratizzazione si estese a tutti gli aspetti della vita cittadina, l'ideale aristocratico di autoaffermazione nella competizione guadagnò strati sociali più vasti di cittadini liberi. Tutte le capacità: fisiche, intellettuali, artistiche, che potevano rendere celebri, venivano sviluppate.
Così, mentre la "borghesia" della polis seppe creare l'unità della società politica e civile, l'aristocrazia invece seppe aggiungere a questa sintesi l'ideale dell'individuo libero, che non pensa solo a "lavorare" ma anche a "competere per diventare famoso".
La sovranità economica della polis era sempre considerata come una garanzia della proprietà privata dei suoi cittadini, anzitutto della loro proprietà fondiaria, benché in numerose polis si siano sviluppate efficacemente anche l'artigianato e il commercio.
Se la proprietà fondiaria e la cittadinanza procedevano parallelamente, l'artigianato e il commercio erano spesso praticati, nella polis, da lavoratori non-cittadini, come ad es. i coloni di altre polis e, più tardi, i liberti. Come nel caso della plebe romana, esisteva uno strato sociale assai vasto di persone che, pur non fruendo dei diritti civili, giocava un ruolo considerevole nella vita economica della città, lottando, spesso con successo, per l'uguaglianza.
Per l'uomo dell'antichità classica gli schiavi, così come i meteci (persone prive di cittadinanza), erano visti come "strumenti" o "circostanze" che servivano al benessere della polis. L'impiego degli stranieri schiavizzati divenne un fenomeno di massa in seguito alla vasta applicazione dell'iniziativa libera nella produzione mercantile. Nell'antichità gli schiavi avevano la stessa funzione della macchina nell'epoca industriale.
Non per questo dobbiamo considerare gli antichi greci e romani come anzitutto degli "schiavisti". L'abitante della polis era prima di tutto un libero proprietario in emulazione coi suoi pari, che partecipava direttamente alla realizzazione della volontà politica del suo Stato.
Il fenomeno dello schiavismo è parte integrante d'un fenomeno più generale: l'autarchia, il separatismo civile della polis, che nega ai non-cittadini ogni diritto sul proprio territorio e che impone dei limiti alla crescita della stessa polis. Da un lato, quindi, s'impongono rigidi e assurdi controlli sul numero effettivo della popolazione; dall'altro sorgono interminabili e spesso disastrosi conflitti egemonici tra le polis.
La cosiddetta "democrazia dei piccoli spazi", se assolutizzata, restringe le possibilità evolutive del sistema, trasformando i rapporti tra le polis in una guerra interminabile di tutti contro tutti.
La Roma antica cercò di superare questa contraddizione, sostituendo progressivamente alla polis greca la costruzione dell'impero, che, dapprima in forme repubblicane, si pose come obiettivo quello di creare una "cosmopolis universale". Il cosmopolitismo, come teoria filosofica, era nato nella Grecia antica, ma solo nell'impero romano trovò la sua adeguata espressione politica. Una gigantesca potenza polietnica appariva come un'unica città. Con l'editto di Caracalla (212 d.C.) tutti gli abitanti dell'Impero acquisivano lo status legale di cittadini liberi. Nel contempo l'Impero cercava di trasformare gli schiavi in coloni locatari, interessandoli ai risultati del loro lavoro.
Purtroppo, riducendo la polis a livello di "municipi", e subordinandole alle strutture burocratiche indipendenti dalla volontà dei cittadini, l'Impero aveva creato, col tempo, una frattura tra il sistema politica e la società civile. L'importanza politica di un cittadino era stata ridotta al minimo: il potere centrale poteva facilmente disporre di lui e della sua proprietà. L'Impero, divenuto dispotico, si avvicinava così ai modelli delle monarchie orientali.