LA GRECIA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Storia ed evoluzione della Grecia classica
Sviluppi della Grecia italiana e siciliana
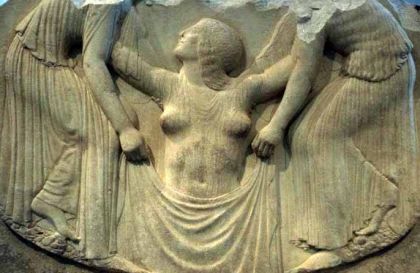
Al pari della Grecia vera e propria, anche gli insediamenti ellenici delle zone occidentali - ci riferiamo qui, in particolar modo, a quelli italici e siciliani - conobbero in questi anni delle profonde crisi e delle altrettanto profonde trasformazioni interne, sia sul piano organizzativo ed istituzionale (e ciò specialmente quelli greco sicilioti…) quanto su quello dell'autonomia e dell'indipendenza politica (…quelli italici).
In Sicilia, fu soprattutto l'esigenza di difendersi dai Cartaginesi (i quali intendevano estendere la propria influenza sull'isola anche alle zone occupate dai greci) a determinare tale crisi.
Nelle regioni del sud Italia, invece, furono soprattutto le popolazioni autoctone - tra le quali, iniziava allora a farsi strada anche quella romana… - a far vacillare l'indipendenza delle città-stato greche.
Cominciamo dalla Sicilia.
Nel 409 - poco dopo la sconfitta ateniese del 411 - un generale cartaginese di nome Annibale, attaccava e distruggeva due importanti città elleniche della Sicilia, Imera e Selinunte, conquistando così un vasto predominio sulla zona nord-occidentale dell'isola. Tre anni più tardi poi, nel 406, anche la città di Siracusa si arrendeva ai Cartaginesi. (Tutto ciò, ovviamente, poteva avvenire anche a causa della debolezza dei Greci della madrepatria: incapaci - per ovvi motivi - di soccorrere i propri connazionali.)
Sempre in quello stesso anno tuttavia, la situazione in Sicilia subiva per i Greci una svolta decisiva. Dionisio I infatti, divenuto stratego con pieni poteri, riusciva a concludere una pace onorevole coi nemici, divenendo l'anno successivo (405) tiranno di Siracusa. Attorno a tale città inoltre - da sempre una delle maggiori potenze siciliane - si riunivano ben presto gli altri stati greco-sicilioti. Si veniva così a formare - per la prima volta, e per evidenti necessità di difesa - un vero e proprio stato territoriale greco, un fatto che contravveniva a tutte le precedenti consuetudini del mondo politico ellenico, caratterizzato da una situazione di frammentazione in piccole realtà locali. Sotto Dionisio I inoltre, la Sicilia si armava di una potentissima flotta marittima (la più potente al mondo), divenendo così in breve un vero e proprio Impero militare.
Ma non era finita qui. Infatti, solo all'incirca dopo un decennio - ovvero nel 392 - i Greci riuscivano a relegare i Punici nell'estremo lembo nord-occidentale dell'isola, mentre l'Impero di Dionisio I arrivava a estendersi fin nel sud dell'Italia, giungendo inoltre a controllare alcuni territori della Corsica e costituendosi non più soltanto come un organismo militare, bensì anche come un'unità produttiva e commerciale.
Un tale impero tuttavia, non poteva certo avere vita lunga, a causa soprattutto della presenza di popolazioni a esso fortemente ostili - e ciò non solo in Sicilia, ma anche in Italia. Già nel 382 infatti, i Cartaginesi riuscivano a riconquistare alcune delle loro precedenti posizioni, spostando il confine tra lo stato greco e quello punico nelle zone immediatamente antistanti la città di Imera.
Inoltre, con la scomparsa di Dionisio I, personaggio di grande statura politica, aveva inizio un lungo periodo di crisi per gli stati greci siciliani. In tale periodo - segnato peraltro dalla reggenza di Dionisio II, figlio del precedente tiranno - gli stati ellenici avrebbero conosciuto una vera e propria crisi di identità e di coesione, alla quale si dovette il riesplodere di molte delle divergenze del passato (fu inoltre in questi anni, che si collocò l'infelice tentativo del filosofo Platone - guidato e appoggiato da Dione, genero del tiranno siracusano - di instaurare sull'isola uno Stato fondato sui suoi stessi principi etici e politici…)
Fu infine nel 344, con l'arrivo presso Siracusa di un certo Timoleonte (cittadino corinzio, mandato dalla propria città a ricoprire il ruolo di arbitro nelle contese interne di Siracusa), che si ebbe l'inizio di una nuova "rinascita" politica e militare siciliana.
Attorno alla città di Siracusa difatti, che in quest'ultimo aveva nuovamente trovato una valida guida, la compagine greco-siciliota ritrovò la propria antica compattezza divenendo in breve una federazione di stati, e riuscendo così a riguadagnare - soprattutto dopo la Pace di Imera (339) - alcune delle sue precedenti posizioni, nonché in generale un indiscusso primato sull'isola a scapito dei Cartaginesi.
Un'analoga manovra di 'salvataggio' non fu però possibile per le città-stato elleniche in Italia.
Qui infatti - come si è già detto - troppo forte era fin dall'inizio la posizione di quelle civiltà autoctone che da sempre minavano l'autonomia politica degli stati greci. Questi ultimi infatti, non riuscirono a resistere a lungo alla pressione di quei popoli la cui potenza avevano essi stessi - nei secoli precedenti, e attraverso la propria benefica influenza culturale e politica - aiutato a maturare.