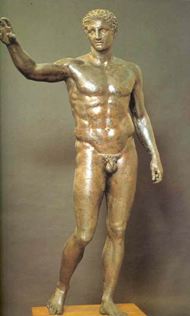LA GRECIA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Storia ed evoluzione della Grecia classica
La prima parte della guerra: la guerra Archidamica (431 - 421)
Riassumeremo brevemente, qui avanti, le fasi salienti di questo lunghissimo conflitto, rinviando il lettore - per una sintesi più accurata - a un qualsiasi testo di storia greca, o addirittura al resoconto di Tucidide, che di tali fatti fu (oltre che un grande espositore e interprete) un testimone diretto.
|
Divideremo in tre parti gli anni compresi tra le lunghe guerre del Peloponneso, e cioè: a) la fase iniziale, detta guerra 'archidamica'; b) la breve tregua che fece seguito alla stipula della pace di Nicia; c) e l'ultima fase del conflitto, con la spedizione ateniese in Sicilia e le ultime battaglie. Per ciò che concerne l'inizio della guerra, essa fu scatenata dalla forte conflittualità, instauratasi oramai da anni, tra Atene e Corinto (quest'ultima, la maggiore potenza commerciale all'interno della Lega del Peloponneso). Una conflittualità dovuta al fatto che Atene, negli ultimi tempi, si fosse estesa commercialmente anche verso occidente, soprattutto verso i territori della Sicilia (cfr. sopra), disturbando in tal modo il predominio corinzio in quell'area. |
|
Quando poi l'isola di Corcira (l'attuale Corfù), fino ad allora colonia corinzia, aveva deciso di ribellarsi alla capitale (433), aveva richiesto e ottenuto prontamente l'appoggio militare di Atene. Ne era nata una guerra al termine della quale Corcira aveva guadagnato l'indipendenza, mentre Atene aveva consolidato ulteriormente le sue posizioni occidentali.
Dal canto suo anche Corinto disturbava i traffici ateniesi. Antica fondatrice della ricca colonia calcidica di Potidea, già da tempo divenuta membra della Lega marittima ateniese, Corinto continuava difatti a mantenere con essa frequenti contatti politici, istigandola alla ribellione contro la capitale (e sappiamo già che tipo di dominio, estremamente autoritario, Atene esercitasse sulle altre città-stato della Lega marittima…) Da che poi Potidea era ricorsa all'aperta insurrezione, Corinto si era schierata in suo favore, sostenendone sia le rivendicazioni che l'azione militare.
Le due città greche cercavano insomma, in quanto protagoniste e rivali del commercio nell'area mediterranea, di logorare vicendevolmente le proprie posizioni.
Ma l'inizio vero e proprio delle ostilità fu conseguenza di un decreto di Pericle (432), attraverso cui si proibiva alla città di Megara, alleata di Corinto e i cui interessi commerciali - a differenza della prima - si estendevano verso est, cioè nel mare Egeo, di intrattenere rapporti commerciali con le città della Lega Delio-attica. Oltre che un duro colpo all'economia degli stati peloponnesiaci (che erano così privati di buona parte delle risorse, granarie e non solo, provenienti dal Mar Nero e dalle zone a est della Grecia), un tale decreto costituiva anche un'aperta violazione dei patti del 446, che stabilivano la piena libertà di scambio tra gli stati delle due Leghe.
E fu appunto in seguito a un tale decreto, che Corinto riuscì a costringere - sotto la minaccia, come si è già detto, di abbandonare la Lega peloponnesiaca alleandosi con Argo - l'alleata Sparta, che pure non vedeva intaccati in modo sostanziale i propri interessi (ed era inoltre alle prese con gravi problemi interni: calo della popolazione, insofferenza degli Iloti…), a denunciare la violazione della precedente pace dei trent'anni, dichiarando guerra alla rivale. Era il 431, ed aveva così inizio la guerra tra i due blocchi.
La prima battaglia avvenne a Platea, dove i Tebani (coniugando i propri interessi privati allo scoppio del conflitto) si scagliarono contro la vicina città-stato, loro antica rivale. Un conflitto che vedeva presto, inoltre, il trionfo degli invasi (Platesi) sugli invasori.
A esso faceva seguito una prima invasione dell'Attica da parte dell'esercito peloponnesiaco, guidato dal generale spartano Archidamo. Ritiratesi in gran parte tra le mura di Atene (secondo peraltro una strategia elaborata da Pericle, che voleva evitare lo scontro di terra con le truppe avversarie, cosciente della loro superiorità), le popolazioni attiche aspettarono che il nemico tornasse alle proprie sedi, dopo aver devastato gran parte del loro territorio.
Ma lo scoppio della guerra era anche - come si è già detto - un'ottima occasione per sistemare gli 'affari' pendenti tra le singole città-stato. Tra questi, per Atene, vi era l'antica rivalità con gli Egineti, i quali venivano infatti invasi e sterminati (e fu, questo, solo il primo di una lunga serie di episodi di inaudita crudeltà che costellarono questo lungo conflitto), mentre il territorio della città veniva trasformato in una cleruchìa attica (430).
Gli anni seguenti avrebbero visto poi, tra l'altro : la diffusione della peste ad Atene (conseguenza dell'ammassamento delle popolazioni attiche tra le sue mura, in seguito ad una nuova invasione spartana, nel 430) che avrebbe mietuto moltissime vittime, tra le quali lo stesso Pericle (429); il conseguente passaggio di consegne da quest'ultimo a Cleone (un politico di umilissime origini, tipico prodotto della democrazia ateniese!); e - con grande gioia degli ateniesi, che riacquistavano così il dominio su zone economicamente ricchissime, tanto più utili in tempo di guerra - la capitolazione della colonia ribelle di Potidea (429).
Anche l'espansione ateniese verso occidente conosceva poi, in questi anni, dei nuovi sviluppi. Gli Ateniesi difatti intervenivano in Sicilia (428), con il pretesto di sedare alcune gravi contese insorte sull'isola tra stati dorici e stati ionici (su cui peraltro, essi avevano già esteso la propria influenza, cfr. sopra). In tal modo, la coalizione ateniese diveniva sempre di più la padrona assoluta dei mari, sia a ovest che a est. Ciò che consentiva a essa di attuare un micidiale blocco dei rifornimenti ai danni delle popolazioni del Peloponneso, mostrando a esse come la loro superiorità su terra fosse ampiamente compensata da quella ateniese sui mari !
Complessivamente, insomma, la guerra volgeva in favore di Atene e degli altri stati della Lega marittima. Tale trend conosceva il momento culminante con la spedizione ateniese nel Peloponneso, al termine della quale gli Ateniesi riuscivano a piegare presso Sfacteria (425) gli eserciti nemici, cui di conseguenza non rimaneva che invocare - anche se con scarso successo, data la tempra del nuovo leader ateniese, Cleone - la pace.
La situazione del blocco oligarchico si risollevava però in modo inaspettato per mano del generale spartano Brasida, il quale invadendo (424) le colonie attiche della Tracia (da tempo, come già aveva dimostrato la ribellione di Potidea, riottose al dominio ateniese) riusciva ad appropriarsi di regioni essenziali per la solidità del blocco nemico.
Gli anni seguenti, Atene li avrebbe passati in buona parte a cercare di riappropriarsi di tali zone, e soprattutto della ricchissima Anfipoli. Solo nel 422, con la definitiva sconfitta ad opera di Brasida presso Anfipoli, essa si arrendeva alla sconfitta, concludendo poco dopo - fatto possibile solo per la morte di Cleone e per quella dello stesso Brasida, principali fautori della guerra - una nuova pace con Sparta, per iniziativa di Nicia (421).
E' curioso inoltre come, a partire dalla conquista delle città-stato traciche, il blocco oligarchico iniziasse a risollevarsi (attraverso, ad esempio, una cocente sconfitta ateniese in Beozia), mentre - contemporaneamente e per cause autonome - la fortuna degli Ateniesi iniziasse a declinare (essendo gli ateniesi, per esempio, costretti ad evacuare la Sicilia, in seguito al placarsi del conflitto interno).
Nel complesso, Atene era stata a un passo dalla vittoria (cosa di cui però, una volta di più, non aveva saputo approfittare!) Il suo tallone d'Achille era stata l'incerta solidarietà delle alleate, sempre più vessate tra l'altro dall'onere dei tributi, in conseguenza delle enormi spese sostenute dalla capitale per la guerra.
Ciò gli spartani avevano capito, e approfittandone erano riusciti a risollevare le proprie sorti, trasformando la sconfitta iniziale in un (quasi) pareggio.