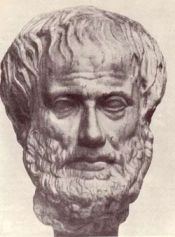LA GRECIA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Storia ed evoluzione della Grecia classica
La Grecia nel periodo di Pericle
|
Gli anni finali della Pentecontaetia (462-433) furono per il mondo ellenico 'anni difficili', segnati dall'estendersi a livello globale (sia cioè nella madrepatria, che in alcune colonie e stati circostanti) dei due opposti schieramenti, quello oligarchico filo-spartano e quello progressista filo-ateniese, oltre che dagli ultimi atti della guerra contro la Persia (un impero la cui efficienza nella lotta contro i Greci per il predominio nell'Egeo, fu condizionata pesantemente da alcuni episodi di ribellione interna - tra cui quello dell'Egitto, paese da sempre ricalcitrante di fronte a qualsiasi dominazione esterna), che si concluse con la pace di Callia nel 449. |
|
Sul fronte politico ateniese, invece, un tale periodo può essere stigmatizzato come "l'età di Pericle", il celebre politico e statista che - seppur con alcuni limiti - guidò la città verso il suo apogeo, sulla strada di un'espansione essenzialmente imperialistica e coloniale.
(a) La Grecia (e il mondo ellenico) fino alla tregua tra Sparta e Atene (446)
Già tendenzialmente divisa negli anni precedenti tra due opposte Leghe o aree di influenza, quella cioè facente capo a Sparta e quella capeggiata da Atene, la Grecia conobbe in questi anni un ulteriore rafforzamento delle stesse. Tra il 461 e il 446 infatti, le due coalizioni si estesero a parecchi nuovi stati - alcuni dei quali inoltre, situati al di fuori della madrepatria!
Le ragioni di tale fenomeno furono essenzialmente due : da una parte vi fu una politica di potenza coscientemente perseguita dai due schieramenti, ormai in aperta lotta tra loro; dall'altra il fatto che stati prima indipendenti - o magari soltanto simpatizzanti per l'uno o per l'altro schieramento - cercassero sempre più frequentemente un appoggio esterno contro i propri personali nemici (un chiaro esempio di ciò è costituito dalla Focide, regione che si alleò con Atene per mantenere il proprio predominio sulla vicina Delfi… la quale poi, a sua volta, richiese l'aiuto di Sparta).
In breve, al termine della Pentecontaetia la Grecia e, più in generale, il mondo ellenico erano divisi tra un'area prevalentemente occidentale, oligarchica e filo-spartana, ed una prevalentemente orientale, filo-democratica e filo-ateniese.
I fatti che portarono a una tale situazione furono fondamentalmente quelli legati alla lotta tra le due 'capitali' per il predominio sulla Grecia centrale (Beozia e Focide) e su alcune regioni peloponnesiache, mentre sin dall'inizio le zone orientali ed egee caddero - essenzialmente per ragioni geografiche - sotto l'influenza ateniese.
Le fasi principali di tale conflitto furono : a) una prima, nel corso della quale Atene estese il proprio potere sia su diverse zone della Grecia centrale che su alcune delle città-stato a lei vicine (soprattutto costiere), b) un'altra, nel corso della quale Sparta, reagendo alla politica colonialistica della rivale, sferrò, con la battaglia di Tanagra, un attacco molto pesante all'espansione ateniese nella Grecia centrale, c) una terza, durante la quale la Lega marittima capeggiata da Atene dovette affrontare gli attacchi della Persia (perdendo inoltre alcune importanti zone di influenza marittima) e che si concluse nel 449 con la pace di Callia, d) un'ultima infine, che vide nel 446 il sanzionamento degli equilibri interni creatisi negli anni precedenti, attraverso un accordo (la pace dei trent'anni) tra Sparta e Atene.
-- L'espansione ateniese nella Grecia centrale --
Una prima fase fu - come si è appena detto - quella dell'espansione ateniese nelle zone vicine, che si tradusse nell'annessione alla propria area di influenza di Argo (da tempo oramai in rotta di collisione con la Lega spartana, della quale aveva peraltro fatto parte) e di Megara (città rivale della vecchia Corinto, fedele alla lega spartana, per il predominio sull'Istmo). A ciò si aggiunga poi la difesa degli interessi dei Focesi che, 'allungando le mani' sui beni della città sacra di Delfi, avevano bisogno del sostegno di una potenza esterna.
Nel 459 inoltre, Atene rispondeva positivamente alla richiesta di aiuto degli Egiziani, insorti con Inaro contro i dominatori persiani, e in più dichiarava guerra alla sua antica rivale, la città di Egina, che inglobava a forza poco dopo - e a condizioni molto sfavorevoli - nella Lega Delio-Attica.
-- Il contrattacco di Sparta e degli 'oligarchi' --
Ma la reazione della capitale laconica non doveva farsi attendere. La preoccupazione per l'espansionismo di Atene difatti (soprattutto dopo la svolta democratica e progressista degli ultimi tempi) induceva presto quest'ultima a intervenire nella Grecia centrale - una zona nella quale forti erano da sempre le tendenze conservatrici - nel tentativo di creare una coalizione di stati oligarchici, ovviamente in funzione anti-ateniese.
Nel 457 la battaglia di Tanagra (località posta sul confine tra l'Attica e la Beozia) vedeva le forze oligarchiche beotiche e filo-spartane scontrarsi e vincere, anche se di poco, su quelle ateniesi, coadiuvate da alcuni contingenti inviati dalla città di Argo e dalla Tessaglia (regione alleata ad Atene). Ma che tale vittoria non fosse affatto schiacciante, lo dimostra chiaramente il fatto che gli Ateniesi, appena un mese dopo, riuscissero a riconquistare le zone perdute, inglobando inoltre nella propria sfera d'influenza alcune nuove città-stato, e indebolendo la supremazia spartana sulle regioni centrali.
-- Gli ultimi scontri con la Persia achemenide --
Una svolta negativa per l'espansionismo ateniese fu tuttavia determinata dall'aggravarsi del conflitto contro i Persiani sulle coste asiatiche.
Dopo un primo momento in cui gli insorti avevano prevalso, gli eserciti persiani erano infatti riusciti nel 454 ad avere la meglio su essi e sui loro alleati greci, riappropriandosi inoltre dell'isola di Cipro (che, nei decenni precedenti, era stata in mano agli ateniesi).
Atene in più, dovendo concentrare le proprie energie sul fronte marittimo, al fine di arginare l'avanzata del nemico, si vedeva costretta a comprare - e a condizioni molto umilianti - una sorta di pace temporanea con Sparta. In questi anni infatti, la città di Argo veniva nuovamente ceduta alle forze oligarchiche (451).
Nel 449, infine, Pericle decretava ufficialmente la fine dell'espansionismo greco verso oriente e delle ostilità con la Persia, stabilendo con la pace di Callia (ricco cittadino ateniese incaricato di intavolare le trattative) un modus vivendi tra le parti. Tale pace in sostanza suggellava in modo semi-ufficiale, congelandola, la situazione di fatto creatasi con le ultime guerre, secondo la convenienza sia dei Greci che dei Persiani.
-- La (temporanea) pacificazione della Grecia dopo la pace di Callia --
La parabola guerresca del decennio precedente, conosceva infine una definitiva interruzione (che durò però poco più di dieci anni) con la stipula nel 446 del trattato di pace tra Atene e Sparta, trattato la cui validità avrebbe dovuto essere di trent'anni.
Prima però gli ateniesi, indeboliti dagli eventi dell'ultimo periodo, conoscevano una nuova sconfitta da parte delle forze oligarchiche beotiche e spartane presso la città di Coronea (447), e assistevano impotenti alla rifondazione - proprio col sostegno della potenza spartana [1] - della Lega beotica, perdendo così tutte le aree di influenza acquisite precedentemente nella Grecia centrale (compresa, e con grande vantaggio per la città di Delfi, la Focide…)
Oltre a ciò, prezzo della pace era per essi la rinuncia alla città di Megara, mentre Egina continuava a far parte della Lega marittima.
In sostanza, dunque, l'intera regione peloponnesiaca e quelle centrali finivano per entrare a far parte della sfera d'influenza spartana, mentre sotto quella ateniese rimanevano le vicine zone costiere, le isole egee e le coste asiatiche.
(b) Atene nel periodo di Pericle (461 - 429)
Gli anni che abbiamo appena descritto (461-446), furono contrassegnati ad Atene - e indirettamente in tutto il mondo ellenico - dalla grande personalità di Pericle.
Dopo essere stato il braccio destro di Efialte - fino alla morte di quest'ultimo, avvenuta nel 461 ad opera dei suoi avversari politici -, egli ne raccolse l'eredità politica, sviluppando a modo proprio i presupposti della linea democratica intransigente del suo predecessore e maestro.
Durante la reggenza di Pericle (vedremo meglio più avanti in che modo egli 'reggesse' la città), Atene conobbe indubbiamente il massimo splendore sia all'interno (con l'abbellimento della città, ma anche con il suo apogeo artistico) sia all'esterno (con il trionfo della politica imperialistica e coloniale). Ciò non toglie però, che la sua linea di conduzione dello stato conoscesse anche dei limiti considerevoli, legati essenzialmente ad un eccesso di fiducia nella capacità di Atene di sostenere il peso di una lunga serie di impegni, che si tradusse in una lotta su più fronti.
Pericle, in ogni caso, rimane ancora oggi uno dei simboli della classicità, ovvero del periodo di massimo splendore della civiltà ateniese, nonché più in generale di quella greca.
-- La politica interna --
Come si è appena accennato, Pericle portò avanti il processo di 'popolarizzazione' della vita politica ateniese iniziato da Efialte, favorendo in nuovi modi l'accesso delle classi di censo più basse alle diverse magistrature.
Una per tutte, si deve ascrivere a lui la norma che imponeva allo stato di retribuire coloro che ricoprivano incarichi pubblici, come risarcimento per le perdite patrimoniali causate dallo svolgimento di tali attività (una misura concepita, ovviamente, in relazione soprattutto alle esigenze delle fasce economicamente più deboli). Venivano inoltre eliminate, nel corso di quella che potremmo definire la sua "reggenza", alcune restrizioni giuridiche che impedivano ai ceti più bassi (teti e zeugiti) di rivestire le magistrature più alte, quali ad esempio quelle giudiziarie.
Seppure a una prima occhiata, queste innovazioni possano sembrare a degli osservatori esterni (e moderni) del tutto ineccepibili, bisogna tuttavia rilevarne anche gli aspetti negativi e 'volgarizzanti' per la vita della polis. Il fatto di equiparare i cittadini di più bassa condizione (e quindi di più modesta istruzione) a quelli di estrazione più alta, dotati - almeno in linea di massima - di una più solida preparazione culturale, contribuiva difatti a dequalificare tante attività (ad esempio quelle giudiziarie) il cui svolgimento aveva un ruolo essenziale per il buon funzionamento dello stato. Per tale ragione, molti storici vedono in Pericle non solo e non tanto il sostenitore di una democrazia sempre più radicale, ma anche un primo responsabile della progressiva involuzione 'demagogica' di Atene!
E' facile immaginare poi come tali misure, se da una parte servivano allo stesso Pericle per consolidare la propria leadership a livello popolare, finissero dall'altra per implicare spese sempre nuove per l'apparato statale, richiedendo quindi un maggiore esborso di danaro.
Né è un caso che Atene, proprio negli anni d'oro della sua democrazia, mentre conosceva al proprio interno una sempre maggiore parità di diritti tra liberi cittadini, accentuasse di molto la distanza tra questi e tutti coloro che non possedevano la piena cittadinanza ateniese - tra i quali peraltro non vi erano solo le donne e gli schiavi, ma anche gli alleati politici (le altre città-stato, membre della Lega marittima) e quegli stranieri trapiantati (o meteci) cui, pur vivendo oramai da anni all'interno della loro polis, essi non riconoscevano il titolo di cittadini. Nei confronti di tali soggetti sociali, la politica di Pericle fu orientata fondamentalmente verso uno sfruttamento sempre più profondo e intensivo, il cui fine chiaramente fu quello di rendere possibili i fasti del nuovo sistema democratico. [2]
E' curioso quindi - e non deve essere dimenticato - il nesso esistente tra il principio di parità politica interna, e l'atteggiamento aristocratico/oligarchico tenuto dagli ateniesi nei confronti di tutti coloro che non erano… loro stessi : in altri termini, il nesso che legò tra loro aspirazioni democratiche e aspirazioni imperialistiche nella fase più classica della storia ateniese.
Un altro cenno va fatto infine ai modi attraverso i quali Pericle, pur promotore di riforme ultra-democratiche, riuscisse in pratica - a partire dalla morte di Efialte, fino alla propria - a condurre da assoluto protagonista la vita politica di Atene.
Come prima e dopo di lui molti personaggi di primo piano (uno fra tutti, Giulio Cesare), anche Pericle seppe infatti costruirsi un solido imperio personale senza tuttavia entrare in aperto conflitto con le strutture istituzionali vigenti (strutture nel suo caso apertamente democratiche). D'altra parte, egli non fu certo né il primo né l'ultimo grande protagonista della vita pubblica ateniese - altri furono prima di lui Clistene, Solone, Cimone, ecc. - anche al di fuori della breve parentesi tirannica.
L'idea di "democrazia" non rimandava difatti innanzitutto a quella di un sistema pluralista, bensì a quella di un governo basato sull'approvazione popolare. E di quest'ultima Pericle, pur con inevitabili alti e bassi, poté effettivamente godere - anche grazie al suo personale carisma - fino alla morte, a dispetto dei tentativi di screditarlo operati dai suoi avversari.
La carica che Pericle ricoprì dal 461 in poi, fu comunque quella di stratego. Se infatti già ai tempi delle guerre contro la Persia, essa aveva acquisito un'importanza notevole, con Pericle giunse ad essere tra tutte quella di gran lunga più influente. E proprio perciò egli, ricoprendola per ben trent'anni di seguito (pur affiancato ogni volta da un collega, essendo due per legge gli strateghi), riuscì a rimanere sempre una figura di primissimo piano nella vita politica di Atene.
D'altra parte, come leader carismatico di una coalizione che si era affermata sulla scena ateniese oramai dai tempi di Efialte, egli aveva voce anche nelle decisioni di molti altri politici, le cui azioni molto probabilmente, manovrava sotto banco.
Per tutte queste ragioni, gli anni che stiamo trattando furono, per Atene, gli 'anni di Pericle'.
-- La politica estera --
Il limite della politica di Pericle fu essenzialmente la mancanza di senso della misura - ciò che appare chiaramente, ancor più che dalla gestione degli affari interni, da quella degli affari esteri.
Mentre Temistocle, ad esempio, aveva scelto di anteporre alla lotta contro la Persia quella contro gli stati oligarchici (nella consapevolezza ovviamente dei limiti strutturali della potenza ateniese), Pericle al contrario pensò non solo di poter perseguire entrambi questi obiettivi, ma anche di potervene aggiungere un altro: quello cioè dell'espansione verso l'occidente ellenico.
Per tale ragione, nei suoi anni, Atene si impegnò non soltanto in un ampliamento della propria sfera d'influenza verso l'interno della Grecia e verso l'Egitto (due imprese i cui momenti salienti abbiamo già brevemente descritto), ma anche in un'impresa del tutto nuova, diretta verso l'Italia e le coste della Sicilia.
I momenti fondamentali di essa furono due : prima di tutto vi fu (454) l'intervento in Sicilia a favore della città di Segesta, in lotta con la vicina città di Selinunte; in secondo luogo, vi fu la fondazione (444) della colonia panellenica di Turi, nel luogo dell'antica Sibari (situata sulle coste dell'attuale Calabria, e distrutta nei decenni precedenti dai Persiani).
Tali imprese - delle quali le più positive furono senza dubbio quelle siciliane - erano espressione di una strategia di espansione in direzione delle zone italiche, decisamente ricche e commercialmente floride, anche se dilaniate sia da forti contrasti interni che dall'aggressività delle popolazioni locali e dalla rivalità delle vicine città cartaginesi.
L'impresa siciliana, inoltre, conobbe - come presto vedremo - dei nuovi (e tragici) sviluppi nel corso delle guerre peloponnesiache, per iniziativa del giovane Alcibiade.
Un altro aspetto decisivo della politica imperialistica di Pericle, fu la trasformazione della Lega Delio-Attica da una coalizione di stati almeno tendenzialmente egualitaria e con una funzione militare e difensiva, in una con fini essenzialmente politico-commerciali, governata in modo sempre più tirannico da Atene.
Una tale evoluzione, iniziata in nuce con la nascita stessa della Lega Delio-Attica, conobbe il suo apogeo negli anni che fecero seguito alla pace con la Persia (449), quando - per ragioni obiettive - le esigenze difensive conobbero un notevole declino.
Ma anche prima della pace di Callia, si erano avute delle avvisaglie dei progetti di dominio ateniesi.. Nel 454, per esempio, quando l'integrità dei territori egei era apparsa davvero in pericolo a causa della riscossa delle forze persiane su quelle degli insorti, si era deciso di trasferire il tesoro comune degli stati della Lega dall'isola di Delo (in cui esso era stato tenuto fino ad allora) all'acropoli di Atene. In tal modo, quindi, quest'ultima iniziava a poter disporre più liberamente rispetto al passato delle finanze comuni.
Fu tuttavia con la fine - o comunque con il forte ridimensionamento - del pericolo persiano, che Atene cominciò ad assumere atteggiamenti apertamente dittatoriali nei confronti dei propri alleati. In particolare, in forza della sua netta superiorità militare, essa si diede a 'dissuadere' tutti quegli stati che cercavano di staccarsi dalla Lega, soprattutto per liberarsi dagli oneri tributari che una tale adesione comportava. (Celebri sono rimaste le spedizioni punitive, ai danni dell'isola di Nasso e della città di Bisanzio, da parte dalle truppe ateniesi).
Atene inoltre, in qualità di potenza egemone della stessa Lega marittima, finì per sobbarcarsi l'onere di dirimere - con vantaggio non solo proprio, ma anche degli alleati - le diverse questioni che insorgevano tra gli stati membri.
E' chiaro dunque, come la capitale dell'Attica fosse oramai divenuta il centro di un'area pressoché omogenea da un punto di vista politico e commerciale, la 'Roma' di un vasto impero marittimo che si estendeva dal bacino egeo fino alle zone degli Stretti e del Mar Nero.
Sempre in questi anni inoltre, Atene fondò - con vantaggi economici e finanziari non indifferenti - la colonia di Anfipoli nel Pangeo (Tracia), una zona molto ricca di risorse minerarie.
-- Atene negli anni prima della guerra, l'opposizione a Pericle --
La politica di Pericle, come si è detto, non fu di certo immune dalle manie di grandezza del suo ideatore. Proprio per tale ragione essa, nel corso dei decenni, costò ad Atene un'ostilità sempre maggiore da parte degli stati alleati, e a Pericle quella di una buona parte dei concittadini. [3]
Non è un caso quindi, che gli ultimi anni dell'era di Pericle (ovvero quelli che precedettero di poco lo scoppio della guerra, oltre ai primi due della stessa), fosse politicamente più incerti e contrastati rispetto ai precedenti.
Soprattutto, sul fronte interno, Pericle dovette fronteggiare sia l'ostilità degli oligarchi, che non gli perdonavano innanzitutto la svolta ultra-democratica (…qualcuno direbbe 'demagogica'!) impressa alla città, sia quella dei ceti più poveri (i piccoli proprietari) che non condividevano alcuni aspetti della sua politica, molto più favorevole agli interessi dei ceti commerciali che non ai loro. (L'espansionismo militare difatti, uno dei perni della strategia periclea, era molto più vicino alla sensibilità delle classi commerciali, che non a quella dei modesti possidenti che vivevano dei frutti delle proprie terre (una categoria, quest'ultima, logorata da tempi immemori - come si ricorderà - dall'avidità di latifondisti e nobili)).
D'altra parte, non bisogna neanche dimenticare che proprio a Pericle si dovette la fondazione delle "cleruchìe" : specie di zone franche all'interno dei territori dei vari staterelli della Lega, riservate appositamente ai cittadini ateniesi, e governate attraverso le leggi della loro città… insomma, quasi dei distaccamenti di Atene fuori dal suo territorio!
Esse - come poi avverrà anche per le colonie fondate dai romani sui territori italici, nei primi secoli della Respublica - avevano la funzione di favorire la reintegrazione economica e sociale dei cittadini meno abbienti della capitale, e testimoniano l'attenzione dello stesso Pericle per gli squilibri sociali che affliggevano la sua città.
[1] Non si deve infatti dimenticare che la Lega beotica fu sciolta per iniziativa degli Spartani, capi della coalizione degli stati greci (la Simmachia ellenica), al termine della guerra contro i Persiani, in ragione della neutralità compiacente degli stati componenti. I capi del partito filo-persiano, inoltre, vennero pubblicamente giustiziati sull'Istmo di Corinto (Cfr. paragrafo sulle Guerre persiane). (torna su)
[2] Né si deve dimenticare come, sotto Pericle, Atene conoscesse una vera e propria fioritura di nuovi monumenti, tra i quali il celeberrimo Partenone. Egli inoltre raccolse nella sua città - come prima di lui avevano già fatto soprattutto i tiranni - molte figure sia dell'arte che della cultura del suo tempo, tra le quali lo scultore Fidia e il filosofo Anassagora. (torna su)
[3]
Un'ostilità che si tradusse anche in una vera e propria persecuzione
di tipo giudiziario.
Sebbene infatti Pericle fosse inattaccabile sul piano personale (data
la sua inattaccabile onestà e la sua indefessa dedizione alla causa
ateniese), fioccavano le accuse ai danni di molti personaggi del suo seguito:
tra essi ricordiamo la sua amante e consigliera Aspasia (una delle più
belle e influenti etère ateniesi), lo scultore e architetto Fidia
(che finì i suoi giorni in carcere), e il filosofo Anassagora (che
fu costretto all'esilio). (torna su)