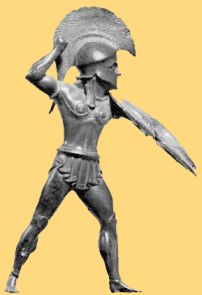LA GRECIA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Storia ed evoluzione della Grecia classica
La Grecia prima di Pericle
(a) Conservatori e rivoluzionari
Come già si è accennato, furono due le linee politiche che si contesero il primato in Grecia (e non solo ad Atene…) al termine delle guerre persiane: una che potremmo definire maggiormente innovatrice e rivoluzionaria, l'altra - al contrario - più propensa a proseguire la lotta contro il grande Impero asiatico, conservandone i presupposti.
|
Per i sostenitori di quest'ultima, se da una parte era fondamentale continuare nell'impresa di liberazione dei territori greco-asiatici dal dominio del Gran Re persiano (concentrando inoltre molte energie per il loro mantenimento), dall'altra era anche necessario - come logica conseguenza - conservare più salda possibile la precedente alleanza tra gli stati ellenici: in sostanza cioè, tra la zona orientale (riunita sotto la Lega Delio-attica, e capeggiata da Atene) e quella occidentale peloponnesiaca, guidata da Sparta. |
|
D'altra parte, poco dopo la nascita della Lega marittima ateniese (478), si era stabilito di comune accordo che fossero le regioni orientali ed egee a sobbarcarsi l'onere della difesa dei confini asiatici, mentre a Sparta sarebbe toccato il compito di vigilare sull'unità e sull'ordine delle zone più interne.
Si era perciò giunti all'instaurazione di un pacifico equilibrio all'interno del mondo ellenico, un equilibrio tutto sommato vantaggioso per entrambe le parti.
Ma fino a quando - anche data l'inevitabile tendenza espansionistica del blocco democratico filo-ateniese - un tale equilibrio si sarebbe potuto realmente mantenere !?
Per i sostenitori della linea 'rivoluzionaria', al contrario, priorità assoluta era quella di scardinare l'assetto di potere attuale, approfittando dei movimenti di rinnovamento in senso democratico che - ora più che mai - si andavano diffondendo anche in molte zone del Peloponneso, un territorio tradizionalmente filo-spartano.
Né, inoltre, gli esponenti di tale corrente - primi tra tutti, l'ateniese Temistocle e lo spartano Pausania, che erano stati entrambi personaggi di spicco nella lotta contro i Persiani - erano del tutto immuni da simpatie - seppure meramente strumentali - nei confronti del potere del Gran Re persiano (lo stesso, si badi, contro il quale avevano strenuamente combattuto!) cui chiedevano, sotto banco, sostegno per il mantenimento delle proprie posizioni, logorate dai nemici interni.
Due opposte posizioni quindi : l'una mirante a conservare lo status quo, sia portando avanti la lotta contro il dominio persiano, sia cercando un accordo e un equilibrio di potere tra gli stati filo-spartani e quelli filo-ateniesi; l'altra, al contrario, mirante a scardinare gli equilibri - peraltro già decisamente precari - che si erano venuti a creare, favorendo il dilagare in Grecia della corrente democratica, tutta a favore (almeno per il momento) di un predominio attico!
Dallo scontro tra queste due correnti, quella conservatrice e moderata, e quella progressista e rivoluzionaria, non sarebbe forse potuta sorgere - qualora, come vedremo in seguito, la seconda fosse riuscita a prevalere per tempo sulla prima - una Grecia molto differente da quella che oggi conosciamo, al cui interno un ruolo nettamente predominante avrebbe svolto Atene, a seguito di un potente ridimensionamento dell'influenza di Sparta e della sua Lega, confinate in una zona marginale nell'estremo lembo sud-occidentale della penisola peloponnesiaca? Il fatto poi che le cose non andassero realmente così, non deve portarci a credere che un tale sviluppo fosse impossibile.
(b) Sparta fino alla fine di Pausania
La prima manifestazione rivoluzionaria del dopoguerra persiano (anche se, in realtà, le guerre contro i Persiani finirono ufficialmente solo con la pace di Callia, nel 449) si ebbe con le azioni militari di Pausania, comandante della coalizione ellenica e guida di molte delle precedenti imprese di riconquista delle regioni asiatiche, da Micale sino a Sesto.
Attraverso la propria autorità militare e il proprio carisma personale, questi minacciava difatti di divenire una specie di sovrano indipendente rispetto alla propria città di provenienza, Sparta, i cui possedimenti coincidevano inoltre con alcune zone di influenza tradizionalmente ateniese. Egli in tal modo muoveva le ire di entrambe le città.
Fu perciò Cimone (di cui parleremo nel prossimo paragrafo), leader politico ateniese di orientamento conservatore e filo-spartano, a sconfiggerlo presso Bisanzio nel 476, costringendolo così a ritornare in patria, dove - presto o tardi - avrebbe dovuto confrontarsi con l'ostilità degli efori e in generale del potere costituito.
E fu forse per evitare un tale confronto, che Pausania si alleò con gli Iloti, impegnati in quegli anni nella preparazione di una nuova insurrezione antispartana (in seguito alla quale sarebbe poi scoppiata la terza guerra messenica), aggiungendo così una nuova accusa a quelle - tra le quali, quella di aver cospirato con il Gran Re di Persia - già pendenti sul suo capo.
La fine di Pausania, accusato di avere attentato all'integrità dello Stato e autocondannatosi alla morte per stenti, dopo essersi rinchiuso nel tempio di Atene Calcieca (467) per sfuggire ai suoi nemici, segnò il trionfo definitivo della linea tradizionalista all'interno del governo di Sparta.
Pare inoltre che Pausania - come, del resto, in quegli stessi anni l'ateniese Temistocle - intrattenesse dei contatti anche con quelle correnti democratiche, diffuse un po' in tutto il Peloponneso, che minavano dall'interno l'integrità del blocco tradizionalista e oligarchico. La sua azione era quindi mirata in un senso abbastanza simile a quello delle forze progressiste ateniesi, con le quali col tempo si sarebbe quasi certamente alleato.
L'intervento degli efori, quindi, aveva bloccato sul nascere una situazione i cui sviluppi sarebbero stati senza dubbio molto pericolosi per la stessa egemonia spartana.
Ma i guai per Sparta non erano ancora terminati. Negli anni successivi, infatti, le sarebbe toccata un'impresa ancora più ardua: quella cioè di placare, ancora una volta, dei pericolosi moti insurrezionali ad opera delle popolazioni sottomesse, gli Iloti
(c) Atene fino alla morte di Efialte
Con la scomparsa di Pausania, gli efori avevano dunque riaffermato il proprio tradizionale potere sulla città di Sparta, e con esso la linea "dura" contro i propri avversari sia interni che esterni. La loro era stata perciò, una vittoria della tradizione sulle (sempre latenti) forze della rivoluzione.
Una lotta per molti versi analoga, si svolgeva in quegli stessi anni ad Atene. Qui, i due opposti schieramenti erano guidati l'uno dal 'vecchio' leader Temistocle, uno dei protagonisti delle guerre persiane, e l'altro dal suo giovane avversario Cimone (aristocratico, figlio di Milziade), sostenitore di una politica fondamentalmente filo-spartana.
Il primo insisteva - già peraltro dai tempi delle guerre persiane - per portare avanti delle nuove misure difensive per la città, misure che si erano tradotte nell'erezione delle mura che ne circondavano il perimetro e nella fortificazione del Pireo (il porto di Atene). Egli voleva difatti preparare Atene per quello che sarebbe stato lo scontro militare con la rivale Sparta.
La politica di potenza ateniese non doveva quindi, secondo tali progetti, tenere alcun conto dei precari equilibri stabilitisi all'interno della compagine degli stati greci, frutto in realtà di esigenze passeggere legate alla guerra contro la Persia.
Cimone viceversa, pur credendo anch'egli nella 'missione imperialistica' ateniese, propendeva (anche a causa delle proprie origini nobiliari, cui doveva un profondo istinto conservatore) per un'espansione in sostanza solo marittima di Atene, il cui scopo inoltre doveva essere anche quello di difendere la compagine greca dal nemico persiano : un'espansione rispettosa quindi delle aree di influenza spartana e della dignità di un tale (storico) colosso!
Nonostante poi una tale visione sia agli occhi di noi moderni passibile di una critica fondamentale, quella cioè di avere impedito alle città-stato filo-ateniesi di sferrare un attacco (che sarebbe forse stato decisivo) contro il blocco spartano, bisogna anche riconoscere come con le sue azioni militari egli riuscisse a portare a termine imprese di grande rilevanza nella lotta contro i Persiani, consolidando il prestigio e il primato di Atene all'interno della Lega Delio-attica. La sua politica quindi, seppure fu indiscutibilmente troppo tenera verso le forze oligarchiche della Laconia, portò ad Atene anche dei grandi vantaggi.
Impresa decisiva di Cimone fu la storica vittoria sui Persiani presso il fiume Eurimedonte (465): un'impresa con cui, se da una parte allontanò una volta di più il pericolo persiano dai mari e dalle coste egee, consolidò dall'altra la propria posizione di preminenza politica nei confronti della parte avversa - e in primis proprio di Temistocle - ad Atene.
Con la sconfitta dei nemici presso l'Eurimedonte, dunque, egli otteneva contemporaneamente un successo su due fronti: rendeva infatti Atene padrona (quasi) incontrastata del mare egeo, e incoronava se stesso leader indiscusso dell'Attica.
Temistocle, d'altro canto, era stato allontanato dalla città attraverso la misura dell'ostracismo negli anni precedenti (470), e si era rifugiato nella vicina - e democratica - città di Argo, da dove collaborava (essendone uno, se non il principale, dei capi carismatici) con le forze ostili al dominio spartano nel Peloponneso.
Espulso successivamente anche da Argo, in seguito a pressioni esercitate sulla città dagli efori spartani che gli muovevano accuse di collaborazionismo in funzione anti-ellenica sia con Pausania che con la Persia, trovò rifugio presso il Gran Re (Artaserse I), suo ex-nemico, che lo incoronò tiranno di una città, quella di Magnesia, situata sulle coste anatoliche ancora in mani persiane, dove visse fino alla morte.
D'altro canto, anche la fortuna di Cimone era destinata presto a finire, ciò che avvenne poco dopo la sfortunata spedizione fatta dagli ateniesi in difesa degli spartani (464), durante la terza guerra messenica.
Dopo solo un mese di assedio alla città di Itome, infatti, le truppe di questi ultimi venivano rimandate indietro dai loro stessi alleati. Un evento che costituì per Atene uno smacco tale da compromettere definitivamente la popolarità di Cimone, il quale, condottiero della spedizione, l'aveva concepita come una dimostrazione di amicizia verso la città di Sparta (…vedremo tra poco le ragioni che, molto probabilmente, furono alla base del rifiuto spartano). Il politico ateniese subiva così la stessa sorte del suo avversario, essendo costretto a prendere la strada dell'esilio (461).
Con la fine del predominio aristocratico di Cimone, riprendevano vigore ad Atene le forze democratiche più radicali.
Queste trovarono in Efialte un nuovo leader. Obiettivo primario di quest'ultimo fu quello di limitare ulteriormente il potere dell'Areopago, un'istituzione nobiliare di antichissime origini, trasferendone le principali competenze giuridiche e politiche alle più giovani istituzioni democratiche : l'Ecclesia, la Bulè e l'Eliea. Egli portava avanti, in tal modo, quella trasformazione della polis in senso democratico inaugurata da Clistene e, in seguito, ulteriormente rafforzata da Temistocle.
L'Areopago, pur non perdendo il privilegio della carica a vita (che rendeva i suoi componenti esenti in sostanza dal controllo e dal giudizio dei cittadini!), cessava così di svolgere attività politicamente significative, divenendo un'istituzione in gran parte religiosa, e il cui unico ruolo reale restava il giudizio sui delitti di sangue.
Ma tale passaggio di consegne politiche determinò anche un notevole cambiamento nella politica estera ateniese.
Con la fine del pericolo persiano infatti, la Lega Delio-Attica diveniva sempre di più un'associazione a fini commerciali, dei cui proventi si avvantaggiava in massima parte proprio Atene, la più ricca e potente delle città-stato che la componevano.
Sempre per iniziativa delle forze democratiche anti-spartane poi, essa cessava ufficialmente di far parte della Simmachia greca, interrompendo quindi l'alleanza con Sparta, e divenendo una potenza indipendente a tutti gli effetti: la base in sostanza del futuro impero commerciale e marittimo ateniese.
(d) Un bilancio finale: la politica isolazionista spartana e l'ineluttabilità del conflitto con Atene
Si è già visto come, ad Atene, i politici di orientamento più conservatore fossero propensi a mantenere pressoché inalterati gli equilibri di potere instauratisi all'interno della compagine greca nel corso delle guerre persiane. Essi difatti volevano un'Atene forte, i cui orizzonti di influenza però si estendessero soprattutto verso est, quindi verso il mare e le coste egee, e che fosse al tempo stesso affiancata da una Sparta altrettanto - se non più - influente a livello ellenico, come del resto era sempre stato, e il cui dominio si spingesse verso le zone occidentali e interne della Grecia.
D'altra parte, dopo il grottesco fallimento nel 462 della spedizione delle truppe ateniesi in favore degli spartani (durante l'assedio alla città ribelle di Itome), un tale tipo di politica aveva conosciuto una brusca interruzione. Era difatti divenuto chiaro a tutti come le forze oligarchiche, capeggiate da Sparta, non avessero nessuna intenzione di avallare l'alleanza con Atene! Era ormai evidente, in altri termini, come il progetto 'reazionario' di Cimone - pur avendo favorito la ripresa della potenza spartana, quando essa si era trovata veramente in difficoltà e pericolo - non avrebbe mai potuto trovare un effettivo riscontro nella politica di quest'ultima.
Cerchiamo dunque di capire le ragioni della ritrosia e della diffidenza delle elitès spartane e filo-spartane, nei confronti delle manifestazioni di amicizia e di solidarietà di Cimone, e più in generale delle forze conservatrici e filo-oligarchiche ateniesi.
La ragione essenziale di tale atteggiamento fu senza dubbio il timore di 'contaminazioni' politiche, dovute appunto al contatto con un tale tipo di civiltà, di carattere democratico (ragione che fu peraltro anche all'origine, durante la terza guerra messenica, della decisione di respingere l'aiuto delle truppe ateniesi). Il contatto con le idee e con il clima stesso della democrazia infatti, era considerato da tali elitès estremamente pericoloso, in quanto potenzialmente foriero - malgrado magari le reali intenzioni dei capi ateniesi - di atteggiamenti ostili all'assetto politico dei propri stati!
Le trasformazioni sociali degli ultimi secoli avevano infatti portato, più o meno in tutta la Grecia, alla formazione di una vasta classe intermedia, la cui ricchezza dipendeva essenzialmente da attività di natura non agricola, bensì commerciale e artigianale. Ad un tale fenomeno era connesso l'emergere di nuove concezioni politiche, le quali - seppure di solito non pienamente democratiche - propendevano in ogni caso per una maggiore partecipazione popolare alla vita politica (ovvero alle attività decisionali) dello stato.
Laddove dunque le classi 'alte' erano riuscite a mantenere un sostanziale predominio politico sui ceti popolari, si imponeva da parte di esse (e quindi dello stato stesso) un atteggiamento di forte chiusura nei confronti di quelle città in cui invece tali trasformazioni erano oramai divenute un dato di fatto!
Per tale ragione quindi, l'illusione, di cui furono schiave le classi alte ateniesi, di potere mantenere un'amicizia e un'alleanza politica con la roccaforte per eccellenza del potere aristocratico e gentilizio, Sparta, e più in generale col blocco degli stati da essa capeggiato, rimanendo al tempo stesso fedeli a una concezione pienamente democratica, doveva andare inevitabilmente incontro a un drastico fallimento.
Oltre a ciò, si consideri il fatto che Atene stava estendendo ormai da anni la propria sfera di influenza su molte delle vicine città-stato, alcune delle quali (una per tutte, Argo) erano così uscite dall'orbita della grande potenza spartana… e ciò ovviamente con grande disappunto di quest'ultima!
Atene, insomma, diveniva oramai una potenza economica e politica alternativa a quella - più antica - della capitale della Laconia, oltre che l'astro ideologico di quegli stati che (magari a furor di popolo) desideravano emanciparsi da forme di dominio oramai antiche, considerate oppressive e inadeguate.
Si presenta spontanea dunque, la considerazione secondo la quale la ritrosia di Cimone e delle fazioni aristocratiche e conservatrici ateniesi a sferrare un attacco alla potenza rivale (oltre che a maturare degli autonomi progetti di carattere espansionistico) giovasse senz'altro molto più alla causa spartana, che a quella ateniese - nonché in generale a quella democratica greca.
Ed è altresì chiaro in che senso una maggiore fermezza nel combattere contro gli stati oligarchici filo-spartani (auspicata peraltro da uomini come Temistocle) avrebbe potuto portare - se attuata per tempo - ad una vittoria piena della democrazia, evitando al tempo stesso lo scoppio di quelle successive guerre intestine, dette guerre peloponnesiache, che divisero ulteriormente, e fiaccarono, le città-stato greche.