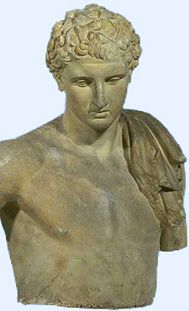LA GRECIA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Storia ed evoluzione della Grecia classica
L'Impero persiano
Riassumeremo, qui di seguito, le tappe fondamentali che portarono lo stato dei Medi e dei Persiani dalla sua originaria estensione, a quella cui era giunto alla vigilia delle guerre contro le città-stato elleniche. Ma ci soffermeremo anche - argomento ben più interessante! - sui modi e sui mezzi attraverso i quali un tale tipo di dominio poté essere conquistato prima, e successivamente conservato.
|
(a) Evoluzione della Persia tra VII e VI secolo Iniziamo a conoscere qualcosa della Persia (una piccola regione, posta nella zona elamitica sud orientale) soltanto a partire dal settimo secolo. Quando i Medi, popolazione appartenente al medesimo ceppo linguistico dei persiani, erano già un popolo avanzato, in grado di abbattere - in concomitanza con i Babilonesi - la grande potenza assira (612), la Persia rimaneva ancora una regione marginale, associata tradizionalmente ai suoi 'fratelli maggiori'. |
|
Tanto più strano dunque, può apparire il processo attraverso cui - nel corso di giusto due o tre generazioni di regnanti - essa divenne la maggiore potenza asiatica, capace di sbaragliare le difese di tutti gli altri stati orientali: dalla Media appunto, alla Lidia, alla Babilonia, all'Egitto, ecc., sottomettendoli al proprio dominio.
Vediamo ora le tappe fondamentali di questo cammino.
Protagonisti di questa trasformazione furono tre sovrani: Ciro II detto "il grande" (558-530), Cambise II (530-522) e Dario (522-486). Serse invece (486-465), figlio di quest'ultimo, non aggiunse - anche considerando il fallimento dell'impresa contro la Grecia - territori significativi all'Impero, limitandosi a consolidarne i confini.
Le conquiste di Ciro furono: a) la Media (550), annessa dopo aver sconfitto militarmente il sovrano Astiage; b) la Lidia (540), con la vittoria sul celebre re Creso; c) ed infine l'impero di Babilonia (539), dopo la vittoria sul re Nabonedo. Il soprannome "il grande", con cui egli passò alla storia, si dovette proprio alla vastità delle sue conquiste e alla magnificenza delle sue imprese, che posero le basi territoriali stesse dell'Impero persiano.
Dopo Ciro, il regno passò a suo figlio Cambise, la cui impresa principale consisté nella conquista dell'Egitto (l'ultima sopravvissuta tra le grandi potenze del passato) (525), con l'allestimento di un'imponente flotta navale.
Alla sua morte inoltre, si ebbe una prima crisi dinastica, al termine della quale la dignità regale fu conquistata dal primo sovrano achemenide, un certo Dario, in realtà usurpatore del trono.
A quest'ultimo, si dovette soprattutto l'ampliamento del regno verso il nord, in direzione cioè delle regioni della Tracia, della Macedonia e della Scizia.
Le sue imprese militari, rafforzando ulteriormente il dominio persiano nelle zone liminari della Grecia e nelle isole greco-egee, posero le basi della guerra - avvenuta pochi anni dopo (499-494), e conclusasi con un successo persiano - che egli portò avanti contro le città-stato ioniche. Tale espansione verso nord infatti, estendendo il dominio politico su località tradizionalmente elleniche, quali ad esempio quelle poste nella regione degli stretti o sulle coste del Mar Nero, alimentò l'insofferenza dei greci nei confronti della dominazione persiana.
(b) Formazione e struttura dello stato persiano
Più interessante tuttavia delle tappe dello sviluppo territoriale dell'Impero persiano, è senza dubbio - almeno per il presente scritto - la comprensione delle strutture e delle strategie attraverso le quali esso riuscì a mantenersi sano e vitale per circa due secoli, fino cioè alla sua dissoluzione ad opera di Alessandro il Macedone, nel quarto secolo.
Base della potenza persiana furono gli eserciti. Fu grazie a essi difatti, che fu possibile ai sovrani ampliare smisuratamente i confini del proprio regno. Alla base del processo di formazione dell'Impero persiano infatti (come del resto, due secoli più tardi, di quello di Alessandro Magno) non vi fu soltanto il graduale accrescimento dei territori sottomessi, ma anche quello - peraltro conseguenza del primo - delle proprie potenzialità militari, ogni conquista comportando un incremento degli eserciti e più in generale delle risorse da destinare a nuove imprese di conquista.
Quello persiano insomma - più ancora di quelli precedenti - fu un dominio basato in primo luogo sulla forza e sulla coercizione.
Al periodo dell'invasione e della sottomissione, seguiva quello dell'instaurazione di una nuova classe di potere, composta solitamente da altissimi funzionari persiani, la quale si sostituiva alla precedente sfruttandone al tempo stesso le strutture politiche e di potere. Tale instaurazione inoltre, quasi mai poteva prescindere dall'alleanza con le elités locali, senza il cui appoggio il proprio dominio sarebbe stato estremamente incerto e difficoltoso. Anche per tale ragione, i persiani ostentarono (quasi) sempre un profondo rispetto nei confronti delle tradizioni amministrative e religiose locali, cui in linea di massima - pur con le dovute 'modifiche' - scelsero di appoggiarsi.
Le varie province si chiamarono satrapie, e coincisero a grandi linee con i confini dei regni prima indipendenti (la Lidia, La Mesopotamia, ecc.). I loro amministratori, detti satrapi, goderono d'altra parte di grandi autonomie rispetto al potere centrale (il che non significa, però, che fossero del tutto indipendenti da esso!), essendo tra l'altro la loro una carica a vita.
Il rapporto tra i poteri locali e il potere centrale (ovvero quello del Gran Re) se da una parte fu improntato a una profonda deferenza, fu caratterizzato dall'altra anche da un pragmatico decentramento e da una notevole libertà amministrativa. Ogni regione difatti aveva delle proprie tradizioni particolari, impossibili da estirpare da un giorno all'altro, e che di conseguenza era assolutamente necessario assecondare.
Per tale ragione, il governo persiano si esplicò sempre in modi e forme profondamente differenti da zona a zona. Le città stato ioniche, ad esempio, trovarono un compromesso tra le proprie tradizioni politiche e l'esigenza di un controllo dall'esterno, attraverso l'instaurazione di regimi tirannici. Questi ultimi difatti, coniugavano bene identità greca e regime assolutistico orientale (fu in questo periodo, infatti, che la parola e il concetto "tirannide" iniziarono ad assumere un significato assolutamente negativo). La Mesopotamia invece, terra con un antico e glorioso passato, fu annessa con alcuni privilegi, che la ponevano (almeno formalmente) sullo stesso piano della Persia. E così via…
Altri mezzi di asservimento al potere del Gran Re persiano furono le pratiche vessatorie (una per tutte, quella delle deportazioni di massa) nei confronti delle popolazioni ribelli all'autorità centrale, pratiche peraltro rese possibili dalla grande facilità nel reclutare grandi quantità di soldati mercenari (tra i quali comparivano molti Greci) tra le popolazioni asservite.
Ma anche l'usanza del Sovrano di viaggiare costantemente all'interno dell'Impero (a proposito della quale si è spesso parlato di "regalità itinerante"), facendo visita ora all'una ora all'altra nazione e alle elités locali, oltre a quella di innalzare a un rango vicino al proprio soggetti particolarmente 'meritori' provenienti da ogni parte del regno, ebbero un peso notevole nel mantenimento del prestigio e della fedeltà dei sudditi.
Nonostante ciò, non infrequenti furono gli episodi di ribellione a livello regionale, soprattutto da parte delle zone più ricche e dal passato più glorioso (stati come l'Egitto in particolare - o come la Mesopotamia - si mostrarono spesso profondamente riottosi di fronte alla dominazione straniera). Tali eventi, in linea di massima, furono sempre causati dalle popolazioni indigene, mai dai satrapi o dalle elités persiane, le quali infatti governavano in nome del Gran Re (da cui traevano significato e quindi legittimazione).
Va anche ricordato come, attraverso l'utilizzo della forza, la Persia riuscisse sempre - presto o tardi - ad avere la meglio su tali 'ritorni' di orgoglio nazionale.
Un ultimo cenno infine, va fatto in merito al rapporto vigente tra la proprietà del Sovrano e la proprietà dei sudditi.
Come in tutti gli stati asiatici, anche in Persia era il Sovrano a essere (formalmente) padrone unico di tutte le terre e - più in generale - di tutti i beni. Ed anche il Gran Re persiano (come i sovrani degli altri regni dell'Asia minore, e non solo) si riteneva investito della propria autorità somma da un Dio, in questo caso Ahuramazda, in nome e per ispirazione del quale governa per il bene dei suoi sudditi!
Tuttavia, nella realtà dei fatti, il re non poteva avere un controllo diretto di tutti i territori del suo Impero, ragion per cui essi venivano per così dire concessi in usufrutto sia alla nobiltà locale (la quale in tal modo diveniva alleata e complice dei dominatori), sia ad alti funzionati persiani [1]. Ovunque poi, vari territori rimanevano proprietà diretta dell'Imperatore, essendo amministrati da uomini di sua fiducia.
Le uniche proprietà totalmente inalienabili, e quindi virtualmente private, erano quelle di più modesta entità, come ad esempio quelle concesse ai soldati, oppure quelle derivanti da piccole attività private come il commercio, la produzione artigianale, ecc.
Non bisogna inoltre dimenticare che gli Stati asiatici avevano sviluppato già da tempo un elaborato sistema fiscale e tributario, che fu ripreso ovviamente dall'amministrazione persiana, e che ogni satrapia doveva pagare con cadenza regolare un certo tributo al Gran Re, oltre a dover fornire - in periodi di guerra - uomini abili alla leva.
Dal canto suo invece, il Gran Re (ovvero il potere centrale da lui simboleggiato) coordinava le attività riguardanti l'intero territorio dell'Impero (quali ad esempio le operazioni belliche, la costruzione e la manutenzione delle opere pubbliche, o la soluzione di questioni legali tra i diversi stati - in particolar modo di quelle riguardanti i confini, ecc.), garantendo così il mantenimento di una "pax Achaemenidica", garanzia di ordine e sicurezza all'interno dei confini del regno, con vantaggi diffusi tra un po' tutta la popolazione.
Nel complesso dunque, non vi era - né forse avrebbe potuto esserci - un rapporto troppo sbilanciato tra centro e periferie, né a vantaggio del primo né a vantaggio delle seconde. In complesso, la regalità persiana si basò sul principio del reciproco vantaggio, ovvero su un'idea di dare/avere. Anche per tale ragione, un Impero così variegato riuscì a mantenersi discretamente saldo per due secoli e più, nonostante le profonde differenze culturali che conteneva al suo interno.
[1] Si parla a questo proposito di "feudalesimo asiatico", in contrapposizione a quello occidentale, nel quale i feudatari sono effettivamente padroni dei propri territori, e in cui perciò il potere del monarca è estremamente ridotto.
Ci pare inoltre interessante citare qui di seguito un brano di Ezio Savino, nel quale si descrivono molto in sintesi le caratteristiche organizzative salienti dell'Impero persiano del V-IV secolo: "Dario plasmò il magma di genti e tradizioni incluse nei confini, creando un equilibrio tra la centralità assoluta del trono e le pluralità locali. Emblema vivente dell'Impero era il monarca, vicario del dio supremo Ahura-Mazda, da cui irraggiava una spinta prodigiosa a dominare la totalità del mondo. Tutto era possesso del sovrano: uomini e beni. Egli era destinatario dei tributi e capo delle forze armate. Le <<province>> (satrapie) conservavano forme di autonomia culturale e religiosa, subendo però limiti vistosi nella sfera economica: esazione dei tributi, leve coatte, direttive centrali rigide sulle attività produttive e mercantili. Al governo delle province era il <<satrapo>>, nominato dal Re e in ogni momento destituibile. Un cancelliere e un generale dell'esercito lo affiancavano, definendone i poteri. Ispettori viaggianti, <<gli occhi e le orecchie del Re>>, perlustravano le satrapie, riferendo al sovrano sullo stile dell'amministrazione, e sulla docilità dei governatori. Questi funzionari imperiali facevano da deterrente alle ambizioni dei notabili periferici, non di rado ansiosi di autonomie eccessive, e autori di aperte rivolte.
Concreti fattori di coesione erano una rete viaria estesa ed efficiente, per movimenti rapidi di notizie, comandi, truppe, e la circolazione di una moneta unitaria - il darico, la moneta di Dario - che garantiva ordine agli scambi commerciali interni e all'afflusso dei tributi". (torna su)