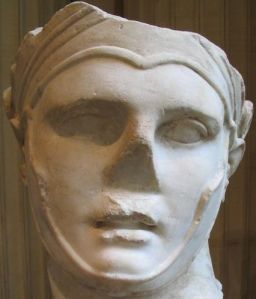LA GRECIA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Storia ed evoluzione della Grecia classica
2-
Sviluppi sociali e politici del mondo greco:
le città-stato e la loro
organizzazione
Novità fondamentale dell'età arcaica fu l'apparizione delle poleis, ovvero delle città-stato : prodotto non soltanto delle trasformazioni che seguirono, ma anche di quelle precedettero (e resero possibile) la formazione e la grande diffusione delle colonie.
Furono difatti i villaggi gentilizi dell'età buia a porre le basi stesse delle successive formazioni cittadine e comunitarie. E il loro sviluppo sfociò - seppure attraverso un processo lungo e graduale - nella nascita delle poleis greche.
|
Come si è detto, le stirpi dominanti che avevano invaso le diverse regioni della madrepatria si erano spartite tra loro i nuovi territori, mantenendo in una condizione di sudditanza i loro precedenti abitatori. A questi ultimi poi - quantomeno laddove la frattura tra esproprianti e espropriati si sviluppò in un modo meno radicale - fu probabilmente concesso a volte di rimanere proprietari, seppure a titolo personale e individuale, di piccoli appezzamenti terrieri. |
|
Ciononostante, furono le stirpi (ghenoi) dominanti ad appropriarsi della maggior parte delle terre. E ciò fu alla base di quel dislivello nella proprietà patrimoniale (che col tempo inoltre conobbe un'ulteriore recrudescenza) che generò, sia durante il periodo arcaico che durante quello classico, dei gravi conflitti sociali.In un tale clima generale, oramai estremamente mutato, non aveva più molto senso l'istituto monarchico (il quale tuttavia sopravvisse ancora per alcuni secoli); così come del resto le strutture palazziali, prima centro della vita sociale, finirono gradualmente per decadere e scomparire. Si affermò invece un nuovo tipo di struttura: cioè il villaggio come residenza - di solito - di un'oligarchia dominante, il luogo nel quale quest'ultima discuteva i propri affari, tenendo vivo al tempo stesso il sentimento della propria superiorità (in quanto casta egemone) nei confronti della popolazione rimanente (che potremmo definire la 'plebe' greca).
Dal Palazzo come centro direttivo di un potere unidirezionale, si passò così al villaggio come sede di un'aristocrazia di carattere gentilizio, caratterizzata quindi da sfumature 'democratiche' (si ricordi a questo proposito il carattere socialistico delle antiche comunità gentilizie, cfr primo paragrafo).
In un tale contesto vennero poste appunto le basi delle future città-stato: al tempo stesso derivazione dei villaggi dei secoli precedenti, e loro sviluppo in un senso sempre più estraneo alla logica gentilizia (basata sull'identificazione della comunità con un'unica stirpe d'origine) e a quella delle caste (fondata sulla una stratificazione sociale rigida e inalterabile) - il tutto, come vedremo, con la sola eccezione di Sparta!
- Caratteri generali delle poleis greche
Anche se le poleis greche conobbero nel loro complesso un vasta gamma di forme politiche (oligarchia, timocrazia, democrazia, tirannide…), si possono tuttavia individuare a livello socio-politico dei tratti evolutivi comuni. E se è vero che - come si è appena detto - la città di Sparta costituì una lampante anomalia rispetto alla situazione generale, bisogna anche ricordare che essa non ebbe mai eguali né nel mondo antico (e non soltanto in quello greco) né in quello moderno. Essa costituì quindi, in un certo senso, l'eccezione che conferma la regola.
I tratti di fondo alla base della trasformazione delle antiche comunità oligarchiche e gentilizie dell'età oscura furono essenzialmente due: a) da una parte vi fu la crescita degli squilibri legati alla grande proprietà, a spese, ovviamente, della precedente situazione di parità sociale (riguardante tuttavia soltanto i membri della casta dominante), b) dall'altra invece vi fu l'emergere sul piano politico, su quello economico e su quello militare (tre piani peraltro strettamente interconnessi) di un ceto intermedio tra le due precedenti condizioni: la povertà quasi assoluta dei piccoli contadini e dei braccianti, e l'estrema ricchezza fondiaria dei nobili.
Lo stato greco moderno nacque dunque dall'azione concomitante di tali fattori. Se infatti, attraverso lo sviluppo della grande proprietà si affermò, oltre al diritto al possesso privato dei beni immobiliari, anche quello ad un loro indefinito ampliamento; dall'altra, il progressivo emergere delle classi medie - nonché in generale delle prime e aspre lotte sociali tra ceti nobiliari e non - pose le basi dei successivi sviluppi democratici (basati sulla parificazione dei diritti politici tra i cittadini) del mondo greco, e in generale di quello occidentale.
Ma come si giunse alla formazione di squilibri tanto accentuati in seno alla proprietà terriera?
Si possono fare molte ipotesi in merito. E' certo comunque che tra VIII e VII secolo si fosse giunti oramai a un forte accentramento di carattere fondiario a favore di una classe molto ristretta, la nobiltà, cioè alla dissoluzione della precedente comunità oligarchica gentilizia in favore di un'altra numericamente ancor più limitata, contrapposta ad una sempre crescente massa di poveri. Si consideri inoltre che il periodo in questione si sviluppò in massima parte lungo i cosiddetti secoli bui, dei quali non ci restano che poche tracce archeologiche e nessun (affidabile) documento scritto.
Si può ipotizzare in ogni caso che una delle ragioni della diminuzione graduale del numero dei proprietari fu l'isterilimento delle famiglie dominanti; oppure - al contrario - fu una prima divisione dei patrimoni fondiari tra eredi maschi, cui nel corso dei secoli seguì una ricomposizione assai meno paritaria rispetto a quella iniziale… è un fatto comunque che, al termine di lunghi secoli di evoluzione, la situazione divenne quella sopra delineata. Ad un piccolo gruppo di proprietari si affiancarono difatti due diverse classi: da una parte quella dei piccoli proprietari (spesso discendenti da antiche famiglie decadute, appartenute in precedenza alle stirpi dominanti) ormai in rovina, e dall'altra quella dei braccianti nullatenenti, ovvero i 'teti' (discendenti forse dalle popolazioni espropriate già ai tempi delle invasioni doriche).
Esiodo illustra bene, nel suo componimento "Le opere e i giorni", quella che dovette essere la triste e dura condizione dei piccoli proprietari terrieri, asserviti ai più ricchi esponenti della nobiltà, e la cui vita era segnata da incubi costanti, quali la fame o la traduzione in schiavitù [1].
E' ovvio come una simile configurazione della vita sociale non potesse non creare dei gravissimi attriti in seno alla società stessa. Anche a essi infatti, si dovette la grande colonizzazione avvenuta tra l'VIII e il VI secolo!
Tali tensioni tuttavia, non si tradussero mai in un movimento organizzato politicamente, rimanendo delle semplici istanze interne alla società, capaci effettivamente di determinare dei fenomeni di grande portata (ad esempio, appunto, i grandi flussi migratori alla base della colonizzazione), ma non di modificare - quantomeno radicalmente - la struttura economica e la distribuzione della proprietà all'interno delle poleis.
Sarà, invece, l'emergere di nuove forze sociali (portatrici non solo di inedite istanze morali, ma anche di forme di produzione e distribuzione della ricchezza differenti rispetto al passato) a rendere possibile un primo mutamento nelle strutture politiche, in un senso essenzialmente timocratico.
Non è necessario sottolineare come questi nuovi ceti sociali fossero essenzialmente legati al commercio, ovvero alle attività mercantili e a quelle artigiane, e avessero entrambi sede prevalentemente non nelle campagne, bensì nelle città. La loro ricchezza quindi non era - come per i latifondisti - peculiarmente agraria ma monetaria, o comunque basata più sulla capacità di fare circolare i beni, che su quella di tesaurizzarli.
Tali ceti, imprimendo all'economia e alla società una svolta differente rispetto al passato, guadagnarono una posizione di autonomia rispetto ai vari potentati dell'aristocrazia terriera che dominavano la vita politica e sociale, riuscendo così effettivamente ad emanciparsi (coinvolgendo poi in un tale processo anche altri strati della popolazione) dal potere invasivo di quest'ultima.
Vi furono inoltre anche altri fattori alla base di questa trasformazione della vita delle poleis, molti dei quali furono legati alle trasformazioni della tecnica militare!
A un individuo contemporaneo, abituato a considerare gli eserciti come delle entità fondamentalmente impersonali e controllate dall'alto, un tale fatto potrebbe sembrare strano o addirittura incomprensibile. Tale affermazione tuttavia appare meno assurda qualora si consideri la natura degli eserciti del mondo antico, e in particolare di quelli delle città-stato greche.
Col tempo infatti, la guerra tra i singoli stati per ragioni soprattutto territoriali (data la forte richiesta di nuove aree su cui insediarsi) divenne sempre più frequente, e le esigenze militari crebbero di conseguenza. Al tempo stesso, alle antiche tecniche belliche basate essenzialmente su combattimenti individuali tra condottieri (di solito nobili - si ricordino a tale proposito le gesta eroiche dei personaggi mitologici) se ne sostituirono altre. In esse il fattore individuale venne superato da quello collettivo, anche perché si era oramai scoperto come un esercito compatto (la falange) [2] pagasse molto di più in battaglia rispetto a uno basato su combattenti sciolti (si ricordino a tale proposito le descrizioni delle battaglie presenti nell'Iliade). Ma questo tipo di formazione militare richiedeva al tempo stesso un massiccio impiego della popolazione libera, né si accontentava più fondamentalmente dell'apporto della nobiltà.
E con l'entrata stabile delle classi dei non nobili nelle fila degli eserciti, si affermarono in favore di queste ultime anche molti diritti politici. Come avrebbe difatti potuto la nobiltà permettere ai cittadini liberi di armarsi, sapendo al tempo stesso di mantenerli in una condizione di subalternità insopportabile? Con ciò essa avrebbe decretato la sua stessa condanna, o in ogni caso la pena a vivere in uno stato costante di latente guerra civile. Fu perciò per essa una necessità imprescindibile concedere ai plebei dei nuovi diritti, che ne parificassero almeno in parte la condizione politica alla propria. La nuova organizzazione militare fu definita 'tattica oplitica', e gli opliti (componenti della fanteria) divennero il pilastro stesso degli eserciti greci.
Bisogna tuttavia anche ricordare come ogni cittadino dovesse pagare il proprio armamento bellico, un fatto che restringeva di molto (dato il costo di quest'ultimo) il numero di coloro che avevano diritto a far parte di questo 'secondo' esercito (il primo era quello costituito dalla cavalleria, formata essenzialmente dalla nobiltà). In tal senso, più che di una rivoluzione democratica, si trattò qui di una rivoluzione timocratica, legata cioè alla ricchezza (ovvero al censo) dei singoli cittadini, anziché alla semplice cittadinanza politica!
In ogni caso, tanto le trasformazioni socio-economiche, quanto quelle militari, contribuirono in modo essenziale all'emancipazione politica delle classi 'plebee' rispetto al precedente dominio aristocratico.
E le riforme politiche del resto, diedero a propria volta un apporto molto positivo sia allo sviluppo che all'affermazione delle classi mercantili, e in generale a quello delle classi cittadine.
(a) Gli sviluppi politici di Atene e dell'Attica
Nel panorama della storia greca l'Attica e la sua capitale, Atene, rivestono - come tutti sanno - un ruolo del tutto essenziale, sia per l'importanza da esse assunta a partire dal periodo classico, sia per la particolarità del loro sviluppo. D'altra parte, tali particolarità (o comunque molte di esse) possono essere ricondotte alla geografia stessa di tale regione, protetta e delimitata naturalmente da una vasta schiera di montagne, quindi costituente da sempre un territorio circoscritto con una popolazione tendenzialmente omogenea.
Tornando indietro nel tempo, ovvero al periodo della dissoluzione degli antichi regni micenei, vediamo ad esempio come gli eventi traumatici che - più o meno direttamente - sconvolsero tutta l'Ellade (oltre alle zone ad essa circostanti), intervenissero in maniera fondamentalmente attenuata in Attica. Quest'ultima difatti non conobbe direttamente le invasioni doriche, e nemmeno - molto probabilmente - quelle ad esse conseguenti, dei popoli cacciati dalle proprie sedi originarie.
Il suo isolamento naturale (rafforzato peraltro dai tratti peculiari della sua popolazione e dalle sue tradizioni politiche) portò l'Attica a rimanere indietro rispetto alle abitudini coloniali della gran parte degli stati circostanti (quali ad esempio Corinto o Megara). Si è già detto, a un tale proposito, come la prima vera colonizzazione ateniese avesse inizio soltanto attorno al settimo secolo, ovvero con un ritardo di circa un secolo rispetto alla maggior parte degli altri stati greci!
E fu anche - o forse principalmente - una simile inclinazione isolazionistica a porsi alla base della trasformazione in senso democratico della città-stato ateniese. L'assenza difatti per lungo tempo di quella 'valvola di sfogo' costituita, per le altre poleis, dalle colonie, finì molto probabilmente per esacerbare quei conflitti sociali interni che un po' ovunque si posero alla base delle rivoluzioni anti-oligarchiche. In Attica quindi, e ad Atene in particolare, queste ultime conobbero forme molto più radicali che altrove, tanto che essa si pose a modello di un po' tutte le altre democrazie greche (così come, del resto, Sparta divenne un riferimento per gli stati oligarchici).
Vedremo più avanti con maggiore esattezza le dinamiche che furono alla base dell'evoluzione di Atene da città-stato oligarchica (sostanzialmente quindi uguale alle altre) a città-stato di carattere timocratico prima, e successivamente pienamente democratica.
(b) Sparta e la conquista della Messenia
Se Atene può essere presa a modello - o come 'tipo ideale' - dell'evoluzione popolare e anti-oligarchica degli stati greci, Sparta al contrario portò avanti una trasformazione di tipo diametralmente opposto: col tempo difatti le sue strutture politiche, anziché emanciparsi dall'antica conformazione gentilizia e di casta, finirono per consolidarne ulteriormente i caratteri. Tale città quindi si sviluppò in un senso inverso rispetto a tutte le altre poleis greche - anche, peraltro, rispetto a quelle che rimasero più attaccate a concezioni di tipo aristocratico (e arcaico)!
Tenteremo ora di indagare le ragioni per le quali tale città conobbe un'evoluzione così anomala rispetto al resto degli stati greci. Senza ovviamente voler togliere nulla al fattore della libera scelta umana, si deve infatti sottolineare l'esistenza di tutta una serie di presupposti che rendono meno inspiegabile e arbitraria anche ai nostri occhi una tale evoluzione. Cercheremo, qui avanti, di delinearli molto sommariamente.
Abbiamo già mostrato in precedenza che Sparta e il Peloponneso meridionale furono il centro dell'invasione dorica, ovvero il luogo in cui queste popolazioni - al termine della loro corsa attraverso le regioni dell'Ellade - decisero di insediarsi stabilmente. La totale estraneità di tali popoli nei confronti dei loro precedenti abitatori (appartenenti tutti al ceppo acheo), li pose con essi in un rapporto profondamente conflittuale. A un tale fattore quindi, si deve ascrivere l'atteggiamento difensivo assunto dai popoli occupanti nei confronti degli Achei, esplicatosi in un arroccamento - tanto morale quanto fisico - in sedi rigidamente distaccate rispetto ad essi.
Alla base della frattura insanabile tra questi due popoli vi fu, insomma, questa profondissima differenza di partenza, molto più marcata rispetto a quella sussistente tra gli altri popoli invasori, provenienti comunque da altre zone della Grecia, e quelli che furono per così dire costretti a 'ospitarli'.
La società dorica, la cui 'filosofia' si inverò soprattutto nel tipo di dominio instaurato dalla città-stato di Sparta, fu quindi una società 'coloniale' e imperialista fin dai propri esordi. Essa si fondò da subito sul dominio militare di una ristretta casta egemone nei confronti di una più vasta popolazione originaria. Col tempo inoltre questa egemonia basata sulla violenza, che sussisteva anche a prezzo di notevoli sacrifici personali tra i componenti della casta dominante, finì - anziché per attenuarsi - per acuirsi. Alla base di un tale fenomeno vi fu forse un processo autonomo di radicalizzazione dei conflitti che una tale situazione generava, che inevitabilmente comportò anche un inasprimento delle misure repressive ai danni delle popolazioni espropriate.
Quanto alla città-stato di Sparta poi, ovvero il più potente stato dorico in Grecia, essa non si limitò alla conquista e all'asservimento della Laconia e dei suoi abitanti (avvenute probabilmente tra XI e X secolo), proseguendo in un secondo momento fino a comprendere la vicina regione occidentale della Messenia (VIII - VII secolo).
Le vicende della guerra (o, per l'esattezza, delle due guerre) tra popoli messenici e spartani, ci raccontano il definitivo consolidarsi della potenza di questi ultimi nel Peloponneso, ma anche i rischi che essi più volte corsero di scomparire, travolti da quegli stessi nemici che successivamente riuscirono a sconfiggere e a sottomettere.
Generati dal bisogno di acquisire dei nuovi territori, in seguito all'aumento della popolazione spartana, entrambi i conflitti furono molto lunghi e conobbero diverse e alterne fasi, pur essendo entrambi alla fine vinti da Sparta.
Il primo conflitto si collocò nell'ultimo quarto dell'VIII secolo, e si concluse con la sottomissione dei popoli messenici. Il secondo ebbe inizio invece dalla rivolta di questi ultimi (oramai ridotti al rango di semplici Iloti, come si mostrerà meglio più avanti) contro il dominio spartano, a metà del VII.
Il secondo conflitto, inoltre, ebbe una portata decisamente maggiore rispetto al primo, riguardando ben più dei due semplici stati contendenti. La Messenia difatti cercò e ottenne l'alleanza in funzione anti-spartana dello stato argivo e di diversi stati arcadici (preoccupati dalla crescita d'estensione della loro rivale, che diveniva col tempo sempre più temibile).
Al termine della guerra quindi, quando Sparta ebbe riportato (pur con grandissime difficoltà, come si è detto) l'ordine nei suoi domini, era oramai divenuto chiaro a tutti come essa fosse la potenza egemone nel Peloponneso, in quanto si era dimostrata lo stato militarmente più potente, oltre che quello tra tutti territorialmente più esteso. Si formò perciò in quegli anni la prima lega tra gli stati greci della madrepatria [3] : la Lega Peloponnesiaca, destinata a una lunga e gloriosa esistenza sia nel periodo classico che in quello post-classico.
Ma la situazione che seguì alle conquiste messeniche, comportò per lo stato spartano notevoli mutamenti anche sul piano dell'assetto sociale.
La consapevolezza infatti di dover sopportare un carico sempre maggiore di nemici interni, costituito ovviamente da una fascia sempre più ampia di popolazioni sottomesse, radicò ancora di più l'esigenza di una capillare attività interna di polizia, volta al mantenimento di un ordine sociale alquanto precario. Il tutto si tradusse quindi in un inasprimento delle norme comunitarie, a svantaggio delle libertà personali dei singoli cittadini. Così, mentre - come già si diceva - tutto il mondo ellenico conosceva un progresso in direzione dell'affermazione della libera iniziativa privata, ovvero a sfavore degli antichi vincoli comunitari che legavano tra loro i componenti della casta egemone, Sparta conosceva al contrario un drastico inasprimento di questi ultimi, conseguenza di un dominio sempre più difficile e instabile sulle varie regioni del proprio territorio.
Per ciò che riguarda le popolazioni sottomesse poi, esse si divisero sin dall'inizio (ovvero sin da prima dell'invasione messenica, dai tempi cioè dell'insediamento degli Spartani in Laconia) in due differenti gruppi: i Perieci da una parte, e gli Iloti dall'altra.
I primi, seppure posti in una condizione socialmente subordinata, costituirono una popolazione a latere rispetto agli spartiati, che godeva di alcuni diritti essenziali - e alla quale erano inoltre delegate attività, quali ad esempio il commercio, che gli spartiati (non solo come classe/casta egemone, ma anche in quanto profondamente chiusi di fronte a possibili influenze e contaminazioni esterne) non volevano né potevano esercitare! - ma che tuttavia non aveva alcuna voce nelle decisioni di natura politica. I peireci molto probabilmente erano i discendenti delle popolazioni che dominarono quelle zone prima dell'arrivo dei Dori. Queste ultime difatti in parte furono sospinte al di là dei loro precedenti territori (soprattutto in Arcadia e in Acaia), in parte continuarono invece a vivere ai margini di essi, laddove le regioni più fertili vennero occupate dai nuovi arrivati.
La condizione più dura fu però quella degli Iloti : una sorta di "classe schiavile di stato", impiegata nella coltivazione dei campi e più in generale nelle attività produttive, totalmente priva di diritti (e non soltanto di quelli politici, ma anche di quelli più elementari). Gran parte delle popolazioni sia della Laconia (regione di più antica conquista), che della Messenia (acquisita definitivamente, come si è appena mostrato, verso la fine dell'VIII secolo) furono tradotte in schiavitù, andando così a comporre i membri di una tale classe, giuridicamente priva d'esistenza autonoma in quanto mero strumento produttivo per la classe egemone degli spartiati.
E' necessario infine dare un breve sguardo alle trasformazioni che, a partire soprattutto dalla seconda guerra messenica, ebbero luogo all'interno dello stato spartano.
Innanzitutto bisogna ricordare come, prima della conquista della Messenia, si stessero formando delle rivalità abbastanza forti tra le due famiglie politicamente più influenti dello Stato spartano (gli Agiadi e gli Euripontidi), un fattore che chiaramente era causa - e al tempo stesso espressione - di una crescente divisione interna. Prodotto di questo aspetto della vita politica e sociale fu forse la scelta istituzionale di carattere diarchico (ovvero la doppia monarchia) posta alla base dell'organizzazione stessa dello stato. Ognuno dei due re infatti (la cui carica peraltro, contrariamente a quella dei sovrani del periodo miceneo, durava soltanto un anno!) era espressione di una delle due famiglie dominanti, e la loro azione combinata tendeva quindi a mantenere tra esse un equilibrio di potere.
Il potere dei sovrani inoltre non era certo assoluto, ma bilanciato da altri istituti: la Gherusia (il Consiglio degli anziani), e l'Apella (l'assemblea dei cittadini liberi, ovvero gli spartiati, convocata solo per le decisioni più importanti).
Anche se le guerre messeniche, molto probabilmente, non modificarono da subito una tale struttura (fu infatti solo nel secolo successivo, il sesto, che gli Efori, i cinque magistrati la cui istituzione risaliva ancora all'VIII secolo, iniziarono ad avere la concreta possibilità di limitare il potere dei sovrani), esse sicuramente influenzarono lo spirito stesso del popolo spartano, rendendolo più chiuso e diffidente nei confronti degli altri stati (i quali, come vedremo più avanti, stavano conoscendo già da tempo un'evoluzione di segno opposto rispetto alla sua) e rafforzando contemporaneamente lo spirito di coesione interna, ovvero il senso della parità sociale e politica tra i cittadini liberi, a tutto svantaggio degli antagonismi politici tra le grandi famiglie.
Un altro elemento poi, che modificò profondamente la vita politica e sociale della polis spartana, fu l'introduzione (avvenuta verosimilmente proprio in concomitanza con la seconda guerra messenica) della tattica oplitica, la quale - come si visto - richiedendo un forte senso di solidarietà reciproca tra i cittadini-soldati, favorì (e anzi impose) il processo di parificazione sociale tra essi, a scapito di nuovo delle interne rivalità particolaristiche.
Un ultimo fattore che caratterizzò da sempre - ma ancor più profondamente a partire da questo periodo - la cultura spartana, fu il tipo di educazione impartita alla sua gioventù (Agoghè), la cui esistenza era improntata a un'esistenza dura, spietata e militaresca.
Elementi essenziali di essa furono: il distacco forzato dalla famiglia dall'età di tredici anni, l'inizio cioè di un'esistenza puramente comunitaria; la ginnastica come mezzo per temprare tanto il corpo quanto lo spirito; e delle condizioni di vita alquanto precarie, che obbligavano i giovani spartani a rubare per sostentarsi, a rischio di subire però terribili punizioni fisiche e morali.
Fu la guerra messenica quindi, l'evento che molto probabilmente costrinse la città di Sparta a trasformarsi definitivamente in quella roccaforte impenetrabile (spesso inoltre mitizzata dai suoi stessi nemici, elemento non secondario della sua forza) che tutti ancor oggi conosciamo, episodio più unico che raro nell'intera storia mondiale.
- Evoluzione interna degli altri stati greci
Per ciò che concerne invece gli altri stati greci, abbiamo già detto che la loro evoluzione fu molto più vicina a quella della città di Atene che non a quella di Sparta. Ma peculiarità dell'Attica fu anche qui - come per quanto concerne la crescita coloniale - un notevole ritardo rispetto alla maggior parte delle altre regioni. Così, ad esempio, mentre Corinto conobbe per la prima volta l'esperienza politica della tirannide ancora nel VII secolo, Atene la conobbe invece soltanto a partire più o meno dalla metà del VI, sotto la guida illuminata di Pisistrato.
Per ciò che riguarda quest'ultima forma di governo, bisogna notare che essa fu espressione in gran parte della volontà dei nuovi ceti commerciali e "borghesi" (nel senso di non peculiarmente legati alle ricchezze fondiarie) di affermarsi anche su un piano politico e civile. I tiranni difatti, se da una parte furono quasi sempre degli esponenti della nobiltà, dall'altra furono anche espressione della necessità di mediare tra gli interessi di quest'ultima e quelli dei ceti emergenti, cittadini e commerciali. In questo senso la tirannide greca non ebbe (quantomeno da subito) quei connotati negativi che assunse in seguito, e che ancora oggi conserva.
In ogni caso la cultura politica delle altre poleis fu molto spesso influenzata dall'esperienza della democrazia ateniese, pur non essendo mai giunta in esse a soluzioni altrettanto radicali, ed essendosi quindi mantenuta su un piano di maggiore moderazione. Del resto, anche laddove si formarono stati di stampo oligarchico, essi conservarono sempre rispetto al passato un carattere decisamente attenuato: era oramai inconcepibile infatti, visti gli sviluppi sociali di un po' tutto il mondo greco, un dominio a senso unico della nobiltà terriera.
Le eccezioni più considerevoli rispetto a una tale situazione si trovarono in Arcadia (ovvero nelle zone più interne del Peloponneso) e in Tessaglia (nella zona nord-orientale della Grecia).
Qui difatti, gli sviluppi economici e sociali oramai avanzati nelle altre regioni, non ebbero altrettanta facilità a penetrare. Anche sul piano politico, dunque, rimasero in vigore in massima parte le tradizioni gentilizie più arcaiche e le forme di insediamento ad esse corrispondenti, più tribali che cittadine.
[1] Ma quello dei dislivelli di proprietà non fu, nel mondo occidentale, un problema esclusivamente greco. Anche a Roma, ad esempio, la questione delle terre - detta 'questione agraria' - fu sempre estremamente sentita.
D'altra parte, il processo di graduale accentramento fondiario non venne mai realmente interrotto dai provvedimenti politici, ma al massimo rallentato. Ne è prova il fatto che la fine del mondo antico fosse segnata dalla realtà del feudalesimo - ovvero di una società divisa territorialmente tra le proprietà dei grandi possidenti. (torna su)
[2] Ma quello dei dislivelli di proprietà non fu, nel mondo occidentale, un problema esclusivamente greco. Anche a Roma, ad esempio, la questione delle terre - detta 'questione agraria' - fu sempre estremamente sentita.
D'altra parte, il processo di graduale accentramento fondiario non venne mai realmente interrotto dai provvedimenti politici, ma al massimo rallentato. Ne è prova il fatto che la fine del mondo antico fosse segnata dalla realtà del feudalesimo - ovvero di una società divisa territorialmente tra le proprietà dei grandi possidenti. (torna su)
[3]
Le prime leghe tra le città greche non furono quelle della madrepatria,
bensì quelle delle colonie asiatiche. Per l'esattezza la prima
lega fu quella, fondata nel VII secolo, tra le poleis ioniche, e le cui
basi furono innanzitutto religiose.
Anche qui, come in molti altri campi, le colonie ebbero il merito di costituire
il 'volano' dell'evoluzione dei popoli ellenici. Solo con i secoli, quando
lo sviluppo economico e politico principale si spostò nuovamente
verso la madrepatria, quest'ultima si riappropriò del proprio ruolo
'egemone'. (torna su)