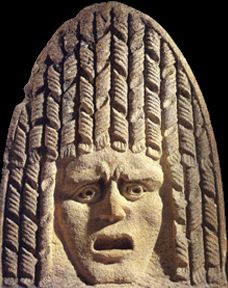LA GRECIA TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Storia ed evoluzione della Grecia classica
2- La trasformazione della Grecia e delle vicine coste egee tra XII e IX secolo: nascita di nuovi regni e prima colonizzazione greca
|
Dopo avere delineato la situazione complessiva che fece seguito alle grandi migrazioni del XIII/XII secolo, affronteremo qui di seguito un tale evento in relazione alla Grecia continentale e insulare e alle regioni costiere dell'Asia anteriore (oggetto, a loro volta, di invasione e di colonizzazione da parte dei Greci). Come già abbiamo fatto per il mondo mediterraneo, ci soffermeremo prima sui fatti, cioè sia sulle migrazioni indoeuropee che su quelle a esse connesse (in quanto determinate dalle prime, e con le quali inoltre spesso si fusero), e successivamente ci occuperemo delle trasformazioni di ordine sociale e politico cui tali sconvolgimenti diedero luogo, non solo sul continente europeo. |
|
- Movimenti di popoli in Grecia e dalla Grecia
Gli eventi che sconvolsero la Grecia nel XIII secolo (e al termine dei quali sorsero delle nuove società) passarono alla storia come "invasioni doriche", dal nome di alcuni popoli situati a nord della Grecia (nella regione del Pindo) che, a quanto pare, ebbero in essi un ruolo primario.
Ma, come già si è detto, tale flusso migratorio non fu prima di tutto dorico, bensì indoeuropeo e illirico. Questi popoli infatti, nella loro discesa verso le regioni meridionali, dotati tra l'altro di micidiali armi in ferro (ancora totalmente sconosciute ai popoli egei), finirono per smuovere dalle loro sedi alcune popolazioni della Grecia settentrionale (i Dori e i Tessali, appunto) rafforzando così l'effetto delle proprie incursioni.
Come gli Illiri avevano scacciato molti Tessali dalla Tessaglia e molti Dori dal loro territorio originario, il Pindo, così le popolazioni miste che invasero le regioni della Grecia centro-meridionale indussero molto probabilmente gran parte dei loro abitanti a fuggire, con le seguenti conseguenze: a) le etnie Eoliche (situate nella zona a Nord) fondarono sulle coste anatoliche settentrionali (antistanti alle loro regioni originarie) delle proprie colonie; b) le etnie Ioniche (per la verità le meno toccate dalle invasioni doriche) fondarono invece le colonie ioniche; c) gli Achei infine, situati nelle regioni più a sud della Grecia, cioè l'Argolide e il Peloponneso, dopo essere rifluite a nord (Ionia, Etolia, Beozia, ecc.), presero molto probabilmente parte alle migrazioni ioniche.
Anche i Dori non si fermarono, dopo l'acquisizione delle regioni meridionali della Grecia, cioè l'Argolide e il Peloponneso, e passarono a conquistare sia le isole meridionali (compresa Creta, che divenne una delle sedi della civiltà dorica nel mar Egeo) sia le coste meridionali dell'Anatolia occidentale.
Al termine di questo flusso migratorio troviamo dunque la Grecia centro-meridionale divisa tra tre distinte zone: a) quella eolica (la più a nord), b) quella ionica (nella parte centrale: Eubea, Attica, Cicladi), c) quella dorica (all'estremo sud).
A esse corrispondevano poi, a grandi linee, tre diverse zone coloniali sulle coste asiatiche immediatamente antistanti: a) le colonie eoliche (nord), b) quelle ioniche (centro), c) quelle doriche (sud).
Era così oramai delineata quella che sarebbe stata la conformazione etnica e politica del mondo ellenico, fino peraltro al periodo classico!
- Trasformazioni sociali e istituzionali nel mondo ellenico
Come si è già detto, le incursioni del XIII secolo ebbero pesanti conseguenze non solo sulla distribuzione delle diverse etnie sul suolo ellenico, ma anche sullo stile di governo delle regioni da esse interessate. Queste nuove forme di governo poi (tutte emerse - più o meno direttamente - da tali eventi) portarono con sé dei fenomeni nuovi, quali ad esempio la proprietà privata del suolo, i primi governi su base aristocratica o oligarchica, i primissimi fondamenti delle future poleis d'età classica… oltre a tutta una serie di trasformazioni che anticipavano molti aspetti dei regimi politici dei secoli successivi.
Analizzeremo qui avanti i seguenti punti: a) il passaggio dalle società monarchiche (di Palazzo) a quelle aristocratiche, b) il ruolo delle colonie negli sviluppi della civiltà greca, c) le sopravvivenze della civiltà achea e micenea nelle regioni egee, d) il discorso sullo sviluppo della proprietà privata nelle sue due opposte forme: quella più propriamente personale e quella invece collettiva o 'di casta'.
(a) le società oligarchiche
Abbiamo già visto come le società di Palazzo fossero il risultato di invasioni prevalentemente non violente: non a caso esse riflettevano, nelle proprie strutture, le condizioni pacifiche e il processo storico graduale dal quale erano sorte. Erano delle società difatti fondamentalmente piramidali, in cui le decisioni più importanti dipendevano dall'autorità del sovrano (wanax), vertice di un'organizzazione sociale fondata sulla cooperazione tra le diverse classi o, se si vuole, caste che le componevano.
Le società sorte dall'invasione dorica (e in generale dal processo di riassestamento delle popolazioni greche) riflettevano invece ben altra condizione di partenza: quella dell'espropriazione violenta delle terre da parte di una popolazione conquistatrice, ai danni dei suoi precedenti abitatori. A partire da questa considerazione, si può facilmente capire quale profonda diversità dovesse sussistere tra la civiltà Micenea e quella "feudale" successiva.
Mentre, da una parte, nel mondo miceneo la proprietà era interamente del sovrano, ovvero vigeva (implicitamente) una forma di proprietà di tipo collettivo, in quelle post-micenee essa diveniva prerogativa esclusiva di una componente minoritaria della popolazione, ovvero quella dei conquistatori, cui si contrapponeva una 'plebe' asservita ed espropriata. Da una struttura piramidale si passò così ad un'altra di tipo essenzialmente orizzontale, fondata su due condizioni sociali parallele: quella dei vinti e quella dei vincitori.
Dall'altra parte poi, - fatto non meno importante - mentre nel mondo miceneo era fondamentale la figura del sovrano, che (come si è detto) costituiva il vertice stesso della piramide sociale, in quelle 'doriche' era il gruppo dominante ad assolvere un ruolo egemone. Non più quindi un singolo individuo e una singola autorità, bensì piuttosto un gruppo di individui posti su un piano di fondamentale parità (dovuto all'appartenenza a una medesima etnia e, spesso, a una stessa famiglia o stirpe d'origine, il ghenos). Quella dell'età buia insomma, fu una società di tipo oligarchico, basata cioè sul "governo di pochi", anziché, come quella precedente, una società monarchica e verticistica.
Ma l'esistenza effettiva del sovrano e del Palazzo divenne impossibile - a ben osservare la situazione - anche per un'altra ragione: il ruolo del Palazzo era stato in passato quello di servire da collettore delle eccedenze alimentari (come in tutte le società di tipo asiatico, del resto), o come punto di irraggiamento dei commerci (da una parte alimentati dalle esigenze della corte, e dall'altra pianificati da quest'ultima in vista di esigenze di carattere comunitario), o si era comunque basato su aspetti della vita sociale oramai virtualmente inesistenti. Appare insomma chiaro che, in un contesto fortemente impoverito come quello che fece seguito alle invasioni doriche, le esigenze connesse alla funzione regale diminuissero drasticamente, e con esse quindi il ruolo dell'autorità del wanax e quella del Palazzo.
Non che con questo si voglia dire che, da un momento all'altro, l'istituzione monarchica scomparisse, bensì piuttosto che essa - pur sopravvivendo per un certo periodo, come vestigio del tempo passato, o come espressione di una gerarchia interna ai popoli invasori vigente ancora ai tempi delle guerre di conquista - tese gradualmente ad atrofizzarsi, per la perdita di un ruolo e di un significato reali. Già prima del X secolo, difatti, (se si eccettuano alcuni sporadici esempi nelle zone interne e altri in quelle regioni periferiche, come la Macedonia e l'Epiro) non vi fu più traccia - o quasi - dell'istituto monarchico nel mondo greco.
Le differenze essenziali tra il mondo miceneo e il mondo 'dorico' (sorto appunto dagli stravolgimenti dovuti alle incursioni violente dei popoli dorici a partire dal XIII sec.) furono quindi: a) la mancanza nel secondo di un centro di potere forte, dal quale dipendessero le realtà locali; e b) la conquista del potere politico da parte di una classe aristocratica (di stampo militare) che si contrappose alla massa della popolazione originaria, da essa espropriata dei propri diritti e delle proprie terre.
Altre implicazioni di questo discorso verranno analizzate più avanti. Qui avanti ci occuperemo invece del ruolo delle colonie asiatiche nell'economia degli stati greci.
(b) Il ruolo svolto dalle colonie nella storia greca arcaica
Nelle trasformazioni del mondo ellenico dopo il XII secolo, un ruolo molto particolare ebbero le colonie asiatiche, e ciò peraltro fino al periodo successivo, quello arcaico.
Esse infatti svolsero due funzioni essenziali per la civiltà greca: a) da una parte svilupparono una prima coscienza 'nazionale', il primo senso di un'appartenenza culturale comune (un sentimento che contagiò successivamente anche i Greci europei); b) dall'altra assolsero ad una preziosa funzione di assimilazione di motivi e influssi provenienti dalle civiltà asiatiche (anatoliche, fenicie, mesopotamiche ed egizie), come sempre all'avanguardia da un punto di vista tecnico-scientifico e ricche quindi di preziosi stimoli culturali.
Per tali ragioni, furono proprio le colonie asiatiche a porre molte delle basi della futura cultura greca. Né fu un caso difatti, che alcuni dei più grandi esponenti di essa - uno tra tutti, Omero - provenissero in questi primi secoli proprio da tali regioni.
Un aspetto che da subito iniziò a emergere nelle zone greco-asiatiche - soprattutto in quelle ioniche - fu la 'nostalgia' per la madrepatria, per i suoi costumi e per la sua lingua originaria, e ciò non solo in ragione della distanza da essa, ma anche a causa di un contesto culturale - quello dei popoli asserviti - decisamente differente e spesso ostile a quello greco. Le colonie, anche per tale ragione, si mantennero dunque molto legate (almeno idealmente) alle proprie terre d'origine: un fattore alimentato anche dall'ostilità delle etnie sottomesse, con cui molto probabilmente spesso non fu possibile istituire rapporti sereni e pacifici.
Fu insomma a partire dalla distanza dai propri usi e costumi originari, che i coloni svilupparono la stessa consapevolezza di essere dei "greci" - consapevolezza che successivamente trasmisero anche alle regioni di provenienza.
Il secondo aspetto non fu forse così immediato. Inizialmente difatti anche l'Oriente (pur così antico e così ricco di suggestioni) non ebbe molto da offrire alla cultura greca. La recente migrazione aveva difatti fortemente destabilizzato anche tali aree e provocato una loro temporanea regressione.
Solo nei secoli successivi, con lo svilupparsi di un nuovo assetto politico stabile, esse poterono costituire di nuovo una fucina di idee e di stimoli per l'occidente.
In Anatolia, per esempio, si affermarono prima il regno dei Frigi (nella zona orientale) e poi quello dei Lidi (in quella più occidentale); nell'entroterra asiatico invece l'Impero assiro la fece da padrone un po’ ovunque (Egitto compreso, anche se per un breve periodo) dal IX fino all'VIII/VII secolo.
Fu soprattutto dai Lidi però che le colonie greche, nel periodo finale del cosiddetto 'Medioevo ellenico', ricevettero i maggiori stimoli. Da tali popoli infatti esse raccolsero due invenzioni fenomenali, che posero le basi dei futuri sviluppi non solo della Grecia, ma anche dell'intera umanità: a) la moneta (intesa in senso moderno), e b) la scrittura alfabetica (più veloce e comoda di quella geroglifica, più facile quindi da utilizzare).
Ma anche in campo letterario le colonie diedero un apporto fondamentale, con la stesura tra il X e il IX secolo dei due celebri poemi omerici (ad opera di una figura "semi-storica", il poeta Omero), nei quali veniva rievocata l'antica civiltà micenea, oramai appartenente ad un passato mitizzato, che assumeva quindi un forte valore simbolico. Tali opere difatti assommavano in se stesse sia gli ideali eroici dell'aristocrazia conquistatrice greco-asiatica, sia il rimpianto di essa per la propria patria e per le proprie gloriose origini.
Va però ricordato di nuovo, che gli apporti più rilevanti provenienti sia dalle colonie orientali che dalle vicine civiltà asiatiche, si collocarono quasi tutti sul finire dell'epoca buia, quando cioè la situazione cominciava a stabilizzarsi, permettendo così alle energie intellettuali e creative fino ad allora rimaste compresse e inutilizzate di potersi nuovamente esprimere.
(c) Sopravvivenze delle civiltà micenee
La scomparsa, in seguito alle incursioni indoeuropee del XIII secolo, delle civiltà di Palazzo micenee, non significò però quella della cultura achea. Le popolazioni achee, infatti, continuarono a esistere e - sebbene con forti limitazioni - a portare avanti le proprie antiche tradizioni (artistiche, religiose, ecc.)
Nel complesso tuttavia, all'epoca delle società piramidali e 'cooperative' fece seguito quella delle nuove società, fondate sull'espropriazione (un discorso che - come si è già detto - non vale solo per i Dori, ma anche per quei popoli greci che, cacciati dai primi dalle proprie sedi originarie, molto spesso si trovarono costretti a porre in atto un analogo meccanismo di espropriazione ai danni di altre popolazioni.)
La pratica della violenza ai fini del dominio su territori contesi tra diverse etnie divenne insomma un fatto molto comune, mentre si infransero quell'unità e quell'armonia linguistico-culturali (anche se non politiche) che, nei secoli micenei, erano sorte tra le diverse zone dell'Ellade.
Ma in che modo e in che misura gli Achei, o meglio le popolazioni eoliche e quelle ioniche, espressione di civiltà oramai antiche, poterono perpetuare le proprie tradizioni e la propria identità culturale, in un mondo tanto fortemente trasformato?
Sul territorio greco il clima politico era oramai profondamente mutato, e ciò anche in quelle zone (come l'Attica e l'Eubea) nelle quali le incursioni doriche non erano giunte direttamente. Ma nelle isolette minori dell'Egeo, poste al di fuori del grande flusso storico, gli Achei poterono conservare ancora a lungo sia la propria cultura che la propria organizzazione sociale (ne fanno fede ad esempio, le tombe a tumulo che sono state ritrovate in alcune di esse). Un discorso abbastanza simile vale poi per le colonie ioniche e eoliche, laddove però i Greci dovettero anche combattere e difendersi dall'ostilità degli indigeni (con conseguenze ad esempio sul tipo di governo, che fu qui - come del resto in Grecia - di tipo aristocratico e militare).
Un discorso a sé merita infine l'isola di Cipro, e non solo in relazione ai greci. In essa difatti, i popoli del Mare non arrivarono, ragion per cui Cipro si conservò intatta dalle trasformazioni che tali incursioni portarono laddove giunsero.
In tale isola si sviluppò una sorta di civiltà mista, acheo-fenicia (essa difatti è posta immediatamente davanti alla Siria), nella quale molto probabilmente un gran numero di caratteri delle civiltà precedenti poterono conservarsi con singolare vigoria.
In ogni caso, complessivamente, il mondo egeo subì - sia sul piano culturale, che su quello politico - una profonda trasformazione, che annullò molte delle precedenti scoperte (anche tecniche, come ad esempio la scrittura lineare d'origine cretese) del periodo precedente. Il mondo greco passò quindi attraverso le forche caudine di una sorta di Medioevo, per risvegliarsi però al suo termine - come del resto accade di solito per tutti i 'Medioevi' - più maturo e più ricco di prima !
(d) I due sviluppi della proprietà aristocratica
Come si è detto, la base storica dei nuovi stati fu l'atto stesso con cui gli invasori espropriarono delle loro terre le popolazioni indigene (o che comunque in essi risiedevano da più lungo tempo). Per tale ragione, la società si divise tra una casta dominante e una subordinata (composta in prevalenza dagli antichi residenti).
A partire da un tale atto di espropriazione, si comprende in che modo insorgesse l'uso della proprietà privata (nel senso escludente ed 'esclusivo' del termine) delle terre ad opera di una fascia della popolazione, più o meno ristretta, e ai danni di un'altra. Si formò difatti una classe/casta dominante - dove il termine classe sta a indicare un gruppo di individui proprietari, inizialmente a titolo rigorosamente collettivo, delle terre su cui risiedevano (senza, quindi, alcuna funzione delegata rispetto a un'autorità superiore: quella del re), mentre il termine casta indica un gruppo chiuso di individui proprietari per famiglia e per nascita, e non per meriti o per fortuna, di certi privilegi sociali (primo dei quali, appunto, quello di essere proprietaria delle terre) - contrapposta a un'altra che si trovava invece in una condizione minoritaria.
E' poi chiaro come, mancando un'autorità di riferimento - o essendo quest'ultima comunque estremamente debole - gli esponenti della classe nobiliare fossero indotti a fare anche un ultimo passo : quello cioè di appropriarsi a titolo personale dei territori sui quali già risiedevano, seppure in qualità di gestori per conto della loro stessa comunità clanica (ghenos).
Da una proprietà di carattere collettivo, dunque, essa diveniva lentamente una proprietà integralmente privata! O, se si preferisce, da una forma di proprietà di carattere comunitario e collegiale (di casta), si passava a un'altra completamente privata, in quanto prettamente personale e individuale.
Tuttavia, è da notare come quest'ultima trasformazione, sebbene costituisse la norma, non fu in ogni caso del tutto priva di eccezioni.
L'esempio più eclatante è quello costituito da Sparta, una polis di carattere spiccatamente militare nella quale, tra gli individui componenti la casta dei dominatori, non esisteva alcuna dimensione privata, nemmeno - come noto - quella familiare. In un tale stato, la dimensione di casta fu conservata con un rigore che spesso suscitò tra i contemporanei una profonda ammirazione e che oggi, a un osservatore moderno, provoca invece di solito una sorta di raccapriccio.
Ma Sparta è esemplare ai nostri occhi anche per un'altra ragione, per comprendere cioè le motivazioni alla base di un tale tipo di organizzazione politica. Posta difatti a capo di un vero e proprio impero territoriale - il quale col tempo finì per estendersi anche alle zone circostanti: cioè la Laconia e la Messenia - essa avvertì più profondamente di altre aree il bisogno di mantenere una forte compattezza e coesione tra i propri cittadini (gli Spartiati) contro le popolazioni sottomesse (Iloti e Perieci).
Dalla sua vicenda dunque, si rende chiaro come mai furono soprattutto le stirpi doriche a propendere per una tale soluzione, rigidamente aristocratica e militare, anziché per una di tipo (maggiormente) democratico
Infiltratesi infatti sui propri territori come dominatrici assolute, attraverso una rivoluzione estremamente violenta, esse da subito furono incapaci di amalgamarsi alle precedenti popolazioni (da esse asservite). Tale fattore diede vita poi, col tempo, ad un meccanismo di tipo difensivo che finì per autoalimentarsi, creando così una spirale di odio e di violenza che - anziché attenuarla - rafforzò sempre di più tale ostilità. Questo certamente indusse i popoli egemoni a rimanere tali, anziché - come invece accadde nella maggior parte delle altre regioni, nelle quali lo iato tra invasori e invasi era molto meno radicale - a mitigare la distanza che li separava dai vinti.
Se è dunque vero che la Grecia ci offre un vasto ventaglio di esempi (anche se certo non gli unici) di stati di tipo occidentale e privatistico, è vero anche che un tale discorso vi si sviluppò secondo modalità o 'gradi' estremamente differenti : Atene, la città-stato democratica per eccellenza (sorta però, si badi bene, ben oltre il periodo qui descritto!) fu difatti molto differente rispetto a quella aristocratica e militare per antonomasia, cioè Sparta.
Preciseremo meglio più avanti il modo e i percorsi attraverso cui tali destini si separarono.