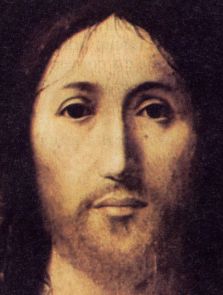
Antonello da Messina, Il Salvatore del mondo, National Gallery di Londra
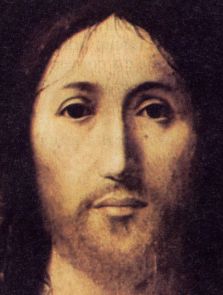
Antonello da Messina, Il Salvatore del mondo, National Gallery di Londra
Libro primo
I Vangeli e il loro retroterra storico-culturale
6. ULTERIORI AMPLIFICAZIONI DELLA FIGURA DI GESù
La moltiplicazione evangelica dei miracoli
Fu Matteo a dare inizio all'amplificazione, essendo per lui troppo riduttive le notizie fornite da Marco: non appena Gesù compare in pubblico, intorno a lui si affollano gli ammalati di tutta la Galilea, non solo, ma anche quelli provenienti dalla Siria. E se Marco ci fa sapere che a Cafarnao Gesù "guarì molti", ecco che per Matteo "guarì tutti" 1. Il che si ripete un'altra volta 2.
Con la tradizione i miracoli vanno via via moltiplicandosi; così è significativo che quando l'edizione accresciuta di Marco 3 parla di due guarigioni, Marco ne cita solo una; nel Vangelo di Marco Gesù, uscendo da Gerico, risana un cieco, Matteo dice che ne sanò due 4. (Anche Luca parla qui di una sola guarigione) (Lc. 18, 35 sgg.). In Marco Gesù guarisce un ossesso, cacciandone lo spirito maligno nel branco dei maiali 5, in Matteo gli ossessi guariti diventano due. Luca cita anche qui una sola guarigione (Lc. 8,26 sgg.).
Ma anche Luca, per la verità, riferendo di altri miracoli, si comporta come Matteo 6: mentre Marco e Matteo sono a conoscenza di una sola resurrezione, quella della figlia di Giairo (Mc. 5, 21 sgg.; Mt. 9, 18 sgg.), Luca arricchisce il Libro dei Libri con quella del fanciullo di Nain (Lc. 7, 11 sgg.). Suscita perlomeno una certa perplessità il fatto che Marco e Matteo passino semplicemente sotto silenzio questa seconda resurrezione, mentre menzionano tanti altri piccoli portenti.
A proposito della moltiplicazione dei pani, Marco parla di "circa" quattromila persone, Matteo accresce il miracolo trasformandole in "circa quattromila uomini", e soggiungendo: "Senza contare le donne e i bambini": la folla, dunque, a sentir lui, sarebbe stata circa il doppio 7. La medesima esagerazione rispetto a Marco troviamo in Matteo nella "moltiplicazione dei pani di fronte ai cinquemila" 8 per altro un doppione abbastanza evidente.
Nel Vangelo di Marco, dopo il racconto della morte di Gesù, si dice semplicemente: "Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso" (Mc. 15, 38), ma Matteo ne sa molto di più, aggiungendo alla notizia di Marco:
" ... la terra si scosse e le rocce si spezzarono, i sepolcri si spalancarono, e molti corpi di santi morti risuscitarono, e dopo la sua resurrezione uscirono dai sepolcri, entrarono nella città santa e apparvero a molti" (Mt. 27,51).
Di tutto questo Marco non sa nulla, né mostrano di averne avuto notizia gli storici, ai quali quest'evento sensazionale non sarebbe certo sfuggito 9.
Qualche volta Matteo incrementa i miracoli di Marco anche col più rapido compiersi d'un evento: ne è un chiaro esempio la maledizione dell'albero di fico; in Marco la pianta si secca il giorno dopo, in Matteo "immediatamente". In Marco, Pietro si ricorda dell'accaduto solo il giorno seguente, passando vicino all'albero, in Matteo, i discepoli discutono dell'immediatezza del portento subito dopo la maledizione. Per altro, in Marco la maledizione si verifica prima della purificazione del tempio, in Matteo il giorno dopo 10. Infine, se Marco non racconta alcun miracolo, Matteo ne inserisce qualcuno nel testo assunto da Marco 11.
è vero che una volta Matteo e Luca ignorano due miracoli narrati di Marco, ma con ciò essi non fanno altro che manifestare la solita tendenza idealizzante. Tali miracoli, per l'esattezza la guarigione del sordomuto e del cieco a Betsaida (Mc. 7, 31 sgg. e 8, 22 sgg.), vengono operati da Gesù ponendo la propria saliva sulla lingua del muto e sugli occhi del cieco, e poi con l'imposizione delle mani. Ma tali metodi non sembrano coerenti con l'idea dell'efficacia immediata delle sue parole; inoltre, si tratta di procedure allora spesso usate e a tutti ben note, tanto che discreditarono Gesù agli occhi degli Evangelisti più recenti, i quali, passando sotto silenzio queste azioni, vollero eliminarlo dal novero dei comuni ciarlatani dell'epoca. Anche i Rabbini, in seguito, riprovarono simili procedimenti 12. Per le medesime ragioni, il quarto Evangelista omette del tutto il racconto delle quotidiane guarigioni degli ossessi ingigantendo, per contro, altri miracoli.
L'assenza di queste esorcizzazioni di demoni nel Vangelo di Giovanni appare tanto più singolare se si pensa che il figlio di Zebedeo, il Giovanni autentico, aveva attribuito una grande importanza proprio agli esorcismi di Gesù: se fosse stato lui l'autore del Vangelo, di certo avrebbe loro concesso uno spazio privilegiato. E invece li passa sotto silenzio 13. Egli cita solo tre dei maggiori miracoli raccontati dai Sinottici, per altro esagerandoli 14 e ne aggiunge altri quattro, davvero grandi, per nulla menzionati dai predecessori.
Per ora esaminiamo la trasformazione dell'acqua in vino durante le Nozze di Cana (Jh. 2, 1 sgg.). è il miracolo inaugurale, un "miracolo di lusso" per altro, che, come scrive poeticamente lo scrittore cattolico Daniel-Rops (Jesus, 228), possiede il profumo sapido dei fatti di natura. In quell'occasione, il Gesù giovanneo crea da sei a settecento litri di vino, come risulta inequivocabilmente da Jh. 2, 6 sg. 15, benché pii esegeti talvolta vogliano ridurre questa rispettabile quantità, rimpicciolendo del tutto inutilmente la portata del miracolo.
Segue subito il miracolo sulle rive del lago di Betesda, la guarigione dell'uomo infermo da 38 anni, che a dimostrazione della sua ritrovata salute si carica in spalla il lettuccio e se ne va (Jh. 5, 1 sgg.), (esattamente come in una storia pagana, narrata 300 anni prima da un'iscrizione di Epidauro, nella quale Mida, morso da un serpente, dopo la guarigione prende su il lettuccio e se ne va con le proprie gambe: cfr. Lucian., Philops., 11). Poi, l'Evangelista ci offre la guarigione del cieco dalla nascita (Jh. 9, 1 sgg.). E infine, a coronamento del tutto, la resurrezione di Lazzaro, già in via di putrefazione: "egli ormai puzza" (Jh. 11, 1 sgg.). è davvero assai sconcertante che tutti e tre gli Evangelisti precedenti omettano completamente questo miracolo particolarmente grandioso, operato per giunta davanti agli occhi di tutti.
E anche qui dobbiamo sottolineare il processo di ingrandimento delle resurrezioni evangeliche: in Marco, Gesù salva la figlia di Giairo, appena defunta o sul punto di morire. Infatti, Gesù dice: "La fanciulla non è morta, dorme soltanto" (Mc. 5, 39); Luca, che scrive dopo, narra il risveglio del giovinetto di Nain, di cui nulla sanno gli altri Evangelisti, che è morto già da tempo, tanto che Gesù lo incontra durante il seppellimento (Lc. 7, 11 sgg.). E adesso il quarto Evangelista ci parla di questo Lazzaro (della cui miracolosa salvazione tacciono tutti gli altri Vangeli), che giace già da quattro giorni nella tomba e ormai puzza 16.
Il Vangelo di Giovanni esibisce miracoli grandiosi; tutto si compie in grande stile, rinunciando a vari dei portenti dei Sinottici, che allora accadevano piuttosto spesso: ma qui i miracoli sono descritti "affinché crediate" (Jh. 20, 30 sg.).
La prosecuzione dell'esagerazione dei miracoli neotestamentari nei cosiddetti Apocrifi
I numerosi Vangeli "apocrifi", gli Atti degli Apostoli, le Epistole e le Apocalissi mostrano in maniera ancor più evidente il modo in cui la figura di Gesù venne fascinosamente trasfigurata dalla fantasia dei cristiani. è certamente vero che nel IV secolo, accingendosi alla definizione del canone del N.T., la Chiesa li ha espunti, dichiarandoli costruzioni leggendarie seriori (ma anche i Vangeli "autentici" lo erano in misura notevolissima!). Significativamente le esagerazioni "apocrife" riguardano non il periodo dell'attività pubblica di Gesù descritta nella Bibbia, considerata, a quanto pare, abbastanza convincente, ma esclusivamente l'epoca precedente il suo battesimo (Hennecke, 76).
In un primo tempo, comunque, gli "Apocrifi" (dal gr. apokrypto = celo, nascondo) non erano affatto considerati tali: l'opera missionaria ebbe luogo con tutti gli scritti sacri, soprattutto nella Chiesa orientale, ma anche in quella occidentale. I Padri della Chiesa più famosi si fecero garanti di quei testi poi condannati 17. La maggior parte degli antichi teologi li ritennero di derivazione apostolica e quindi assolutamente veri, e alcuni furono talvolta preferiti ai libri neotestamentari. Inoltre, numerosi scritti cristiani sono più antichi del N.T., per non parlare del fatto che talune parti degli Apocrifi vennero interpolate negli antichi Codici neotestamentari, specie nel manoscritto D.
Infine, la Chiesa stessa, con l'arbitrarietà che le è propria, riconobbe libri apocrifi, soprattutto del V.T., accogliendo non il Vecchio Testamento ebraico dei giudei di Palestina, ma la redazione usata dalla cristianità antica, cioè la traduzione greca dei Settanta e la Vulgata, la traduzione latina di Gerolamo. Questi libri, tuttavia, erano stati ampliati, rispetto al Canone ebraico originale, con l'inserimento di un gran numero di Apocrifi (Terzo Esra, Judith, Jesus Sirach, Sapienza, Salomone, il Libro dei Maccabei ecc.) e dal Concilio di Trento del 1546 vennero ufficialmente riconosciuti come canonici la maggior parte di questi Apocrifi, per altro mai citati da Gesù, che pure menziona spesso il V.T.: fu definitivamente riconosciuto il testo della traduzione greca del V.T., benché spesso non corrisponda affatto all'originale ebraico.
Secondo la leggenda, 72 traduttori ebrei, ciascuno per proprio conto, produssero la stessa traduzione, parola per parola, e questo miracolo fu accreditato senza remore da tutti i Padri della chiesa, compreso Agostino 18.
La Chiesa evangelica, in ogni caso, si differenzia da quella cattolica, accogliendo il V.T. secondo il Canone ebraico e tollerando nelle proprie Bibbie solo una parte degli Apocrifi.
Per un'analisi storico-critica del Cristianesimo è ovvio che siano prese in esame tutte le fonti, e non solo quelle che si sono più o meno modellate sulle esigenze della Chiesa, ricevendone il "riconoscimento" ufficiale. Negli Apocrifi, infatti, anche laddove sono evidenti rielaborazioni posteriori o degenerazioni, resta ben vivo e riconoscibile, come scrive il teologo Hennecke, lo spirito del Cristianesimo primitivo 19. Per esempio, in un Vangelo attribuito all'Apostolo Tommaso, rielaborato persino dalla Chiesa antica, dalle mani di Gesù ancora bambino di cinque anni volano via alcuni passeri plasmati con la creta. Il divin bambino dissecca come un albero un compagno di giochi piuttosto fastidioso, ma subito dopo lo richiama in vita 20. Il Padre della Chiesa Epifanio di Salamina, cui il secondo Concilio di Nicea (787) conferì il titolo di "Patriarca dell'ortodossia", non soltanto prestò piena fede a questi miracoli del Vangelo di Tommaso, ma se ne servì nella sua lotta contro gli "eretici" 21.
All'apostolo Giovanni si attribuì la tesi, che le grandiose azioni di Gesù non potrebbero essere "forse né raccontate né ascoltate" (Act. Joh. 93), eppure i miracoli di Gesù Bambino avvenivano tramite l'acqua del suo bagnetto, i suoi pannolini e il suo sudore (Hennecke, 83): infatti, come si esprime solennemente un Padre della Chiesa del IV secolo (Gregorio di Nissa): "Se le notizie intorno a Gesù restano relegate nell'ambito della natura, dove sarebbe allora il divino?" 22.
Appare fuori luogo lo zelo di moderni cattolici (come Daniel-Rops, Jesus, 27) sulle "evidenti esagerazioni" e sulle "enormi incongruenze temporali" degli Apocrifi, che "lasciano trapelare invenzioni di basso rango", (una formulazione, del resto, che induce alla conclusione ch'esistano invenzioni "d'alto rango"), anche se molte storie di miracoli contenute nel N.T. non sono certamente migliori: in effetti, è poi così grande la differenza fra i miracoli operati dai pannolini e dal sudore del Bambin Gesù e quelli attuati dai fazzoletti o dalle camicie di Paolo? Eppure questi miracoli si trovano nella Bibbia! (Atti, 19, 11). E poi, perché mai le resurrezioni degli Apocrifi sono esagerazioni, mentre quelle del N.T. non lo sono più?
Gli Apostoli forniscono prestazioni eccezionali anche negli Apocrifi: all'avversario Simone, Pietro fa leggere da un lattante, con profonda voce virile, il Levitico; anzi, riesce a far parlare addirittura un cane: "Che cosa mi ordini di fare, tu, servo dell'ineffabile Dio vivente?" - chiede il cane appena liberato dalla catena. E perché non potrebbe essere accaduto? Nel V.T. Dio fa parlare un asino (5 Mos. 22, 28 sgg.). Persino un tonno affumicato, appeso a seccare a una finestra, al cenno di Pietro sguscia di nuovo vivo e vegeto, piroettandosi in mare. Non c'è da meravigliarsi che molti, assistendo a tali portenti, abbiano abbracciato la fede cristiana (Actus Petri cum Simone, 15, 12-13).
Tutti gli "Apocrifi", ci sia consentito di sottolinearlo ancora una volta insieme a un esperto della materia 23, sono stati "concepiti con serietà", sono stati "attestazioni di fede". Se ne evince che allora si credeva a tutto... anche a uno stoccafisso risuscitato e rispedito in mare.
Note
1 Mc. 1, 34; Mt. 8, 16; cfr.
anche Lc. 4, 40.
2 Cfr. Mc. 3, 10 con Mt. 12,
15. Cfr. anche Mc. 6, 54 sgg. con Mt. 14, 35 sg.
3 Streeter, 151, dà sempre
questa definizione del Vangelo di Matteo.
4 Cfr. Mc. 10, 46 sgg. con
Mt. 20, 29 sgg.
5 Cfr. Mc. 5, 1 sgg. con Mt.
8, 28 sgg. Per Taylor, 278, questo racconto è di "derivazione
petrina", ma trova qualche difficoltà nell'interpretazione dei
maiali: "The greatest difficulty is the account of the swine".
6 Cfr. Mc. 1, 32-34 conlc.
4, 40, o anche Mc. 3, 10 con Lc. 6, 19.
7 Cfr. Mc. 8, 9 con Mt. 15,
38.
8 Cfr. Me. 6, 44 con Mt. 14,
21.
9 In occasione di eventi
straordinari, i terremoti costituivano nell'antichità un motivo
letterario diffuso. Cfr. Fiebig, Jüdische Wundergeschichten, 28
sg., 57 sgg. Dalman, Jesus-Jeschua, 198. Klostermann, Das
Matthäusevangelium, 225. Per ulteriori esagerazioni negli
scritti apocrifi e presso i Padri della chiesa, cfr. le
citazioni in Werner, Die Entstehung, 88 sgg. Anche Telfer, 98
sgg. Inoltre Anaphora Pilati A, 7 sgg.; Arnob. adv. gent. 1, 53;
Cypr. bono pat. 7; testim. 2, 23.
10 Cfr. Mc. 11, 12 sgg. e
11, 20 sgg. con Mt. 21, 18 sgg.
11 Cfr. Mt. 14, 14 con Mc.
6, 31 sg.; Mt. 19, 2 con Mc. 10, 1 sg.
12 Cfr. Strack-Billerbeck,
11, 15.
13 Ciò sottolinea a
ragione Windisch, Das vierte Evangelium, 146.
14 Cfr. Jh. 4, 46 sgg.,
6, 1 sgg. e 6, 16 sgg.
15 Cfr., ad es., W.
Bauer, Das Johannesevangelium.
16 Jh. 11, 17, 39. Al
riguardo Kautsky, Der Ursprung des Christentums, 12.
17 Leipoldt, Geschichte
der neutestamentlichen Kanons, 1, 179.
18 Trede, 114 in
riferimento ad August. civ. Dei 18, 41 e 15, 23.
19 Hennecke, 3. Cfr.
anche Goguel, 79.
20 Ps. Thomas 2, 1 sgg.;
3, 1 sgg; 17, 1 sgg e 18, 1 sgg. In proposito Hennecke, 95.
21 Epiphan, haer. 51, 20.
Sul titolo di "Patriarca dell'ortodossia" cfr. Gögler R., "Epiphanios
von Salamis", in Lexikon für Theologie und Kirche III, 2a ed.,
944 sgg.
22 Greg. Nyssa, Große
Katechese, 13, 1.
23 Michaelis, Die
Apokryphen Schriften zum N.T, XIX. Cfr. anche p. 469.