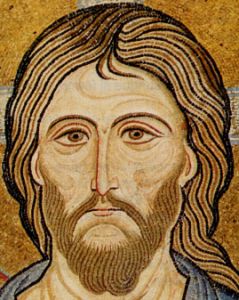
Cristo Pantocratore, Mosaico del XII secolo, Basilica di s. Marco, Venezia
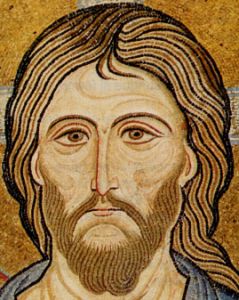
Cristo Pantocratore, Mosaico del XII secolo, Basilica di s. Marco, Venezia
Libro primo
I Vangeli e il loro retroterra storico-culturale
17. I VANGELI AL VAGLIO DELLA CRITICA
La Chiesa vive del fatto che al suo interno i risultati dell'indagine scientifica sulla vita di Gesù non sono affatto divulgati.
(Il teologo Conzelmann, Zur Methodik der Leben-Jesu-Forschung, 8)Celso
Intorno al 180 questo filosofo già più volte citato, il primo grande avversario del Cristianesimo, pose acutamente in dubbio l'attendibilità storica delle scritture cristiane.
Celso non era certo uno sprovveduto: dotato di una formazione culturale criticamente fondata e polivalente, come afferma il suo miglior conoscitore moderno, condusse la propria battaglia contro il Cristianesimo a un livello non attinto da altri critici del Cristianesimo quali Epitteto, Marc'Aurelio, Luciano e lo stesso Porfirio 1. Con la sua profonda dimestichezza con i trattati cristiani allora in voga, Celso vi riconobbe una mistura di elementi stoici, platonici, ebraici, persiani ed egizi. Smascherò come invenzioni più tarde le miracolose profezie intorno alla Passione e alla morte poste in bocca a Gesù (Orig., Cels. 2, 15); non gli sfuggì neppure la contraddizione fra il presunto segreto messianico, col quale si voleva giustificare lo scarso successo pubblico di Gesù, e la proclamazione della voce proveniente dal cielo in occasione del suo Battesimo nel Giordano, osservando con intelligenza coerente: "Vi contraddicete da soli" 2.
Il Discorso Vero di Celso, il primo scritto polemico contro il Cristianesimo, contiene obiezioni talmente fondate, che circa 70 anni dopo la sua comparsa Origene, l'intelligenza più significativa della Chiesa precostantiniana, si vide costretto a una replica, nella quale, sostanzialmente onesto qual era, più di una volta ammette le contraddizioni del Cristianesimo. Spesso le argomentazioni dell'avversario paiono illuminanti persino a lui stesso, per cui tenta di sfuggirvi con mille scappatoie. Una volta non è nemmeno in grado di ribattere alcunché a un'obiezione di Celso (Orig., Cels. 1, 67).
Materiale probatorio, che Celso aveva tratto dalla mitologia greca, dalla storia della filosofia e della religione antiche, viene addirittura passato sotto silenzio da Origene: infatti, nonostante la ripetuta asserzione del contrario, egli riassume o tralascia del tutto molte delle osservazioni anche essenziali dell'avversario, e certo non per trascuratezza o per mancanza di tempo.
Più di una volta Origene attribuisce surrettiziamente a Celso tesi da lui inventate di sana pianta, benché le argomentazioni di Celso siano certamente un po' colorite, ma sempre fondate su precisi dati di fatto, come ha dimostrato la moderna filologia. Anzi, Origene, il massimo teologo dei primi tre secoli, sovente se la cava a buon mercato dicendo a ogni piè sospinto, come scrive Geffcken, che Celso è un cervello di prim'ordine, ma ingarbugliato: "ma proprio dalle informazioni di Origene abbiamo fra le nostre mani la prova migliore del contrario".
In effetti, il testo di Celso ci è stato parzialmente tramandato solo attraverso la polemica origeniana: la Chiesa provvide opportunamente a far sparire l'opera del pensatore pagano.
Porfirio
L'opera di Porfirio venne scritta con dispiegamento tale di dottrina, di intellettualismo raffinato e di intelligenza religiosa, quale mai né prima né dopo raggiunse nessuna trattazione sulla Chiesa. In essa è prefigurata tutta la critica biblica moderna, così che lo studioso contemporaneo non può fare a meno di manifestarle il proprio assenso.Porfirio (233-304), forse cristiano in gioventù, in ogni caso discepolo di Origene, non riuscì a convincersi della verità delle dottrine cristiane. Divenne il più grande discepolo di Plotino, il vero fondatore della filosofia neoplatonica, che, a sua volta, aveva avuto modo di disputare a Roma con Gnostici cristiani.
(Frederik Poulsen, 274)... ancor oggi Porfirio rimane non contraddetto. Nella maggior parte delle tesi di fondo da lui sostenute, egli ha ragione.
(Il teologo Hamack, Mission u. Ausbreitung, I, 521)
Dei 15 Libri di Porfirio Contro i Cristiani, composti durante una convalescenza in Sicilia, sono a noi pervenuti alcuni estratti e talune citazioni, a dispetto dell'azione metodica di distruzione condotta dalla Chiesa. Egli accusa gli Evangelisti, che considera bugiardi e falsi, di aver fabbricato dei miti, evidenziandone con profonda conoscenza specifica e con grande acutezza dialettica le numerose contraddizioni.
Subito dopo il riconoscimento del Cristianesimo da parte dello Stato, l'opera di Porfirio fu ufficialmente posta al bando. Nel V secolo, sotto Teodosio II, gli ultimi esemplari furono messi al rogo ad opera della Chiesa, la quale, non contenta, fece distruggere anche molte opere cristiane, che polemizzavano col filosofo, perché contenevano ancora, come ironizza Wilamowitz (II, 527), molto pericoloso veleno anticristiano.
Eppure lo stesso Agostino dovette riconoscere l'alto livello intellettuale e la profonda dottrina di Porfirio; d'altra parte, il grande Dottore della Chiesa, il cui motto preferito erano le parole di Paolo: "Che cosa possiedi, che tu non abbia ricevuto?" (1 Cor. 4, 7), (di Paolo anche di recente è stato scritto che "fino al giorno d'oggi egli viene continuamente sopravvalutato e come uomo e come pensatore"), ha saccheggiato l'opera di Porfirio in misura tale da rendere lecita l'affermazione che sia stata la sua fonte principale. Padri della Chiesa, meno legati a Porfirio, lo hanno definito il padre di ogni sfacciato insulto contro i cristiani, e certuni lo hanno gratificato con gli appellativi di malfattore, calunniatore, folle e cane impazzito 3, mentre oggi si scorge in lui uno degli ultimi intellettuali della classicità morente, uno spirito originale e nobilissimo, che ha precorso la critica moderna quasi come un professore di teologia.
Nell'antichità, del resto, la storicità dei Vangeli non fu messa in dubbio solo dagli avversari dei cristiani: nientemeno che lo stesso Agostino confessava:
"In verità, se non fosse per l'autorità della Chiesa cattolica, non presterei affatto fede al Vangelo"!
In altri termini, Agostino fonda l'attendibilità dei Vangeli sull'autorità della Chiesa; ma la Chiesa, a sua volta, basa la propria pretesa di autorità rinviando ai Vangeli! E così fu solo grazie ai roghi, ultima ratio theologorum, come dice Schopenhauer, che per più di un millennio venne misconosciuto il riconoscimento della scarsa validità storica dei Vangeli. E oggi l'indagine critica sul Cristianesimo si trova in sostanza ancora là, dove l'avevano lasciata i Pagani Celso e Porfirio. Ma prima di volgerci a una sua analisi, ci sia consentito di chiedere ai Cattolici
Perché i teologi cattolici sono superati?
In tempi di fede cieca e ignorante, la Chiesa ha stabilito che le Scritture, specialmente il N.T., debbano considerarsi assolutamente autentiche e veritiere. Perciò oggi non le si può più stravolgere. I risultati della scienza moderna devono essere respinti e bollati come erronei. D'altra parte, le scelte sbagliate della Chiesa devono essere considerate vere. Perciò diventa necessario credere che il bianco sia nero.
(Alighiero Tondi, ex Gesuita e Professore presso l'Università Pontificia, Die Jesuiten, 395)
Perché procediamo sicuri in ogni direzione, dobbiamo sempre tenere ben fermo che ciò che ai nostri occhi appare bianco, è in realtà nero, non appena la gerarchia ecclesiastica si sia pronunciata in tal senso.
(Ignazio di Loyola, Esercizi Spirituali)
Gli insegnamenti della Teologia Cattolica vengono qui di seguito omessi, perché nei suoi esponenti non esiste alcuna libertà d'indagine.
Per mezzo dei dogmi, in cui tutto va a finire nell'arazionale e nel soprannaturale, i Papi hanno fin dal principio vincolato i teologi ad assurdità logiche, in cui consiste l'essenza propria di tali dottrine, dalle quali scaturisce per l'appunto il loro carattere sovrumano e divino. Studiosi Cattolici, ad esempio, che prima della definizione dell'assunzione in cielo di Maria in corpo e anima definivano sdegnati l'impossibilità della sua eventuale elevazione a dogma, perché da una leggenda non poteva, a loro avviso, nascere dogma alcuno, si adeguarono e si piegarono immediatamente dopo la proclamazione del dogma paventato (Klein, 51).
Inoltre i Teologi Cattolici sono obbligati dal giuramento antimodernista, sollecitato da Pio X nel 1910, che li vincola alle decisioni della Commissione papale sugli Studi Biblici, la quale condanna pressoché in blocco tutti i risultati acquisiti dalla Teologia storico-critica. Questo giuramento, che gli "inaffidabili" devono talvolta ripetere, e che a suo tempo fu rifiutato solo da due Teologi, vieta addirittura agli studiosi cattolici di illustrare e di spiegare le scritture del N.T. e dei Padri della Chiesa per scopi unicamente scientifici, ignorando l'autorità ecclesiastica!
Infine, le pubblicazioni di questi intellettuali soggiacciono all'imprimatur della Chiesa, e non solo quando si tratta di libri, ma anche di articoli su periodici e quotidiani.
Sono queste le ragioni per cui i Teologi Cattolici in possesso di serie inclinazioni critiche (cosa, per altro, piuttosto rara) possono occuparsi solo di questioni secondarie, mentre i problemi fondamentali restano per loro saldamente prestabiliti dall'autorità esterna della Chiesa. Tutto quel che concerne questioni di principio può essere trattato dai Cattolici che si occupano di Storia della Chiesa solo ed esclusivamente per raccogliere testimonia pro domo sua; devono fornire, insomma, non una spiegazione storica dei dati di fatto, ma indicazioni tendenzialmente dogmatiche, costretti per ciò stesso a usare violenza al corso effettivo della storia, reinterpretata alla luce dei dogmi successivamente elaborati.
Come e perché i Teologi Cattolici si piegano a tale atteggiamento?
Perché la maggior parte di loro sono convinti di ciò che insegnano, il che dipende (quasi sempre) dalla loro appartenenza cattolica, in quanto sono consapevolmente influenzati dalla Chiesa in un'età in cui non sono capaci di pensiero autonomo, e tanto meno di attività intellettuale personale. Via via che crescono, vengono condizionati dalla considerazione che credono in ciò in cui credettero anche i loro padri, i loro nonni, i loro progenitori. A questo sentimento si aggiunge poi la venerazione dell'autorità: lo stesso Sant'Agostino, come abbiamo visto, prestava fede al vangelo solo in nome dell'autorità della Chiesa, la quale, a sua volta, si fonda sulla tradizione evangelica: il classico cane che si morde la coda!
Presso le loro Università gli studenti di Teologia vengono istruiti in modo assolutamente unilaterale: non sanno pressoché nulla di libera ricerca, ignorano anche la Teologia critica del Protestantesimo e quel poco che ne sanno vien loro ammannito in maniera completamente distorta. Le teorizzazioni degli avversari in nessun altro luogo vengono talmente deformate e ricoperte di ridicolo come nelle Facoltà di Teologia Cattolica, dove i teorici o i promotori di un pensiero differente vengono screditati come moralmente guasti, maligni e stupidi. Va da sé che a questi studenti viene impedita la lettura delle opere condannate dalla Chiesa; le eccezioni sono rarissime e vengono concesse soltanto a pochissimi, e limitatamente a pochi libri. Nemmeno ai Sacerdoti viene consentita la lettura delle opere inserite nell'Index Librorum Prohibitorum.
Discussioni vere e proprie coi Professori sono inesistenti. Anche a proposito dei Gesuiti delle Università Pontificie, il Padre Alighiero Tondi scrive:
"è impossibile discutere coi dicenti; il loro cervello è fossilizzato; essi non vedono, ed è facile rendersi conto che alcuni di loro non vogliono credere, altri non possono: messi alle strette, montano su tutte le furie. Se uno manifesta l'ardire di oltrepassare certi confini, viene immediatamente bollato come ignorante, anche se molto garbatamente; oppure lo si convince che non ha capito e che non è capace di capire, perché non ha un cervello metafisico. Con pazienza, con abile indifferenza, con delicata ironia, e con lieve scotimento dei capo l'interlocutore viene ammesso all'udienza e gli si dice che la mente dei giovani è priva ancora di esperienza ed è piena di idee rivoluzionarie, che è necessario approfondire le cose e che solo a cinquant'anni, dopo trent'anni di studio, si comincerà a comprendere qualcosa".
Si leggano anche le sezioni dell'opera di Tondi intitolate rispettivamente Riflessioni filosofiche e Alcuni pensieri intorno alla Teologia: quel che questo ex Teologo pontificio scrive dei metodi e delle argomentazioni degli studiosi cattolici, il modo in cui mette a nudo con rara intelligenza le verità apparenti e gli avvitamenti concettuali ("Nient'altro che un pugno di mosche!"), le astrusità metafisiche ("Buio pesto!"), la diffamazione oltraggiosa degli avversari, la violenza sulle coscienze e l'intolleranza, tutto può essere confermato parola per parola da chi, come me, ha studiato, un tempo, presso un'Università Cattolica di Filosofia e di Teologia.
Naturalmente non tutti i Teologi hanno lo stomaco per ingannare se stessi e per credere in dottrine logicamente e storicamente insostenibili. Come tutti sanno, e come ha ribadito recentemente anche un famoso docente cattolico esperto in Diritto Canonico convertitosi al Protestantesimo, il quale, anche mediante estratti epistolari, ha dimostrato l'esistenza di "casi di eroica mancanza di fede" soprattutto nel clero cattolico colto, e di una "via d'emigrazione interna", esistono studiosi che respingono in toto la fede della Chiesa, pur continuando a professarla esteriormente. "Molti teologi sono guidati dal motto: "Ho compassione del popolo"".
La maggior parte di essi non ha il coraggio di uscire dalla Chiesa, spinta da ragioni tanto "nobili": la paura, unitamente ad altre motivazioni, vi svolge un ruolo assai più determinante: il timore della povertà materiale e dell'emarginazione sociale, specialmente nei paesi esclusivamente cattolici. In Italia, ad esempio, dopo il Concordato del Vaticano col regime fascista del febbraio del 1929, un sacerdote che abbandona la Chiesa viene interdetto da tutti gli impieghi pubblici: "Lo scopo di tutto ciò è gettare sul lastrico gli spergiuri, e spingerli spietatamente alla morte".
Quanto sia ancor oggi rischioso uscire dalla Chiesa nel paese del Papa può essere dimostrato da un esempio eclatante: Alighiero Tondi, docente dell'Università Pontificia Gregoriana, Gesuita dal 1936 e responsabile di "di uno degli incarichi più delicati dell'Ordine", vale a dire della lotta contro il Marxismo-Leninismo, dopo un'attività sessantennale ruppe col Vaticano nel 1952. La casa nella quale aveva trovato rifugio venne circondata dalla polizia italiana, che aveva ricevuto dai Gesuiti l'incarico di chiuderlo in un manicomio:
"... la soluzione migliore per tapparmi la bocca per sempre e per far passare sbrigativamente come prive di qualsiasi valore le molte cose che sapevo e che avrei potuto raccontare. Ho passato ore terribili; ma il piano dei miei avversari fallì: la polizia politica, dopo aver parlato con me, s'accorse immediatamente che si trattava di un tranello e non volle compromettersi, rifiutandosi di continuare a collaborare a un simile inganno".
Detto fra parentesi, anche nel caso del Domenicano ed ex prigioniero del lager di Dachau Leonhard Roth 4, suicidatosi in seguito alle polemiche con l'Arcivescovo di Monaco di Baviera, nel 1960, un alto Prelato sostenne che Padre Roth era "un caso esemplare di schizofrenia, e che sarebbe stato opportuno rinchiuderlo in qualche clinica neurologica".
Si tratta, forse, del modo abituale di togliere di mezzo Teologi e Sacerdoti cattolici un po' scomodi?
Dopo che Tondi si fu sottratto all'attacco frontale dei Gesuiti, venne diffamato sui giornali del Vaticano e dell'Azione Cattolica, e fu sommerso da una marea di lettere anonime piene di insulti; non solo, ma fu anche aggredito per strada e minacciato di morte da estremisti clericali.
"Nonostante questo fango e queste infamie vomitate proprio da coloro che si autodefiniscono i veri seguaci di Cristo, e nonostante quest'odio incomprensibile da parte di una chiesa, che si arroga il diritto esclusivo di portare alla beatitudine, io perdono tutto a tutti, dimentico ogni cosa e vivo in pace".
Alighiero Tondi, già incaricato della lotta contro il Marxismo presso l'Istituto per la Cultura Religiosa dell'Università Pontificia Gregoriana, diventò comunista e si trasferì nella Ddr.
Nei paesi non esclusivamente cattolici, invece, l'apostasia di Teologi Cattolici è meno rischiosa e perciò più frequente; in ogni caso li attende una sorte un po' incerta qualora non si convertano immediatamente al Protestantesimo, spesso il presupposto per il mantenimento di una cattedra universitaria o perlomeno di un'esistenza non precaria. Il giovane Teologo Cattolico Friedrich Pzillas si allontanò dalla Chiesa e dopo aver conseguito la laurea divenne guardiano notturno a Bonn: portento del miracolo economico moderno! Entrato in seguito al servizio del governo federale, pubblicò una delle opere anticristiane più acute e pregnanti dell'età contemporanea (Die Lebenskräfte des Christentums, 1960).
Quanto sia difficile decidere di allontanarsi ufficialmente dalla Chiesa anche per sacerdoti ormai senza fede è dimostrato dal caso del prete francese Turmel. Per circa quarant'anni firmò col proprio nome opere ossequienti all'ortodossia cattolica, ma nel contempo ne pubblicò molte altre in polemica col Cattolicesimo con molti pseudonimi. Dopo aver giurato più volte sulla propria ortodossia, schiacciato da un notevole materiale probatorio, nel 1930 riconobbe come propri quattordici pseudonimi, fu scomunicato e definito vitandus; le sue opere finirono, manco a dirlo, nell'Index dei libri proibiti.
All'attività critica dei Cattolici, guidata attentamente dall'alto e severamente sorvegliata, si contrappone una ricerca sui Vangeli vecchia di quasi due secoli ad opera di Teologi protestanti liberali, del cui immenso lavoro condotto con eccezionale acribia il profano non è nemmeno in grado di farsi un'idea. Molte cose sono state acclarate in maniera definitiva, molte altre vengono energicamente contestate, ma sono stati ottenuti risultati essenziali. Così la moderna Teologia storico-critica dichiara unanimemente che non è possibile ricavare quasi nulla intorno alla vita di Gesù né dei suoi singoli stadi né della sua specificità spirituale né, tanto meno, della sua evoluzione.La vita e l'insegnamento di Gesù nel giudizio della moderna Teologia storico-critica
Se vogliamo tracciare un quadro della vita di Gesù, abbiamo poco materiale a disposizione. Lamentarsene non porta a nulla. Dobbiamo semplicemente stabilire il risultato dell'analisi filologica dei testi, senza riguardo ai nostri sentimenti e ai nostri desideri.
(Il teologo Conzelmann, Die Formgeschichtliche Methode, 61)Il contenuto del messaggio di Gesù continua a essere problematico.
(Il Teologo Percy, 20)
I Teologi critici non si limitano a lasciare da parte la descrizione evangelica della vita di Gesù, (la "cornice" della sua storia), le singole situazioni, le notizie dei tempi e dei luoghi, la maggior parte dei miracoli (giudicati secondari e inventati in un secondo tempo), ma anche talune parti del suo insegnamento tradizionale.
Da D.F. Strauß e F.C. Baur a Wellhausen e Wrede, da Bousset e Goguel a Dibelius, Klostermann, Bultmann, Werner, Hirsch e altri, la Teologia critica ritiene che la dottrina del Gesù storico non è identica alla sua riproduzione da parte degli Evangelisti. Al contrario, la ricerca non vincolata ai dogmi, ai giuramenti e agli imprimatur indica che la predicazione gesuana nel suo cammino attraverso i primi Apostoli e i missionari più antichi, fino alla seconda e alla terza generazione di cristiani (alla quale appartengono gli Evangelisti), ha subìto, involontariamente o a ragion veduta, modificazioni e ritocchi sostanziali.
Certo, la Teologia scientifica crede che le parole di Gesù siano state tramandate più accuratamente delle sue azioni, che per quanto concerne i discorsi e i racconti evangelici si tratti di contesti originariamente orientati in senso del tutto differente e quindi progressivamente contaminati. In altre parole, è un fenomeno analogo a quello verificatosi contemporaneamente nel Giudaismo: la Halakha, cioè la sezione giuridica del Talmud, è stata tramandata più esattamente della Haggada, cioè del materiale leggendario e teologico ampiamente riveduto e corretto dagli Scribi. Ma nemmeno le parole di Gesù erano assolutamente intoccabili, giacché furono riplasmate e moltiplicate con chiose e altri ingredienti ritenuti adeguati. Per alcune è possibile provare che non furono mai pronunciate, per altre il problema resta aperto, per altre ancora è lecito affermarne l'autenticità.
Sono perlopiù autentiche solo quelle parole di Gesù, che contraddicono la dottrina della Chiesa, come può evidenziare l'esempio che segue: in Matteo 10, 5 Gesù dice:
"Non andate dai Pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; andate piuttosto (soltanto) dalle perdute pecore della casa d'Israele".
La frase è autentica proprio per il fatto che la cristianità perseguì immediatamente la missione presso i Pagani, fece cioè esattamente il contrario di questa raccomandazione di Gesù. Sicuramente essa non avrebbe inventato parole come queste, che contraddicevano apertamente la sua prassi. Ma per giustificare questo atteggiamento, in seguito, alla fine del vangelo di Matteo fu introdotto l'ordine del battesimo, nel quale, in aperto contrasto con le parole su citate (e autentiche), Gesù "risorto" ordina la missione mondana (Mt. 28, 18 sgg.). Tale ordine, eseguito dai cristiani prima ancora che fosse impartito, viene unanimemente considerato un falso da tutta la Teologia critica.
Bultmann
Nella sua analisi delle parole di Gesù, il teologo Bultmann tralascia fin dall'inizio tutte le profezie intorno alla Passione e alla Resurrezione 5 poiché da lungo tempo sono state riconosciute come spurie, come invenzioni postume della Comunità cristiana. Ma anche quella ricca e decisiva categoria di parole di Gesù, che lo studioso definisce "Ich-Worte" a parte potiori, è in gran parte opera della cristianità ellenistica, e dunque neppure il frutto della elaborazione della Comunità primitiva, presso la quale, in ogni caso, essa deve avere avuto il suo principio.
Al contrario, l'autore cattolico di un'ampia biografia di Gesù, estremamente colorita e fantasiosa, Daniel-Rops, non dubita nemmeno per un attimo che quelle parole non siano realmente uscite dalle labbra di Gesù. La loro autenticità è riconosciuta anzitutto sulla base del loro "splendore", quindi della loro "risonanza"; infine è in grado "di gustare per così dire lo stile di un testo", ed è proprio lo "splendore" ch'egli "gusta" la "prova irrefutabile" della "immediata dottrina di Gesù".
Rudolf Bultmann riassume i risultati della Teologia storico-critica nel momento stesso in cui afferma che il Vangelo più antico non è una biografia, né una fonte storiografica e neppure la testimonianza di un testimone oculare, bensì "l'opera di uno scrittore, che si muove all'interno della teologia della comunità", "una creazione della comunità ellenistica". Non è il Gesù storico ad essere predicato, ma l'astorico "Cristo della fede e del culto". L'opinione, secondo la quale almeno il Vangelo più antico lascerebbe intravedere il corso della vita di Gesù in modo quasi storicamente verisimile, da questo Teologo viene definita una "pia illusione". L'attività principale di questo Evangelista, e tanto più di quelli più tardi, si svolge all'ombra di una "regola artificiale" e di un "lavoro redazionale di seconda mano"; i Vangeli non sono altro che "leggende cultuali amplificate".
Nella sua Geschichte der synoptischen Tradition, un'opera esemplare della più recente ricerca biblica, apparsa da poco nella 3 edizione, Bultmann rinvia tanto frequentemente alle "fiabe della letteratura mondiale", dalle antiche storie cinesi e, passando attraverso le fiabe degli Indiani d'America, giungendo fino alle leggende dei mari del Sud, alle narrazioni zingaresche e al patrimonio delle saghe germaniche, che spesso si ha la sensazione di avere a che fare più con un esperto in fiabe che con uno studioso del N.T. Per altro, le cose non mutano a proposito del V.T., nel quale moltissimo è tratto dal mondo delle fiabe, delle leggende e delle saghe.
Che cosa resta, dunque, in Bultmann? Uno dei suoi critici così riassume: "Che Gesù sia stato battezzato, che occasionalmente abbia compiuto guarigioni e predicato, questo viene ammesso; solo che ciò che viene riferito sulla base di prove è perlopiù di secondaria importanza" (Fascher, Die Formgeschichtliche Methode, 34-129).
Dibelius
Nella sua Formgeschichte des Evangeliums, opera fondamentale della moderna critica neotestamentaria, il teologo Martin Dibelius distingue tre generi di narrazioni singole: paradigma, novella e leggenda.
Dibelius attribuisce la maggiore attendibilità ai paradigmi, alle storie esemplari, che spiegano il Vangelo col precedente dell'azione di Gesù. La loro attendibilità è, tuttavia, "solo relativa": infatti, a queste narrazioni manca "l'obiettività del protocollo", non sono "neutrali", vogliono "colpire colui che ascolta"; esse contengono "frasi, soprattutto parole di Gesù, della cui attendibilità bisogna dubitare".
Al secondo gruppo, quello delle "novelle", Dibelius riferisce la guarigione del lebbroso e del sordomuto, il placamento della tempesta, il cammino sopra le acque, il pasto dei cinquemila, le nozze di Cana, la resurrezione di Lazzaro e del fanciullo di Nain ecc. Tali "novelle" sono, nel migliore dei casi, ancor meno attendibili delle già inattendibili fra le più attendibili parti dei Vangeli.
Fra le leggende - "pie storie, note e diffuse in tutto il mondo" - lo studioso annovera l'episodio di Gesù dodicenne nel Tempio, l'annunciazione della nascita del Battista e di quella di Gesù, la nascita in Betlemme col messaggio ai pastori, le storie di Simeone e Hanna, dei Magi d'Oriente, della pesca miracolosa e della passeggiata marina di Pietro, la scelta dei discepoli, l'unzione di Gesù compiuta dalla grande peccatrice, la fine di Giuda ecc.
Già il Vangelo di Marco è, secondo questo Teologo, "in ultima istanza sicuramente un libro mitico", benché la tradizione che ne costituisce la base nelle sue parti principali non lasci intravedere in Gesù un personaggio mitico. I primi cristiani, come Dibelius sostiene in altra parte, "non erano interessati alla storiografia", non volevano "scrivere storia, ma predicare il Vangelo". Di conseguenza il N.T., anche secondo Dibelius, non fa altro che illustrare
"ciò che la Comunità già crede intorno a Gesù, non ciò che lui stesso pensava di sé, e nemmeno ciò che altri pensavano di lui durante la sua vita".
Altri teologi
Teologi di fama quali Bultmann e Dibelius non sono, ovviamente, i soli a raggiungere tali risultati. La Teologia critica nel suo complesso scorge nei Vangeli, per usare una definizione coniata da Hans von Soden e fatta propria da altri studiosi, "leggende cultuali" 6, "variopinti prodotti letterari", o come scrive Carl Schneider "raccolte di proverbi e parabole, storie edificanti e di intrattenimento miste di biografia e di leggenda" (Schneider, Geistesgeschichte, I, 29), "una mescolanza di verità e invenzione", secondo Adolf Jülicher (352); "nient'altro che una silloge aneddotica", secondo Martin Werner 7, Kendrik Grobel sottolinea che in essi "non si trova alcun interesse storiografico" (Grobel, 65).
Perciò si può
dire con Maurice
Goguel che i
Vangeli "possono
essere
utilizzati
soltanto con
estrema
circospezione" (Goguel,
73. In rel. a
Marco. Cfr.
anche Knopf,
Einführung, 63);
essi ci
ripetono,
secondo W. G.
Kümmel,
nient'altro che
"la notizia del
personaggio
storico quale è
giunta sino a
noi"
8. La
ricerca critica,
dunque, per
citare ancora il
Teologo Käsemann,
"ha reso dubbia
su tutta la
linea la
credibilità
storica della
tradizione
sinottica"
9.
Anche uno
studioso
cattolico,
Meinertz, sotto
l'impulso delle
conoscenze
acquisite dalla
Teologia
critica, è
costretto ad
ammettere che i
Sinottici "hanno
improntato il
loro
orientamento
operando su un
materiale
tradizionale" (Meinertz,
1, 13 sg).
Raramente i
Cattolici si
spingono fino a
tanto; il loro
atteggiamento
abituale verso
la Bibbia è
espresso
piuttosto da una
sollecitazione
come questa che
segue:
"Non è lecito all'uomo accostarsi alla Scrittura con piglio autoritario, e stabilire quale sia l'autentica figura di Cristo sulla base di criteri qualsiasi appartenenti all'ordine mondano (!); al contrario, egli deve avvicinarsi compunto e obbediente, come alla parola di Dio" 10.
In questo modo proprio il Libro dei Libri dovrebbe essere letto lasciando da parte qualsiasi punto di vista scientifico, col quale viene affrontata la lettura di tutti gli altri prodotti letterari. Ma chi è al corrente della quantità enorme di contraddizioni e di incongruenze presenti nei Vangeli è perfettamente in grado di rendersi conto perché mai la Chiesa sia costretta a esigere una fede acritica nella Bibbia.
Risultato
Il risultato più importante della critica biblica libera da dogmatismi dei secoli XIX e XX è il riconoscimento della non identità del Gesù di Nazareth col Cristo della Bibbia e della Chiesa.
Non è solo il Quarto Vangelo a presentare caratteri di astoricità, come si riteneva prima, ma sono in gran parte astorici anche gli altri tre. Già quel che i missionari cristiani andavano predicando prima della loro stesura non ha nulla a che fare con la veridicità storiografica, perché alla base della tradizione non si trova lo sforzo di perseguire un intento storiografico, biografico e protocollare, bensì una finalità missionaria e dogmatica edificante, propagandistica, apologetica, polemica e tendenziosa. Come gli Evangelisti più recenti migliorarono in molti punti le affermazioni di Marco, moltiplicando e amplificando i miracoli di Gesù, divinizzandone sempre più l'immagine, allo stesso modo fin dal principio i predicatori cristiani del periodo pre-evangelico si posero nei confronti della figura storica del Galileo.
Secondo tutta la critica scientifica della Bibbia, i Vangeli non sono storicamente attendibili già nei loro fondamenti, ma sono, al contrario, prodotti letterari mitologizzanti, notevolmente rielaborati dallo zelo fideistico, scritti di edificazione missionaria, che si proponevano non solo di rafforzare la fede dei cristiani, ma anche di guadagnare nuovi adepti. I loro autori non possedevano alcun interesse verso la realtà storica come noi la concepiamo; in altre parole, si può affermare che i Vangeli sono una creazione fantastica della comunità cristiana posteriore, la quale è la vera plasmatrice dell'immagine del Cristo. A quest'opera non sono estranei gli influssi di miti antichissimi.
Note
1 Andresen,
395. Cfr. anche
223 sg; 237 e
passim,
Miura-Stange,
37.
2 Ibidem, 2,
72; 2, 74 (ad
opera dei
Giudei).
3 Cyrill.
Al., adv. Jul.
Cfr. anche Firm.
Mat., err. 13,
4. Vedi,
inoltre, Poulsen,
274 e 276 sg.
4 Nei primi
anni postbellici
il Cardinale
Faulhaber non
aveva trascurato
di esprimere
all'ex-detenuto
del lager di
Dachau, Padre
Leonard Roth, il
quale, unico
sacerdote, dopo
la sua
liberazione era
rimasto
volontariamente
nel campo a
curare settemila
ammalati di tifo
e poi come
curato nel
villaggio di
baracche di
Dachau, "un
altissimo
riconoscimento
per la sua opera
e il suo
impegno" e di
dichiarare: "Ho
presentato al
Santo Padre i
Suoi resoconti
dal Lager"
(Questo e ciò
che segue
scriviamo
seguendo R.
Seeliger, Die
Andere Zeitung,
7 dicembre
1961). Ma quando
Padre Roth, che
si trovava a
Dachau da quel
giorno terribile
del 1942 in cui
le SS fucilarono
nel cortile del
campo migliaia
di prigionieri
di guerra
sovietici, anche
alla fine degli
anni Cinquanta
continuava a
evocare quel
passato, a
mettere in
guardia contro
la rinascita del
Nazismo e contro
i raduni delle
SS e di gente
come Oberländer
e Globke, a quel
punto tutto ciò
apparve fuori
luogo alla
gerarchia
cattolica. (Del
resto, essa
aveva combattuto
Hitler fino al
1933, lo aveva
sostenuto fino
al 1945 e
condannato dopo
la fine della
guerra; allo
stesso modo il
suo
atteggiamento
mutò ancora
negli anni
Cinquanta).
Il Vescovo di Monaco Neuhäusler bollò il comportamento di Padre Roth, definendolo un "eccesso di zelo e una critica smodata a uffici, persone e situazioni". In seguito alla visita al lager di Dachau di un gruppo di pellegrini inglesi, costui sostenne che sei componenti del gruppo si erano lamentati con lui del fatto che Padre Roth "aveva seminato odio" con le sue spiegazioni, "connotando negativamente" il pellegrinaggio; tutto ciò fu immediatamente smascherato dagli inglesi come pura e semplice calunnia. Quando, poi, Padre Roth protestò contro il decreto del Consiglio Comunale di Dachau che imponeva di occupare con poveri senza tetto quelle miserevoli baracche (vale a dire, un vero cimitero di massa) e sulla base della documentazione del Lager fece presente " ... che nel campo di concentramento di Dachau -senza contare quelli che erano stati portati ad Auschwitz per essere gasati -erano miseramente periti oltre 70.000 prigionieri", l'Ordinariato dell'Arcivescovado di Monaco e di Frisinga inviò un severo biasimo e il 25 marzo 1960 lo privò della Parrocchia di Dachau. Non gli fu consentito nemmeno di congedarsi ufficialmente dalla sua comunità.
In un primo
momento Roth
trovò asilo
presso una
curatoria
sudtirolese, ma
anche qui venne
colpito da
ulteriori
calunnie: un
alto prelato di
Monaco lo definì
pazzo;
all'Ordinariato
di Monaco un
giovane dichiarò
addirittura di
aver avuto
rapporti
immorali con
lui. A quel
punto Padre Roth
abbandonò la
canonica e
cominciò a
vagabondare per
l'Austria come
un reietto; il
15 agosto 1960
due abitanti del
villaggio di
Braz rinvennero
nella boscaglia
il suo cadavere
in avanzato
stato di
decomposizione.
Uno dei due
affermò:
"Sembrava da
escludersi un
incidente, dal
momento che il
morto giaceva
accuratamente
adagiato sulla
tonaca e sul
pullover, con
accanto un
thermos, un
parapioggia e
una Bibbia
aperta". A che
scopo un
guardaboschi,
che durante le
operazioni di
recupero del
cadavere aveva
scattato una
fotografia del
luogo del
rinvenimento
all'insaputa
dell'autorità
inquirente, si
sentì in dovere
di aggiungere
"che accanto al
morto si trovava
un taccuino con
l'annotazione:
"Se mi dovesse
accadere
qualcosa,
avvertire per
favore la mia
governante. Non
voglio nemmeno
essere sepolto
in altro
luogo...". Il
passaporto del
defunto e una
somma di denaro
di oltre 140
Marchi erano
accuratamente
collocati in un
sacchetto
impermeabile.
Inoltre,
trovammo una
pastiglia di
Adalin e
un'altra
pasticca di
genere
sconosciuto.
Incidente di
montagna? No,
non lo credo
affatto!".
Ciononostante
venne indicato
come causa della
morte
"probabilmente
un incidente di
montagna", non
senza, per
altro, "una
serie concitata
di telefonate
fra
l'Ordinariato di
Monaco e gli
inquirenti della
Valle di
Voralberg". E
non basta.
Quando il
giovane, che
aveva sostenuto
di aver avuto
rapporti
innominabili con
Padre Roth,
seppe della sua
tragica fine,
ammise (poco
prima di morire
anche lui
durante
un'escursione in
montagna a causa
di un
"misterioso
attacco
cardiaco") che
quel che aveva
affermato su
Padre Roth di
Dachau "a
Monaco, sotto il
sigillo del
segreto
confessionale"
non
corrispondeva
alla realtà dei
fatti: "non so
nemmeno io
perché sono
arrivato a dire
cose simili su
quell'uomo". E
non basta
ancora! Il
Vescovo
Ausiliario
Neuhäusler, che
in una lettera
strettamente
confidenziale
indirizzata
"Alle spettabili
direzioni dei
giornali della
Chiesa
cattolica"
suggeriva la
possibilità di
un suicidio di
Padre Roth,
esortando "a
perdonarlo... e
a tacere", circa
la sua
permanenza nel
Lager scrisse:
"Che cosa aveva
commesso? Era un
criminale?". Il
Dr. Neuhäusler
prese posizione
sull'articolo di
Rolf Seeliger,
apparso sulla
Andere Zeitung
del 1 febbraio
1962. Ma tutte
le obiezioni
significative
del Vescovo
furono smontate
pezzo per pezzo
da Seeliger nel
medesimo numero
del giornale.
5 Mc. 8, 31;
9, 9; 9, 31; 10,
33 sg.; 14, 21,
41; Mt. 17, 12;
Lc. 17, 25 ecc.
6 In
Ackernann, Jesus,
7. Cfr. anche
116. Inoltre
Bultmann,
Synoptische
Tradition, 396.
7 Werner,
Die Entstehung,
65, in
riferimento a
Marco.
8 Kümmel,
Die Eschatologie
der Evangelien,
227.
9 Käsermann,
Das Problem des
historischen
Jesus, 144.
10 Guardini,
Das Bild von
Jesus dem
Christus, 124.