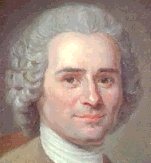LE AVVENTURE DELL'AUTOBIOGRAFIA
quando la vita è un romanzo
J. J. Rousseau (1712-1782)
Nato a Ginevra nel 1712, Jean Jacques Rousseau è con Voltaire e Diderot uno dei filosofi più conosciuti del Settecento. Se in opere come il Contratto sociale(1762) e l’Emilio o dell'educazione (1762) mette in luce la portata del pensiero illuminista, con il romanzo Giulia o la Nuova Eloisa (1761) e poi le Confessioni (postume, 1782) sviluppa l’indagine della sensibilità come ragione e fondamento non solo dell’idea di individuo, ma soprattutto delle relazioni fra gli uomini.
Vivendo fra la Svizzera, l’alta Savoia, l’Inghilterra e Parigi, dove nel castello dell’Ermitage scrisse i suoi libri più importanti, Rousseau rappresenta con i suoi scritti l’intellettuale che salda il pensiero della cultura dei lumi al gusto delle generazioni preromantiche.
Coltivando nello stesso tempo l’amicizia di grandi donne quali la Signora di Warrens e Madame d’Epinay, non meno di quella degli illuministi che gli affidarono la redazione degli articoli di musicologia per l’Encyclopédie, il grande dizionario filosofico che rappresenta la sintesi del pensiero del Settecento, riuniva il meglio del pensiero dei Lumi in materia tanto scientifica quanto letteraria.
Non c’è dubbio che le Confessions del filosofo ginevrino, J. J. Rousseau, autore anche della Nouvelle Héloïse, romanzo di tendenza nel gusto dei lettori e soprattutto delle lettrici del secolo, segnino un capitolo nuovo nella storia del racconto della propria vita. L’apparizione di questo esempio innovativo di genere autobiografico risulta di straordinario interesse, perché ci permette di cogliere il piacere di una descrizione senza veli del suo protagonista.
Scritta in un’epoca in cui la filosofia del sensismo riscopre il valore fondamentale delle emozioni e delle sensazioni per i processi di conoscenza, le Confessions dichiarano tutto il loro interesse per la descrizione degli affetti e delle passioni, così come si formano nelle radici psicologiche della giovinezza.
J. J. Rousseau, Le Confessioni, 1
M'impegno in un'impresa senza esempio, e la cui esecuzione non avrà imitatori. Voglio mostrare ai miei simili un uomo nella nuda verità della sua natura; e quest'uomo sarò io.
Io solo. Sento il mio cuore e conosco gli uomini. Non sono fatto come nessuno di quelli che ho incontrati; oso credere di non essere come nessuno di quanti esistono. Se non valgo di più, sono almeno diverso. Se la natura abbia fatto bene o male rompendo lo stampo nel quale mi ha colato, non si può giudicare che dopo avermi letto.
|
Suoni pure, quando vorrà, la tromba del giudizio finale: io mi presenterò al giudice supremo con questo libro fra le mani. Gli dirò fieramente: "Ecco che cosa ho fatto, che cosa ho pensato, che cosa fui. Ho detto il bene e il male con la stessa franchezza. Nulla ho taciuto di cattivo, nulla ho aggiunto dì buono, e, se ho usato qua e là qualche trascurabile ornamento, l'ho fatto solo per colmare le lacune della mia memoria: ho potuto supporre vero quanto sapevo che poteva esser stato tale, mai ciò che sapevo falso. |
Mi sono mostrato come fui, spregevole e vile quando lo sono stato, buono, generoso, sublime, quando lo sono stato: ho svelato il mio essere interiore come tu stesso lo hai veduto. Essere eterno, raduna intorno a me l'innumerevole turba dei mici simili: ascoltino le mie confessioni, piangano sulle mie bassezze, arrossiscano per le mie miserie. Ciascuno d'essi con la stessa sincerità scopra a sua volta il suo cuore ai piedi del tuo trono: e poi uno solo ti dica, se ne ha il coraggio: "Io fui migliore di quell'uomo".
Commento alle Confessioni di Rousseau, 1
La premessa
La prima pagina dell'autobiografia è già una dichiarazione di intenti: dipingere un uomo nella sua nuda verità. Non l'individuo esemplare di una vita agiografica, non il filosofo modello di virtù personale e di scienza, ma l'uomo nelle sue debolezze, talvolta anche sconcertanti.
|
Il canone dell'originalità, dell'irripetibilità
accompagna la coscienza di vivere una vita unica nei suoi aspetti anche più difficili e
controversi.
Se esiste in ogni autobiografia un latente senso di colpa al quale si vuol rispondere con la giustificazione delle proprie azioni, si può dire che Rousseau proclama a gran voce in questo passo il diritto di sfidare il giudice dell'universo. All'elogio delle proprie virtù si sostituisce dunque la sfida nel rivelare quanto nessuno avrebbe il coraggio di fare. |
Il primato dell'originalità che diventerà un mito dell'età romantica viene dunque fortemente sottolineato, perché la sincerità di chi si svela a se stesso e sente la condizione dei propri simili prima ancora di comprenderla sul piano razionale, diviene lo scopo principale di un'autobiografia che cambierà il modo di pensare e di scrivere la propria vita.
J. J. Rousseau, Le Confessioni, 2
Louise-Eléonore (1) di Warens era una signorina de la Tour de Pil, nobile e antica famiglia di Vevay, città nel cantone di Vaud. Aveva sposato giovanissima il signor di Warens, della casa di Loys di Losanna, primogenito del signor di Villardin. Il matrimonio, rimasto senza figli, non era stato felice, e la signora di Warens, spinta da qualche dispiacere domestico (2), colse l'occasione in cui il re Vittorio Amedeo era ad Evian per varcare il lago e inginocchiarsi ai piedi di quel principe, abbandonando cosi marito, famiglia, patria, per una sventatezza molto simile alla mia, e che anche lei ebbe tutto il tempo di rimpiangere.
Il re, cui piaceva la parte del cattolico zelante, la prese sotto la sua protezione, le accordò una pensione di millecinquecento lire piemontesi, somma ragguardevole per un principe cosi poco prodigo, e, accortosi che per quell'accoglienza lo supponevano innamorato di lei, la mandò, con la scorta di un distaccamento delle sue guardie, ad Annecy, dove, sotto la direzione di Michel-Gabriel de Bernex, vescovo titolare di Ginevra, ella fece professione di abiura nel convento della Visitazione.
Da sei anni viveva là (3) quando vi andai; e lei ne aveva ventotto, essendo nata col secolo. La sua era una di quelle bellezze che si conservano, perché sono più nella espressione che nei lineamenti; cosi la sua era ancora nel suo primo splendore. Aveva un'aria carezzevole e tenera, uno sguardo dolcissimo, il sorriso d'un angelo, una bocca sulla misura della mia, capelli biondo cenere di non comune bellezza, acconciati in una maniera un po' negletta che la rendeva molto attraente. Era piccola di statura, bassa anzi, e un po' tozza, seppur senza deformità. Ma non si poteva vedere una testa più bella, seni, mani, braccia più belli.
La sua educazione era stata molto mista: al pari di me, ella aveva perduto la madre alla nascita (4), e, ricevendo insegnamenti a casaccio, come capitavano, aveva imparato un po' dalla governante, un po' dal padre, un po' dai suoi maestri e molto dai suoi amanti, soprattutto da un signor di Tavel (5), che, essendo dotato di gusto e di cognizioni, ne ornò la persona da lui amata.
Ma tanti generi differenti si nocquero a vicenda, e il poco ordine che lei vi mise le impedì di estendere nei suoi diversi studi la naturale dirittura della sua mente. Cosi, pur avendo alcuni principi di filosofia e di fisica, non mancò di contrarre la passione di suo padre per la medicina empirica e per l'alchimia: fabbricava elisir, tinture, balsami, magisteri; pretendeva di possedere segreti. I ciarlatani, servendosi della sua debolezza, divennero i suoi padroni, l'angustiarono, la rovinarono e consumarono, tra i fornelli e le droghe, il suo ingegno, i suoi doni e i suoi vezzi, con i quali avrebbe potuto far la delizia delle migliori società.
Ma, se tanti vili furfanti abusarono della sua educazione mal diretta per offuscare i lumi della sua ragione, il suo cuore eccellente resisté a ogni prova e restò immutato: il suo carattere affettuoso e dolce, la sua pietà per gli sventurati, la sua bontà inesauribile, il suo umore allegro, aperto e franco non si guastarono mai; e anche alle soglie della vecchiaia, nelle strettezze dell'indigenza, fra gli acciacchi e le diverse calamità, la sua bella anima serena le conservò fino al termine della vita tutta l'allegria dei giorni più belli.
I suoi errori dipesero da un fondo inesauribile di attività, che esigeva continua occupazione. Le occorrevano non intrighi da donnicciole, ma grandi imprese da compiere e da dirigere. Era nata per i grandi affari. Al suo posto, la signora di Longueville (6) non sarebbe stata che un'arruffona; al posto della signora di Longueville, lei avrebbe governato lo Stato.
Le doti del suo ingegno rimasero spaesate, e quel che, in una condizione più elevata, avrebbe generato la sua gloria, in quella in cui visse fece la sua rovina. Nelle cose che restavano nella cerchia delle sue possibilità, ella ampliava sempre, nella sua testa, i piani e vedeva sempre le cose in grande. Avveniva cosi che, impiegando mezzi proporzionati alle sue concezioni piú che alle sue forze, falliva per colpa di altri, e, quando i suoi progetti fallivano, ella ci rimetteva anche quando altri non avrebbero perduto quasi nulla. Quel gusto degli affari, che le causò tanti mali, le fece almeno un gran bene nel suo asilo monastico, impedendole di prendervi dimora per il resto dei suoi giorni, com'era tentata di fare.
La vita monotona e semplice delle monache, il loro minuto ciabolìo di parlatorio, tutto ciò non poteva lusingare una mente sempre in moto che, costruendo ogni giorno nuovi sistemi, aveva bisogno di libertà per dedicarvisi.
Il buon vescovo di Bernex (7), con meno intelligenza di Francesco di Sales, gli somigliava in vari punti; e la signora di Warens, ch'egli chiamava sua figlia e che somigliava alla signora di Chantal (8) in parecchi altri punti, avrebbe potuto somigliarle anche nel suo ritiro, se la sua passione non l'avesse distolta dal grigiore del chiostro.
Non certo per mancanza di zelo quell'amabile donna non si dedicò alle minute pratiche di devozione che parevano piú adatte ad una convertita, vivente sotto la direzione d'un prelato. Qualunque fosse stato il motivo del suo mutamento di religione, ella fu sincera in quella che aveva abbracciata. Può darsi che si sia pentita d'aver commesso l'errore, ma non che abbia desiderato di ritrarsene.
Non solo morì buona cattolica, ma tale visse in buona fede, e oso affermare, io che penso di aver letto in fondo al suo cuore, che solo per avversione alle smancerie non faceva in pubblico la devota: aveva una pietà troppo ferma per ostentare la devozione.
- In realtà Louise-Françoíse. Nata a Vevey nel 1699, aveva sposato nel settembre 1713 Sébastien-Isaac de Loys de Villardin, che prese poi il titolo di Warens, dal nome d'una terra del paese di Vaud di cui era signore.
- Aveva fatto molti debiti.
- Non da sei, ma da due anni, ed esattamente dall'ottobre 1726.
- In realtà un anno dopo, nell'aprile 1700-
- Étienne-Sigismond de Tavel.
- Anne-Geneviève di Bourbon-Condé, duchessa di Longueville (1619-79), l'eroina della guerra della Fronda.
- Il quale era stato anche lui vescovo titolare di Ginevra, con sede in Annecy.
- Jeanne-Françoise Fremiot, baronessa di Chantal, la fondatrice, con san Francesco di Sales, dell'Ordine della Visitazione (1610).
Commento alle Confessioni di Rousseau, 2
La giovinezza è il campo d'indagine dell'autobiografia di Rousseau, è il momento in cui si forma la radice della pianta uomo, in cui prendono corpo i moventi e movimenti della sensibilità. Essa non è ridotta a qualche fatterello di breve consistenza narrativa, ma è attraversata come il luogo delle prime fondamentali avventure dell'individuo. Con essa prendono corpo non solo le pulsioni sessuali ma anche quelle estetiche, cioè la capacità di trasformare la vita in arte.
Come appare al Federico dell'Educazione Sentimentale il bel volto di Mme Arnoux, rendendolo per la prima volta capace di concepire il progetto artistico della propria vita, così nelle Confessioni la Signora di Warrens è la protagonista dell'apprendistato del giovane filosofo. Colta bella e nobile "mammina" appartiene a quel raro numero di donne elette che sa ispirare la passione senza distruggere il cuore di chi la prova. La sua bellezza dal tratto maturo appare confortata da un'idea apollinea cioè rasserenante tale da ispirare per chi la conosce un'immediata confidenza anche se la sua condizione è tanto diversa per rango ed età.
Così come la descrive Rousseau, Louise Elénoire de Varrens era più bella d'espressione che di lineamenti, sicché il suo fascino non era soggetto al tramonto del tempo e poteva corroborare quella simpatia d'anima che fin dal primo momento ispirò al giovane Jean Jacques un misto di affetto e devozione.
L'educazione che riceve l'autore dalla giovane donna è per così dire istintiva, edipica diremmo oggi, in quanto suscitata da un moto d'animo che unisce filosofia, amicizia e sublimato desiderio.
Colta senza essere erudita, "mammina" aveva creato intorno alla vita di Jean Jacques l'ambiente più favorevole per fare maturare in lui la disposizione delle lettere e un'attrazione oscura che si manifesterà in una disposizione feticistica che fa comportare il bambino come il appassionato degli amanti. Da una parte assistiamo alle conversazione serali tra il giovane Rousseau e la Signorina di Warrens che hanno come oggetto gli stessi autori che Elénoire aveva conosciuto nei dialoghi con gli uomini che desideravano piacerle, dall'altra ci troviamo davanti ad episodi maniacali in cui l'autore fa emergere i lati meno sereni del loro rapporto.
Rousseau J.J. (1782-9), Le confessioni, Garzanti 2006