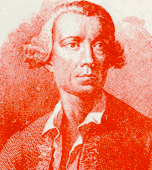LE AVVENTURE DELL'AUTOBIOGRAFIA
quando la vita è un romanzo
Vittorio Alfieri (1749-1803)
Dal 1749 al 1803, la vita dell’Alfieri attraversa tutto il secondo Settecento e l’Europa, caratterizzandosi tanto nell’insofferenza verso i modelli culturali imposti, quanto per la tendenza a far maturare, proprio in opposizione ad essi, la sua vocazione letteraria.
|
Dal 1766 inizia per lui la grande stagione dei viaggi che lo porteranno prima nelle capitali italiane e poi in quelle europee, con la consapevolezza dei limiti provinciali della sua patria. |
|
Snob saturnino, cioè aristocratico melanconico, egli farà tappa a Parigi, Londra, Berlino e Stoccolma, portandosi dietro più il desiderio del viaggio che quello della meta, più il bisogno di partire da un luogo che quello di arrivarci. |
E’ di questo periodo e più precisamente del 1771 l’avventura londinese con Penelope Pitt, che dà luogo al burrascoso romanzo amoroso della sua vita.
Mentre continuano i viaggi verso il Portogallo e la Spagna, la vocazione letteraria inizia a farsi strada tra gli accessi di malinconia, gli stupori e gli sdegni di una personalità istrionica nel senso etimologico del termine, cioè teatralizzata.
Dopo la stesura in francese dell’Esquisse du jugement universel (1773), dopo le prime tragedie Cleopatra, Filippo Polinice (1776), arrivano l’anno dopo la Congiura dei pazzi, l’Oreste e la Virginia, e soprattutto Luisa Stolberg, che sarà la sua compagna per il resto della vita.
A questo punto il viaggiatore insofferente si trasforma completamente nel letterato ispirato che scrive nel 1782 il Saul e la Merope e nel 1774 la Mirra.
Sono ormai gli anni della rivoluzione francese per la quale scrive l’ode Parigi sbastigliato e quattro anni più tardi il Misogallo. Nel 1790 inizia la redazione della Vita che completerà solo nel 1803, anno della sua morte.
Alfieri, La Vita, 1
Fin dall'estate innanzi, ch'io avea passato intero a Firenze, mi era, senza ch'io 'l volessi, occorsa più volte agli occhi una gentilissima e bella signora, che per esservi anch'essa forestiera e distinta, non era possibile di non vederla e osservarla; e più ancora impossibile, che osservata e veduta non piacesse ella sommamente a ciascuno.
|
Con tutto ciò, ancorché gran parte dei signori di Firenze, e tutti i forestieri di nascita da lei capitassero, io immerso negli studi e nella malinconia, ritroso e selvaggio per indole, e tanto più sempre intento a sfuggire tra il bel sesso quelle che piú aggradevoli e belle mi pareano, io perciò in quell'estate innanzi non mi feci punto introdurre nella di lei casa; ma nei teatri e spasseggi mi era accaduto di vederla spessissimo. L'impression prima me n'era rimasta negli occhi, e nella mente ad un tempo, piacevolissima. Un dolce focoso negli occhi nerissimi accoppiatosi (che raro adiviene) con candidissima pelle e biondi capelli, davano alla di lei bellezza un risalto, da cui difficile era di non rimanere colpito e conquiso. |
|
Età di anni venticinque; molta propensione alle bell'arti e alle lettere; indole d'oro; e, malgrado gli agi di cui abondava, penose e dispiacevoli circostanze domestiche, che poco la lasciavano essere, come il dovea, avventurata e contenta. Troppi pregi eran questi, per affrontarli.
|
In quell'autunno dunque sendomi da un mio conoscente proposto più volte d'introdurmivi, io credutomi forte abbastanza mi arrischiai di accostarmivi; né molto andò ch'io mi trovai quasi senza avvedermene preso. Avvistomi in capo a due mesi che la mia vera donna era quella, poiché invece di ritrovare in essa, come in tutte le volgari donne, un ostacolo alla gloria letteraria, un disturbo alle utili occupazioni, ed un rimpicciolimento direi di pensieri, io ci ritrovava e sprone e conforto ed esempio ad ogni bell'opera; io, conosciuto e apprezzato un sì raro tesoro, mi diedi allora perdutissimamente a lei. |
|
E non errai per certo, poiché più di dodici anni dopo, mentr'io sto scrivendo queste chiacchiere, entrato oramai nella sgradita stagione dei disinganni, vieppiù sempre di essa mi accendo quanto più vanno per legge di tempo scemando in lei quei non suoi pregi passeggieri della caduca bellezza.
Ma in lei si innalza, addolcisce, e migliorasi di giorno in giorno il mio animo; e ardirò dire e creder lo stesso di essa, la quale in me forse appoggia e corrobora il suo.
* Si tratta di Luisa Stolberg-Gedern, contessa d'Albany.
Commento alla Vita dell'Alfieri, 1
Dopo i fierissimi accidenti, dopo gli intoppi amorosi in Inghilterra, Alfieri incontra la duchessa d'Albany, la sua donna dalla impressione prima piacevolissima: "un dolce focoso negli occhi nerissimi accoppiatosi con candidissima pelle e biondi capelli".
All'inizio contrastato dalla presenza del marito, il potente e controverso Duca d'Albany, pretendente al trono di Inghilterra, e poi via via più sereno, questo incontro si configura come il punto d'arrivo della vita sentimentale dell'autore.
La giovane età della duchessa, la sua propensione agli studi d'arte e di lettere, faranno di questa quarta e ultima febbre l'occasione di un notevole mutamento esistenziale che conduce l'autore alla maturità personale ed artistica.
Ma il criterio di giudizio con il quale viene esaminata questa nuova esperienza è già in qualche modo commisurato alla vocazione letteraria. Mentre le donne conosciute fino a quel momento avevano fatto sprofondare l'Alfieri in una condizione psicologica di servitù, e la passione amorosa era servita per creare in lui una condizione di infamia, una specie di inferno in cui egli era manovrato come una marionetta dalle circostanze e dagli inevitabili equivoci che le caratterizzavano, in questo caso il "rimpicciolimento" non avviene, ma anzi l'intero corso delle sue memorie sembra cambiare strada disegnando dopo l'itinerario, ad un tempo avvincente e scabroso della giovinezza, dopo l'eccitazione dei tanti viaggi, un momento di riflessione dal quale l'autore protagonista sembra uscire mutato per se stesso e per il lettore.
Alfieri, La Vita, 2
Giunto in Londra, non trascorsero otto giorni, ch'ío cominciai a comprar dei cavalli; prima un di corsa, poi due di sella, poi un altro, poi sei da tiro, e successivamente essendomene o andati male o morti vari polledri, ricomprandone due per un che morisse, in tutto il marzo dell'anno '84, me ne trovai rimanere quattordici.
|
Questa rapidissima passione, che in me avea covato sotto cenere oramai quasi sei anni, mi si era per quella lunga privazione totale, o parziale, sì dispettosamente riaccesa nel cuore e nella fantasia, che recalcitrando contro gli ostacoli, e vedendo che di dieci compratine, cinque mi eran venuti meno in sì poco tempo, arrivai a quattordici; come pure a quattordici avea spinte le tragedie, non ne volendo da prima che sole dodici. Queste mi spossarono la mente; quelli la borsa; ma la divagazione dei molti cavalli mi restituì la salute e l'ardire di fare poi in appresso altre tragedie ed altre opere. Furono dunque benissimo spesi quei molti danari, poiché ricomprai anche con essi il mio impeto e brio, che a piedi languivano. E tanto più feci bene di buttar quei danari, poiché me li trovava aver sonanti. |
|
Dalla donazione in poi, avendo io vissuti i primi quasi tre anni con sordidezza, ed i tre ultimi con decente e moderata spesa; mi ritrovava allora una buona somma di risparmio, tutti i frutti dei vitalizi in Francia, cui non avea mai toccati. Quei quattordici amici me ne consumarono gran parte nel farsi comprare e trasferire in Italia; ed il rimanente poi me ne consumarono in cinque anni consecutivi nel farsi mantenere; che usciti una volta dalla loro isola, non vollero più morire nessuno, ed io affezionatomi ad essi non ne volli vender nessuno.
Incavallatomi dunque sì pomposamente, dolente nell'animo per la mia lontananza dalla sola motrice d'ogni mio savio ed alto operare, io non trattava né cercava mai nessuno; o me stava co' miei cavalli, o scrivendo lettere su lettere su lettere. In questo modo passai circa quattro mesi in Londra; né alle tragedie pensava altrimenti che se non l'avessi né pure ideate mai. Soltanto mi si affacciava spesso fra me e me quel bizzarro rapporto di numeri fra esse e le mie bestie; e ridendo mi dicea: "Tu ti sei guadagnato un cavallo per ogni tragedia"; pensando ai cavalli che a suono di sferza ci somministrano i nostri Orbili pedagogi, quando facciamo nelle scuole una qualche trista composizione (1).
1) Il cavallo era un castigo somministrato, a suon di frustate, ad uno scolaro montato a cavalluccio su un compagno da un pedagogo che ricordava il "plagosus" Orbilio Pompilio, maestro di Orazio (Epistole, II, 1, 2).
Commento alla Vita dell'Alfieri, 2
Nel 1784 Alfieri giunge in Inghilterra per acquistare cavalli. Apparentemente si tratta dell'occupazione tipica di un nobile alla moda, dedito a far sfilare i suoi palafreni per le vie di Parigi, Torino e Lione, e legittimamente compiaciuto di sentirne tessere le lodi da parte dei suoi conoscenti e amici.
Ma ormai l'avventuriero è diventato soprattutto il letterato che trova anche in questo caso l'occasione per buttarla in poesia, per argomentare un insolito confronto tra il numero dei suoi cavalli e quello delle sue tragedie.
A Londra, Alfieri non ricerca la vita mondana ma trascorre il suo tempo tra i quattordici cavalli e l'intensa attività epistolare con la duchessa D'Albany. Egli sta quasi dimenticando la letteratura, non scrive più tragedie, non compone nulla se non due sonetti, finché non decide di iniziare il viaggio di ritorno verso l'Italia.
Il viaggio è descritto in modi diversi: si passa dalla contemplazione rattristata della miserabile sorte degli animali "avviliti sudicissimi da non più si distinguere neppure il bel oro dei loro mantelli castani", visti poi nel momento dello sbarco in terra di Francia, "tratti per aria con una fune con le quattro zampe spenzolate", alla grande impresa del passaggio delle Alpi condotto con la rievocazione epica.
Piuttosto che un gentleman italiano alle prese con i suoi cavalli da passeggiata sembra di vedere Annibale nell'atto di condurre il suo formidabile esercito. L'autore fa assumere al suo protagonista l'aria di un grande stratega che ha ben disposto l'esercito in ordine di marcia.
L'impresa avventurosa, ma tutto sommato sportiva, dichiara nello stesso l'amore di Alfieri per la letteratura e per i suoi cavalli, considerati come amici e compagni di una grande impresa di cui vantarsi a ragione con il lettore.
Prima la salita dei colli alpini prevede i cavalli legati tre a tre guidati da un palafreniere, mentre Alfieri dirige dalla retroguardia la scalata presso due aiutanti da inviare dove ci fosse la necessità di un pronto intervento.
Ma nella discesa, la parte più insidiosa del percorso l'autore passa in prima fila per frenare l'impeto dei giovani cavalli che potrebbero rompere il passo e azzopparsi. Il commento finale all'impresa non può non richiamare il confronto tra la vita e la letteratura, sicché il passo alpino tra Lanslebourg e Novalessa viene descritto con la metafora delle Termopili, e la marcia in montagna come i cinque atti di una tragedia.
Alfieri, La Vita, 3
Cosí vissi io vergognosamente in un ozio vilissímo per mesi e mesi; smettendo ogni dí piú anche il leggere i soliti poeti, e insterilita anco affatto la vena delle rime; tal che in tutto il soggiorno di Londra non feci che un solo sonetto, e due poi al partire.
Avviatomi nell'aprile con quella numerosa carovana, venni a Calais, poi a Parigi di nuovo, poi per Lione e Torino mi restituii in Siena. Ma molto è piú facile e breve il dire per iscritto tal gita, che non l'eseguirla, con tante bestie.
Io provava ogni giorno, ad ogni passo, e disturbi e amarezze, che troppo mi avvelenavano il piacere che avrei avuto della mia cavalleria. Ora questo tossiva, or quello non volea mangiare: l'uno azzoppiva, all'altro si gonfiavan le gambe, all'altro si sgretolavan glí zoccoli, e che so io; egli era un ocean continuo di guai, ed io n'era il primo martire.
E quel passo di mare, per trasportarli di Douvres, vedermeli tutti come pecore in branco posti per zavorra della nave, avviliti, sudicissimi da non piú si distinguere neppure il bell'oro dei loro vistosi mantelli castagni; e tolte via alcune tavole che li facean da tetto, vederli poi in Calais, prima che si sbarcassero, servire i loro dossi di tavole ai grossolani marinai che camminavan sopra di loro come se non fossero stati vivi corpi, ma una vile continuazione di pavimento; e poi vederli tratti per aria da una fune con le quattro gambe spenzolate, e quindi calati nel mare, perché stante la marea non poteva la nave approdare sino alla susseguente mattina; e se non si sbarcavano così quella sera, conveniva lasciarli poi tutta la notte in quella sì scomoda positura imbarcati; in somma vi patii pene continue di morte. Ma pure tanta fu la sollecitudine, e l'antívedere, e il rímediare, e l'ostínatamente sempre badarci da me, che fra tante vicende, e pericoli, ed incommoducci, li condussi senza malanni importanti tutti salvi a buon porto.
Alfieri, La Vita, 4
Confesserò anche pel vero, che io passionatissimo su questo fatto, ci aveva anche posta una non meno stolta che stravagante vanità; talché quando in Amiens, in Parigi, in Lione, in Torino, ed altrove que' miei cavalli erano trovati belli dai conoscitori, io me ne rimpettiva e teneva come se li avessi fatti io. Ma la più ardua ed epica impresa mia con quella carovana fai il passo dell'Alpi fra Laneborgo [Lanslebourg] e la Novalesa.
Molta fatica durai nel ben ordinare ed eseguire la marcia loro, affinché non succedesse disgrazia nessuna a bestie sì grosse, e piuttosto gravi, in una strettezza e malagevolezza sì grande di quei rompicolli di strade. E siccome assai mi compiacqui nell'ordinarla, mi permetta anco il lettore ch'io mi compiaccia alquanto in descriverla. Chi non la vuole, la passi; e chi la vorrà pur leggere, badi un po' s'io meglio sapessi distribuire la marcia di quattordici bestie fra quelle Termopili, che non i cinque atti d'una tragedia.
Erano que' miei cavalli, attesa la lor giovinezza, e le mie cure paterne, e la moderata fatica, vivaci e briosi oltre modo; onde tanto più scabro riusciva il guidarli illesi per quelle scale. Io presi dunque in Laneborgo un uomo per ciascun cavallo, che lo guidasse a piedi per la briglia cortissimo.
Ad ogni tre cavalli, che l'uno accodato all'altro salivano il monte bel bello, coi loro uomini, ci avea interposto uno dei miei palafrenieri che cavalcando un muletto invigilava su i suoi tre che lo precedevano.
E così via via di tre in tre. In mezzo poi della marcia stava il maniscalco di Laneborgo con chiodi e martello, e ferri e scarpe posticce per rimediare ai piedi che si venissero a sferrare, che era il maggior pericolo in quei sassacci. Io poi, come capo dell'espedizione, veniva ultimo, cavalcando il più piccolo e il più leggiero de' miei cavalli, Frontino, e mi tenea alle due staffe due aiutanti di strada, pedoni sveltissimi, ch'io mandava dalla coda al mezzo o alla testa, portatori de' miei comandi.
Giunti in tal guisa felicissimamente in cima dei Monsenigi, quando poi fummo allo scendere in Italia, mossa in cui sempre i cavalli si sogliono rallegrare, e affrettare il passo, e sconsideratamente anco saltellare, io mutai di posto, e sceso di cavallo mi posi in testa di tutti, a piedi, scendendo ad oncia ad oncia; e per maggiormente anche ritardare la scesa, avea posti in testa i cavalli i piú gravi e più grossi; e gli aiutanti correano intanto su e giù per tenerli tutti insieme senza intervallo nessuno, altro che la dovuta distanza.
Con tutte queste diligenze mi si sferrarono nondimeno tre piedi a diversi cavalli, ma le disposizioni erano sì esatte, che immediatamente il maniscalco li poté rimediare, e tutti giunsero sani e salvi alla Novalesa, coi piedi in ottimo essere, e nessunissimo zoppo.
Alfieri Vittorio, Vita, 2006, Garzanti Libri