LE AVVENTURE DELL'AUTOBIOGRAFIA
quando la vita è un romanzo
L'AUTOBIOGRAFIA COME GENERE LETTERARIO
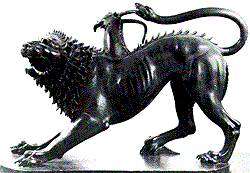
L'autobiografia è un racconto retrospettivo che un autore fa della propria esistenza, rievocando quei fatti che sono stati per lui particolarmente importanti e che hanno determinato lo sviluppo della propria personalità.
L'autore sembra prendere coscienza di sé attraverso i ricordi ed è protagonista delle vicende narrate. I tempi verbali per lo più sono al passato. Lo stile è generalmente "sostenuto" e vi sono poche inserzioni dialogiche, molte invece le riflessioni personali.
Il racconto può essere scritto in varie maniere: in versi (il poema The Prelude di William Wordsworth), in forma di saggio (Le Confessioni di Jean-Jacques Rousseau), in forma di opera teatrale (usata soprattutto in terapia e nello psicodramma alla Jacob Levi Moreno), in forma cinematografica (p.es. i documentari alla Jonas Mekas o Stan Brakhage e altro New American Cinema, ma anche diversi film cosiddetti di finzione), in forma di fumetto (come in Non mi sei mai piaciuto di Chester Brown). Generalmente però l'autobiografia è un racconto in prosa.
Da un lato l'autobiografia confina con la memorialistica (che a sua volta tende alla storiografia) e dall'altro lato confina con le opere di finzione, soprattutto con il romanzo, che soprattutto con il suo sviluppo nel XX secolo diventa una sorta di introspezione. In questo senso anche la pubblicazione di diari e lettere avvicinano al racconto dell'interiorità, che in senso generale viene detto autobiografico. Parentele concettuali si trovano ovviamente anche con la biografia e con l'agiografia.
Antichità
Il più antico esempio di autobiografia noto risale al X secolo a.C. ed è attribuito all'autore egizio delle Avventure di Sinuhe, che si diversifica dalle tradizionali biografie apologetiche di politici e di oratori presentate nell'antichità.
Ma è nella tradizione letteraria latino-cristiana che l'autobiografia affonda le proprie radici: sono infatti le Confessioni di Sant'Agostino, il primo grande modello di racconto autobiografico, reso tale dalla ricerca interiore e dai nuovi elementi psicologici apportati dal Cristianesimo. Nell'opera del vescovo di Ippona la narrazione autobiografica è legata ad una funzione eminentemente religiosa, in quanto il racconto personale si risolve in una ricostruzione della crescita spirituale dell'individuo: formula, questa, che verrà riproposta nel XVII e nel XVIII secolo dai capi di nuove correnti religiose come George Fox (Quaccheri) e John Wesley (Metodismo).
Un esempio significativo di autobiografia medievale è la Storia delle mie disgrazie di Pietro Abelardo, in origine una lettera a un amico.
Umanesimo, Rinascimento, Illuminismo
Con l'età dell'Umanesimo cominciano a diffondersi forme di scrittura autobiografica legate ad esperienze intellettuali eccezionali (come p.es. quella di Francesco Petrarca, raccontata nella raccolta di epistole Familiares e nel Secretum, o quella di Enea Silvio Piccolomini, autore del Diario di eventi memorabili) o alle tradizioni delle famiglie mercantili (legate alla stesura dei libri di ricordi) o all'attività degli artisti figurativi, che nei loro scritti autobiografici raccolgono riflessioni di carattere tecnico, appunti di lavoro, note sui rapporti con i committenti ecc. Ne è uno straordinario esempio la Vita di Benvenuto Cellini, scritta intorno al 1570 ma scoperta e pubblicata nel corso del XVIII secolo.
Che i "Libri di ricordi" e i "libri di famiglia" (fino ai conti domestici) confinino con l'autobiografia (come in Matteo Palmieri o Francesco Guicciardini o nel diario di Pontormo, Il libro mio) è più evidente che in altri casi, legati alla promozione di sé presso le corti o per la vita militare. D'altra parte questo è il periodo in cui si scoprono, traducono e ripresentano anche testi classici, dai Ricordi di Marco Aurelio alle Vite parallele di Plutarco (di per sé opere non autobiografiche, ma che aiutano a rendere fertile il terreno).
Lo sviluppo moderno dell'autobiografia e la sua affermazione come genere letterario è strettamente correlato all'affermarsi di un nuovo tipo di curiosità per la vita individuale, in cui sembrano riflettersi gli eventi, i fatti, le situazioni di un mondo in rapida trasformazione. Su questa strada cominciano a porsi vari scritti autobiografici del XVI secolo e del XVII secolo. Tra questi spiccano il De vita propria dello scienziato e filosofo italiano Girolamo Cardano, che rappresenta una delle più famose e intriganti autobiografie per la schiettezza che Cardano usa nel delineare i tratti peggiori del proprio carattere e la Vita scritta da lui medesimo di Gabriello Chiabrera.
In senso biografico vanno invece intese Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori scritte da Giorgio Vasari per descrivere la personalità di eccelse figure dell'arte e della pittura.
Per quanto riguarda la letteratura italiana, le prime autobiografie settecentesche si presentano come ambiziose giustificazioni dell'impegno culturale individuale, così come è esemplificato nella Vita di Pietro Giannone e nella Vita di G. B. Vico scritta da sé medesimo di Giambattista Vico.
Nel corso del secolo dei lumi il racconto delle vicende intellettuali si intreccia con una più accurata attenzione ai particolari della vita sociale contemporanea. Si impone una nuova curiosità per le avventure, che plasmano e costruiscono la stessa personalità dell'individuo. In questa direzione vanno le opere autobiografiche di Carlo Goldoni (Memorie, 1784-87), Giacomo Casanova (Storia della mia vita, 1822) e Lorenzo Da Ponte (Memorie scritte da esso, 1823-29).
Un'altra autobiografia fondamentale nella storia della letteratura italiana è la Vita scritta da esso di Vittorio Alfieri, pubblicata postuma nel 1806.
Ottocento
Nel corso del XIX secolo, il genere autobiografico si sviluppa ulteriormente, trasformandosi in indagine approfondita delle contraddizioni interiori della personalità, sulla scorta di una nuova aspirazione alla sincerità e all'autenticità di chiara matrice romantica. Il grande modello che si impone a tutta l'Europa è dato da Le confessioni di Jean-Jacques Rousseau, iniziate nel 1764 e pubblicate postume in due parti, nel 1782 e nel 1789.
L'opera di Rousseau, fondata sulla centralità dell'io e sul recupero memoriale, dà impulso a tutta una produzione autobiografica incentrata sulla ricostruzione del passato individuale, sul recupero dell'infanzia e sul tema della memoria.
In Francia vengono così pubblicate le Memorie d'oltretomba di Chateaubriand (1849-50), la Storia della mia vita di George Sand (1854-1855), ma anche la Vita di Henry Brulard di Stendhal (pubblicata nel 1890 ma scritta intorno al 1835-36); in Inghilterra Le confessioni di un mangiatore d'oppio (1821) di Thomas de Quincey, mentre in Russia Tolstoj dà alle stampe la trilogia Infanzia, Adolescenza, Giovinezza (1852-56).
Casi di memorie interessanti sono anche quelle degli ex-schiavi Frederick Douglass, il cui Racconto della vita di Frederick Douglass, uno schiavo americano è pubblicato nel 1845, e Harriet Ann Jacobs, la cui Vita di una ragazza schiava uscì per intero nel 1861. Anche Benjamin Franklin scrisse un'Autobiografia (1770-90, la cui vicenda editoriale complessa comincia a stabilizzarsi con le prime edizioni del nuovo secolo).
Contemporaneamente, la memorialistica italiana produce opere di carattere essenzialmente politico-ideologico, influenzate dal processo risorgimentale: Le mie prigioni di Silvio Pellico (1832), I miei ricordi di Massimo d'Azeglio (pubblicati postumi nel 1867), Le ricordanze della mia vita di Luigi Settembrini, pubblicate postume nel 1879-80 e, ormai nel nuovo secolo, Le faville del maglio di Gabriele D'Annunzio (pubblicate nel 1911-14 ma di impianto ottocentesco).
XX e XXI secolo
Nel corso del Novecento la tradizione autobiografica tende a confondersi con la forma romanzesca, e l'esperienza individuale pare dissolversi nella fiction, dando così origine al romanzo autobiografico.
Grandi testi novecenteschi tra autobiografia e romanzo sono Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, pubblicato tra il 1913 e il 1927, Dedalus di James Joyce (1916), La coscienza di Zeno di Italo Svevo (1923) e L'uomo senza qualità di Robert Musil, (1930-1943), senza dimenticare alcune autobiografie dall'impianto più classico, segnate però da un forte impegno politico e civile: ad esempio Le parole (1964) di Jean-Paul Sartre e Memorie d'una ragazza perbene (1958) di Simone de Beauvoir, primo capitolo di un ciclo autobiografico che comprende anche L'età forte (1960), La forza delle cose (1963) e A conti fatti (1972).
Ancora prima si dovrebbe notare il Contributo alla critica di me stesso di Benedetto Croce (1915), che Gianfranco Contini considerava, pur con maggiore ironia, fatto sull'esempio vichiano e Il pellegrino di Roma di Ernesto Buonaiuti (1945).
Un'interessante sintesi di scrittura autobiografica è di psicoanalisi autoanalitica è il libro postumo di Carl Gustav Jung, Ricordi, sogni, riflessioni, scritto a quattro mani con l'allieva Aniela Jaffè.
Per stile si fanno notare W o il ricordo d'infanzia (1975) di Georges Perec (che alterna un capitolo di finzione con uno autobiografico) e Roland Barthes attraverso Roland Barthes (1975) che il critico francese dedica a se stesso e al proprio metodo.
Con lo sviluppo della psicologia di relazione e comunicazione, l'autobiografia è diventata uno strumento per l'affermazione, ricerca e cura dell'identità, sia a livello del paziente (che viene incoraggiato attraverso la narrazione a ricostruire e rivelare la propria storia intima), sia a livello del medico (in particolare l'analista che junghianamente considera "poetica" la base della mente umana).
L'autobiografia è utilizzata anche per lo storytelling, una tecnica attraverso la quale vengono narrate le organizzazioni (base per processi di motivazione e partecipazione collettiva all'azienda).
Per chiudere la rassegna si deve evidenziare lo sviluppo della letteratura più recente nella direzione del mescolamento tra vicende personali e riflessione sulla narrazione delle stesse (in scrittori come Paul Auster, Don DeLillo, Philip Roth, Milan Kundera o J. M. Coetzee) e al contempo l'accesso aperto alla narrazione di sé offerto dalla crescita incontrollata del fenomeno dei blog.