LA TRAGEDIA DELLE
BACCANTI
|
|
BACCANTI
(BAKCAI)
ANALISI
1 - 2 - 3
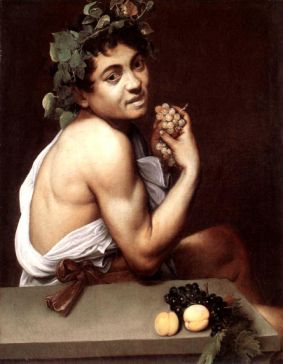
Dioniso è la rivendicazione di una libertà individualistica che si sviluppa seguendo due direzioni sociali: la prima di natura economica, la seconda di natura ideologica.
Egli infatti si pone come imprenditore privato nel settore vitivinicolo, ed è capace di trarre profitti dalla sua attività usando mezzi leciti e illeciti.
In forza di questa attività egli rivendica un potere politico sul territorio, in ambito cittadino, mostrando altresì di disporre di certe doti intellettuali che gli permettono di elaborare una filosofia di vita alternativa a quella dominante.
Dioniso infatti critica la politica ateniese, mostrando che le soddisfazioni personali non possono essere raggiunte sotto la democrazia, ma solo sotto l'anarchia, in maniera del tutto individualistica, optando per soluzioni evasive, asociali, dirompenti (l'estasi viene presentata come un aspetto più significativo dell'opera d'arte, della cultura in generale).
Il dionisismo attacca il tessuto sociale nel suo insieme, colpendolo nella parte più debole: le donne, gli anziani, i giovani. E' l'apologia dell'istintivismo. In sé il culto bacchico non aveva nulla di "religioso", anzi era caratterizzato da truculenti episodi di delirio collettivo, di sbranamenti e perfino di cannibalismo.
Più volte nelle Baccanti egli tenta di dimostrare che in presenza di una forte intelligenza, all'uomo che dimostra di possederla, dovrebbe essere concessa molta più libertà che a un individuo normodotato, nella convinzione che anche nel caso in cui egli dovesse abusarne, in nome della stessa intelligenza saprebbe sicuramente porvi rimedio.
In tal senso Dioniso predica uno stile di vita per un'élite, cioè solo per coloro che si sentono capaci di tornare alla normalità dopo essersi concessi alla follia, alla sregolatezza tipica di quei momenti in cui si abusa di alcool, droghe, sesso, musica e balli scatenati.
Egli giustifica questo suo comportamento non solo in nome della propria intelligenza o in nome del proprio successo economico, ma anche facendo leva sul fatto d'aver vissuto un'infanzia travagliata, in cui il rapporto col padre è stato a dir poco controverso. Zeus (dietro cui ovviamente si poteva nascondere nella vita reale o uno stupratore o un irresponsabile), praticamente lo abbandonò o non lo riconobbe come figlio.
Dioniso è un figlio naturale o illegittimo d'un padre violento e la madre Selene non fu in grado di reggere alla difficoltà della sua crescita, essendo essa stessa vittima della violenza del marito (o della moglie legittima del marito). Sicché il figlio ha dovuto essere allevato da parenti, che lo fecero senza particolari entusiasmi, tant'è che le di lui sorelle misconoscono l'identità del padre.
Un padre libertino che evidentemente doveva essere anche "potente", altrimenti Dioniso, divenuto adulto, non avrebbe continuamente rivendicato un'ascendenza dinastica, naturale e legale, la sola che nella Grecia di allora permetteva a un uomo il successo politico-istituzionale. Una stirpe aristocratica era tutto e non a caso Dioniso rimprovera a Penteo d'aver avuto Echione come padre, un "fiero mostro, non umano, sanguinario".
Dioniso ha vissuto un'infanzia molto difficile, in cui ha appreso anticipatamente i rischi e forse i piaceri connessi all'attività sessuale. Divenuto adulto, non è poi stato capace di emanciparsi completamente dai drammi del proprio passato.
Anzi, ad un certo punto ha fatto del proprio dramma uno stile di vita da proporre agli altri, sfruttando commercialmente un prodotto della natura: la vite, con cui approfittare delle debolezze umane, sino al punto da rivendicare un certo potere politico o riconoscimento sociale, pubblico, che il destino gli aveva negato.
Il Dioniso maturo è un uomo senza scrupoli, non molto diverso dal padre Zeus, un uomo che s'è fatto da sé, come uno dei tanti mercanti dell'epoca, un "emigrante parvenu", polemico nei confronti della classe nobiliare, la quale comanda non per virtù propria ma solo per tradizione; è un uomo rimasto moralmente infantile, incapace di guardare le cose in maniera distaccata, e quindi impotente di fronte ai forti risentimenti che dominano la sua coscienza e che lo porteranno a divulgare i riti orgiastici, utilizzati anche per impedire a qualcuno di conoscere l'identità del proprio padre.
Dioniso non ha un progetto alternativo, sociale, alle contraddizioni del suo tempo; egli inganna Penteo proponendo l'uguaglianza sociale contro la discriminazione di censo, di stirpe, di etnia..., che lo stesso Penteo vuol far passare come tradizione consolidata, fonte di ordine e razionalità. Ma si tratta di un inganno soggettivo contro uno oggettivo, l'antitesi dell'estetica informale all'etica formalista.
In nome dell'opposizione spontaneistica si invoca la separazione dei sessi: la città viene abbandonata dalle donne refrattarie alla sottomissione patriarcale. Poi s'impone la scompaginazione del palazzo reale, i cui marmi si crepano, mentre sulla tomba di Semele riprende con vigore la fiamma di Zeus (Semele verrà poi tolta dall'Ade da Dioniso e portata sull'Olimpo).
Ai confini della città le Baccanti fanno miracolosamente scaturire acqua, vino, latte e miele dalla terra: i beni sono finalmente a disposizione di tutti e gli esseri umani si riconciliano con la natura.
Il vino infatti è vissuto come "stupefacente": con l'aggiunta di sostanze allucinogene è in grado di eccitare i sensi fino al punto d'indurre a credere di poter compiere cose mirabolanti, umanamente impossibili. Non a caso Euripide preferisce Dioniso a Demetra, la quale regala ai mortali dei "frutti secchi", fatica, disagi, sofferenze, mentre quello invece regala oblio, sonno, piaceri.
La nuova comunità bacchica vuole la natura tutta per sé e non sopporta i pastori rivali, con le loro greggi, che vengono quindi smembrate, né tollera gli agricoltori, coi loro campi coltivati, che vengono inevitabilmente saccheggiati: la proprietà fondiaria diventa improvvisamente collettiva e chi, armato, vi si oppone, viene messo in fuga dalla forza corale di donne ben organizzate. Le donne ebbre di vino sono come assatanate, in grado di combattere come uomini, incuranti del pericolo di morire.
Penteo non si rassegna e passa al contrattacco. Egli rappresenta l'autoritarismo tradizionale, formalista, autoritario ma in decadenza morale, perché privo di veri valori. Vuole impedire l'abuso del vino con la forza e non si rende conto che la cittadinanza va lasciata libera di scegliere, dopo averla informata dei rischi e dei pericoli.
Ovviamente Euripide, che qui prende le difese di Dioniso, accentua di Penteo gli aspetti negativi, ne fa una caricatura, mostrando che la morale pubblica era soltanto una falsità, un'ipocrisia. Persino la madre si ribella al figlio. In un colpo solo Euripide ha messo in luce le profonde antinomie non solo tra aristocrazia e borghesia ma anche tra uomo e donna. La borghesia, per imporsi sulla nobiltà d'origine, profondamente patriarcale nei rapporti anche privati, fa leva sulle esigenze di emancipazione delle donne più coraggiose, le quali però recuperano un proprio protagonismo femminile in forme prive di mediazione sociale, cioè in chiave ferina, belluina.
Penteo rifiuta il consiglio del nunzio di approvare l'uso del vino e con esso il piacere sessuale, che dà senso a una vita priva di gioie. Decide anzi di agire di persona, ma, rappresentando solo la forza, finisce col cadere nelle astuzie di Dioniso. Il quale infatti lo convince a travestirsi come una baccante, al fine di poter spiare la madre e le altre donne mentre praticano le orge sui monti. Dioniso assomiglia a Ulisse e la sua vittima non è molto diversa da Polifemo, benché qui s'intreccino aspetti voyeuristici ed erotomani del tutto assenti in Omero.
Da notare che Dioniso non aveva usato lo strumento delle orge come provocazione per dimostrare l'inconsistenza dell'etica pubblica. Egli in realtà aveva fatto del vino la sua ragione economica di vita. Le conseguenze connesse all'uso della nuova droga gli interessavano relativamente, in quanto lui di persona non è mai protagonista di alcuna sfrenatezza sessuale. A lui interessa teorizzare il principio del piacere edonistico o eudemonistico, che gli serve per accrescere il potere economico e successivamente per rivendicare anche quello politico.
Egli, per quello che fa, ha bisogno di darsi delle giustificazioni "morali", proprio allo scopo di dimostrare che il suo stile di vita non è peggiore di quello in cui i poteri costituiti si rispecchiano e che essi stessi impongono. "Sdegno i sofismi - dice - [cioè le ipocrisie della morale ambigua, doppia], ché altre più nobili mete... danno felicità: notte e dì la pietà d'una santissima vita, che onora Dio e le illegittime norme le getta via". Qui è l'opposizione di una morale interiore, individualistica, che usa le armi della licenza sessuale, contro una prepotenza politica.
Da notare, di rilievo, che per tutta la tragedia Dioniso non associa mai il diritto di fare business col proprio vino col diritto di divulgare un proprio stile di vita. Egli chiede soltanto che un passatempo innocuo come quello di ascoltare musica, di ballare e cantare, bevendo vino, abbia libertà di accesso tra i culti della città. Presenta la gaiezza o la frivolezza, la licenza dei sensi, come la cosa più ingenua di questo mondo.
E' in realtà lo scontro di due ateismi: quello ufficiale, che mistifica un contenuto classista e antagonista (l'origine aristocratica) attraverso una forma di religiosità convenzionale; e quello eversivo, che fa presa su vari ceti popolari, privi di ascendenze nobiliari, disposti a opporsi anche con la forza ai poteri costituiti.
Dioniso è deciso ma deve muoversi con cautela: vuole sì il potere ma deve fare anche un calcolo delle forze in campo. Le sue motivazioni a favore del recupero originario del rapporto uomo-natura devono apparire sincere, convincenti, e non come pretesto per rivendicare un potere personale, altrimenti non solo non otterrebbero consensi ma verrebbero anche immediatamente represse, isolate o censurate.
La stessa descrizione - un vero e proprio artificio letterario - dei prodigi fantastici di cui si sono fatte protagoniste le Menadi ha più che altro uno scopo pubblicitario: quello in sostanza di dimostrare che bere vino fa bene alla salute, alla vita sessuale, alla vita in generale. Euripide qui per la prima volta usa lo strumento dello spot per convincere il pubblico di un prodotto industriale e dietro questa alchimia commerciale lascia passare una filosofia di vita incentrata sull'arbitrio personale, o meglio sull'illusione di poter esercitare una libertà incondizionata.
Per dimostrare la giustezza del proprio operato, la superiorità del proprio ateismo, Dioniso accusa Echione, padre di Penteo, uno dei capostipiti della nobiltà tebana (gli Sparti), d'essere stato un "terragno", un "fiero mostro", un "gigante avverso ai numi"... Insomma il vero "ateo", in senso spregiativo, sarebbe stato lui. Il nuovo ateismo, invece, quello gaudente, sarebbe assolutamente tollerante, aperto alla diversità, e soprattutto più coerente coi propri ideali.
E il re Penteo, che non vuole rinunciare al proprio trono e che si sente incarnazione della virilità, del potere maschilista, autoritario, cade nella sofisticata trappola, scopre il suo lato debole e si lascia travestire da donna; lui, centro della città, si fa condurre in montagna, vestito da baccante, per vedere ciò che non è permesso ai non iniziati.
Le donne, sovraeccitate da sostanze allucinogene, scambiano il re per un animale selvatico, sradicano con forza erculea l'albero ove s'è nascosto, lo dilaniano come se nulla fosse e la madre di lui, Agave, porta a Tebe la testa del figlio, convinta sia quella di un leone. Quando lo uccide ha sembianze del tutto sconvolte, tipiche di chi non si rende conto di quel che sta facendo: bava alla bocca, pupille roteanti...
Non poteva che essere linciato un sovrano così contraddittorio, nella cui vita e nella vita del regno che comandava il contenuto non corrispondeva alla forma (p.es. egli era apparentemente religioso ma nella sostanza si comportava come un ateo, e nella tragedia il concetto di "ateismo" viene visto negativamente, come una forma di sopruso, ma in realtà viene usato strumentalmente per dimostrare la doppiezza del potere costituito; per Euripide vale il principio Dio=Natura). Ora s'impone una nuova coerenza, ma a un livello etico molto più basso, quello appunto individualistico (de jure e de facto) del ceto mercantile, dove alla vita mondana, gaudente, si associa l'affarismo senza scrupoli.
L'Agave regicida vuole il potere politico, il trionfo degli oppressi. La rivoluzione sembra essere compiuta, ma il vero vincitore è Dioniso. Agave infatti si pente dell'esito terroristico dell'insurrezione. Non è radicale come dovrebbe essere e Dioniso ne approfitta per sostituirsi al vecchio e al nuovo potere.
Perché si tratta di una tragedia? Semplicemente perché una volta concesso spazio all'arbitrio (quello di Dioniso che si serve del vino drogato per fare affari e acquisire poteri), è molto difficile tornare indietro, di sicuro è impossibile farlo con gli strumenti tradizionali.
Tiresia e Cadmo avevano proposto una soluzione di compromesso, consapevoli dei limiti di una società divisa in classi contrapposte, e speravano che l'accettazione dei riti bacchici avrebbe smorzato le tensioni sociali. Cercano di convincere Penteo ad accettarli con una sorta di motivazione diplomatica: i riti dionisiaci non possono sconvolgere i costumi della città; se essi non fanno bene - dicono come se si trattasse di una nuova religione -, non fanno neppure male. Insomma, "non possiamo non dirci pagani", e in ogni caso sono riti per adulti: si possono accettare liberamente, senza alcuna costrizione.
Penteo invece temeva che una concessione del genere si sarebbe presto trasformata in un fiume in piena. E infatti non ebbe torto. Solo che il potere politico, da lui rappresentato, riflettendo meramente gli antagonismi sociali, non poteva avere in sé le soluzioni per risolverli.
Tebe viene colpita da un tragico destino. Nel momento in cui prende consapevolezza dei propri punti deboli, non ha la forza per reagire positivamente. Cadmo addirittura sembra far capire di non aver voluto la morte di Penteo semplicemente perché ora teme, e a ragione, d'essere espulso dalla città e che la dinastia tebana finisca con lui.
Comprende tardi la spietatezza di Dioniso, il quale non è in grado di offrire alcuna vera soluzione alle contraddizioni della società: egli è soltanto la risposta più negativa alle mancate soluzioni. Egli non vuole né una vera democrazia né un ateismo umanistico, ma che sulla base di una religione naturalistica, priva di dogmi e di istituzioni, si possa creare uno stile di vita favorevole ai suoi interessi privati.
Non si può tergiversare con lui, non si può attribuirgli qualche merito, anche perché Dioniso viene a chiedere conto, senza alcuna pietà, senza alcuna trattativa, delle debolezze altrui, fossero anche quelle dei suoi stessi discepoli. Promette l'uguaglianza ma solo per schiavizzare peggio di prima. Non c'è in lui alcuna misteriosa speranza di salvezza, ma solo inganno e follia. E' falsa la sua pretesa di mostrarsi terribile coi potenti e mite con gli umili. In realtà la sua ambizione è quella di dominare e, in tal senso, non si sente neppure in dovere d'essere riconoscente con le donne che l'avevano aiutato a conquistare il potere.
