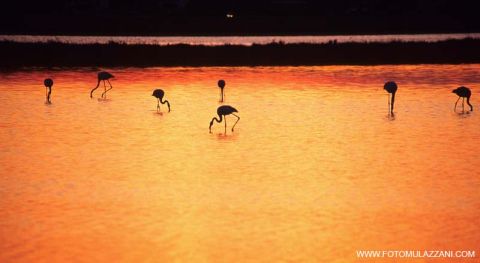
Nella "Corrente"
|
|
Nel corso degli anni ’30, una parte di artisti figurativi si votò ad un nuovo tipo di espressione, cercando di confluire nell’alveo della modernità intellettuale europea. Birolli, Guttuso, Cassinari, Sassu, Migneco, Morlotti, Vedova e non pochi altri cercarono di svincolarsi dalle accademie e di dare un nuovo respiro, un respiro internazionale, alla cultura italiana. Questi artisti si riunirono in un movimento denominato “Corrente” e, grazie ad Ernesto Treccani, diedero vita alla rivista omonima, la cui prima uscita avvenne nel 1938. Per la verità, l’impressione intorno a questo movimento ha due volti: il primo, e più palese, è quello di ringiovanimento dell’attività artistica e dell’impegno intellettuale, il secondo riguarda, invece, un'ansia di correre verso nuovi lidi, peraltro già esplorati da altri. Gli artisti di “Corrente” non volevano più avere a che fare con il neoclassicismo novecentesco, il cui culmine è probabilmente rappresentato da De Chirico e da Carrà, con le loro ostentazioni classiche. Questo neoclassicismo non si riferiva certo a quello tradizionale, da un punto di vista figurativo, ma del tradizionale manteneva l’ispirazione di fondo e la vocazione aristocratica, distacca dal reale ed impregnata di ideale. A salvare la questione classica, e dunque a salvare in qualche modo la maestria italiana nel trattare cose superiori, erano intervenuti anche gli studi di Freud sul mondo occulto, irrazionale che, secondo il noto studioso, condizionava quello reale in maniera significativa. Il classicismo poteva perciò essere visto anche nella veste di impronta psicologica che, con franchezza, “Corrente” non intendeva più celebrare. C’era, negli anni ’30, un’euforia fisica in tutto il mondo (euforia dovuta alla moltiplicazione produttiva dopo i disastri della Prima guerra mondiale e, conseguentemente, alla paura di non riuscire a produrre più) che non dava occasioni riflessive particolari. L’anima del classicismo non poteva essere abbandonata con tanta disinvoltura, per quanto dietro questo abbandono si nascondessero principi da perseguire e onorare, sebbene con non poca sudditanza: i principi erano legati all’opposizione al regime fascista, all’agganciamento con la tradizione europea rappresentata dall’espressionismo tedesco, dalle rivoluzioni proposte da Van Gogh, Gauguin, Ensor, Picasso, al vagheggiamento di un’indipendenza ideologica. Non si teneva conto delle situazioni particolari per cui erano nati certi fenomeni artistici, né della lunga militanza italiana con l’arte, con risultati relativi formalmente e culturalmente in testa per secoli alla tensione culturale generale. L’Italia, accettando quella Europa, di fatto abdicava al suo ruolo di protagonista e si accontentava di divenire una comparsa sulla scena dell’arte, quando ne era stata maestra indiscussa per lungo tempo. Gli artisti che sposarono la causa di “Corrente” cercarono, in realtà, anche se non sempre si capisce con quale convinzione, cercarono una via europea di stampo italiano, riversando nelle loro opere un impegno concettuale non proprio sottomesso ai modelli cui si ispiravano. Il nostro gusto, la nostra finezza estetica, ed una certa esperienza etica, consentirono avventure artistiche di rilievo, anche se non di grandissimo respiro, come esistesse una sorta di pudore, di riservatezza nell’accettazione del nuovo linguaggio europeo, un linguaggio fatto di declamazioni e di forzature che strideva con la grazia espressiva italiana. Nel 1940 il regime fascista fece chiudere la rivista. “Corrente” continuò tuttavia a vivere per qualche tempo grazie alla “Bottega di Corrente” in via della Spiga a Milano. Era diretta da un grande appassionato d’arte, Duilio Morosini. I molti artisti che confluirono via via nel movimento, si davano contemporaneamente da fare anche in altre direzioni, partecipando, molti di loro, alle varie manifestazioni di regime, fra cui il “Premio Bergamo”, dove il ministro Bottai chiudeva un occhio sulla disomogeneità delle opere rispetto ai dettami fascisti. Nel complesso, tutte queste esibizioni ortodosse e meno ortodosse rispondevano ad una mentalità di contenimento dell’eversione intellettuale e quindi della creazione relativa, accontentandosi di cenni rivoluzionari, rispetto all’arte italiana convenzionale, e di qualche azzardo più o meno mascherato. Per ovviare alla mancanza di originalità incisiva – in un mondo nel quale, peraltro, arte e cultura contavano sempre meno – gli artisti del tempo (e dunque non solo quelli di “Corrente”) rispolverarono l’abilità tecnica – con esiti a volte grandiosi – e si cimentarono nel simbolismo (pescando anche nella storia, dagli Etruschi ad esempio) con cura ed attenzione generalmente superiori a quelle dei loro compagni di viaggio europei. La nostra tensione intellettuale rimase come soffocata dalla constatazione di un passo indietro italiano nei rapporti con il mondo. Magari un passo indietro momentaneo, tuttavia doloroso. |
Dello stesso autore:
it.wikipedia.org/wiki/Corrente_(rivista)
Testi