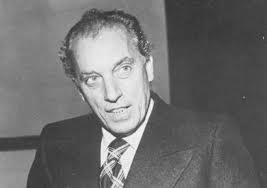
Il male oscuro di Giuseppe Berto
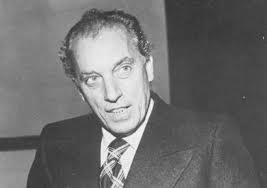
|
|
La redazione de “Il male oscuro” fu una specie di percorso terapeutico da parte di Giuseppe Berto (1914-1978) verso la definitiva liberazione della nevrosi che lo angustiava da anni. Nel libro, l’autore ripercorre il suo calvario con crescente lucidità e incalzante coraggio. Berto usciva, fra l’altro, dal litigio con Alberto Moravia: i due non si stimavano, soprattutto Moravia era drastico, in senso negativo, nei giudizi sulla prosa dell’altro. Ma la vera ragione dello scontro fra i due (eravamo nel 1963) fu l’appoggio dato dallo scrittore romano a Dacia Maraini e al suo romanzo “L’età del malessere” in vista del premio Formentor (che poi le fu dato). Fra Dacia Maraini e Moravia esisteva un legame amoroso e solo per questo, secondo Berto (e secondo molti altri), Moravia premeva per l’assegnazione del premio alla sua protetta, a prescindere dai valori letterari. Che Giuseppe Berto fosse rimasto male dell’atteggiamento di Moravia, allora molto potente, non è provato e d’altra parte, in caso d’indifferenza sostanziale, avremmo il conforto della coerenza del personaggio, lontano dai riflettori, tutto concentrato su se stesso, sebbene con qualche riserva sul proprio valore e sul valore dell’uomo in generale. Berto fu affiancato ai neorealisti, avendo licenziato, fra l’altro, alcuni anni prima, appena dopo la Seconda guerra mondiale, il suo primo grande successo “Il cielo è rosso”, edito da Longanesi. Il titolo si deve a Leo Longanesi in persona che cambiò così quello originale (“La perduta gente”). Si dice che il nostro autore avesse appreso del nuovo titolo direttamente in libreria. Leo Longanesi aveva avuto un grande intuito. “Il cielo è rosso” fu allora una specie di best seller. Narra di giovani sbandati, abbandonati a se stessi, che imparano a stimarsi e a collaborare fra loro. Non è attuale, ma è molto interessante, è quasi uno studio antropologico, svolto con felice piglio giornalistico. Centrale, nell’opera di Berto, è ovviamente il suo “male oscuro”. Nello scritto omonimo egli ci trasmette la sua angoscia apparentemente inspiegabile, suggestionandoci sino a farci dire che in fondo tutti quanti ne soffriamo perché legata alla radice del nostro essere. Noi non sappiamo essere così come ci suggerisce la ragione, siamo essere incompleti, per metà in un modo e per metà nell’altro, acquiescenti e ribelli, rassegnati e reattivi con armi spuntate (forse). La battaglia è intorno al come fare per essere a dovere, secondo principi umani che il mondo non riconosce. Giuseppe Berto ebbe un’infanzia difficile, in perenne lotta con il padre che lo voleva sottomesso per il suo bene (ovviamente secondo l’ottica paterna). Per questo, il nostro scrittore, non appena fu in grado di farlo, lasciò la famiglia e partecipò alla Guerra d’Abissina, quattro anni dal 1935 al 1939, ricavandoci una medaglia d’argento ed una di bronzo (ne fu lieto, specialmente nei momenti di magra, per la pensione che ne derivava). Poi si arruolò volontario nella MVSN (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), una formazione di stretta osservanza fascista e, dopo la sconfitta dell’Asse a El Alamein, nelle successive e sfortunate battaglie africane contro gli Alleati, fu fatto prigioniero, il 13 maggio del 1943, e internato in un campo di prigionia in Texas, dove, fra gli altri, conobbe Alberto Burri, futuro artista concettuale. Fu la prigionia americana a creare Berto scrittore, ad invogliarlo a scrivere non in modo frammentario come aveva fatto sinora. Si vuole che lo stile giornalistico l’avesse appreso dagli americani leggendo, fra gli altri, Hemingway (che più tardi lodò i suoi scritti), ma la cosa non risulta in senso determinante nei suoi, poi, numerosi libri. Già all’esordio, il lungo racconto “La colonna Feletti” (dove si narra di un fatto vero che aveva visto la morte di alcuni suoi compagni), del 1940, la prosa è semplice, immediata e concreta. Berto è sempre andato alla ricerca delle ragioni dei fatti, ritenendosi, forse, non del tutto adatto a comprendere la realtà. Anche la sua “Guerra in camicia nera” sembra a prima vista una narrazione pro regime fascista, ma poi subentra una sottile critica al regime stesso che porta sostanzialmente l’autore a respingerne la fisicità, l’irrazionalità, senza per questo condannarlo del tutto. La questione di Giuseppe Berto fascista va considerata alla luce di una sicurezza che il regime in qualche modo garantiva. Il fascismo era un punto di riferimento, ma riferimento sarebbe potuto essere un altro regime che avesse le medesime credenziali. Un certo opportunismo non va disgiunto dalla scelta di Berto di legarsi mani e piedi alla dittatura di Mussolini, così come tanti altri giovani della sua generazione. Ma tutto questo senza metterci necessariamente la testa. Il regime esigeva obbedienza, non convinzione e dava in cambio la sopravvivenza. Tutta una questione soprattutto materiale. Per un malato di male oscuro da sempre, la caduta del fascismo fu un trauma psicologico dal quale il nostro scrittore uscì solo affrontandolo questo male, per esorcizzarlo. Non ci riuscì, ma sicuramente la sua lotta è un documento straordinario sul buio nel quale si muove l’umanità e sull’illusione di luce in fondo ad un tunnel che si arriva addirittura a pensare come inesistente, frutto d’illusione, a sua volta conseguenza di un incubo trasformato segretamente in sogno per un soprassalto, fortunato, di speranza estrema. |
Dello stesso autore:
Testi di Giuseppe Berto