|
|
IL DIRITTO ALLA
CULTURA
|
Perché il copyright non ha più senso?
I - II
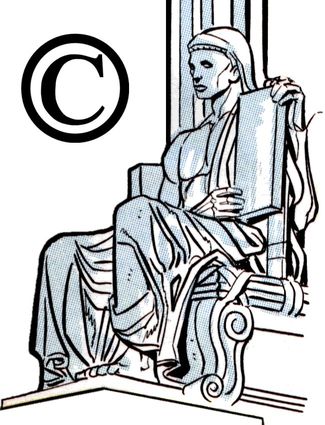
Il copyright oggi è la principale catena che impedisce la diffusione della cultura. È la prima fonte economica degli editori, dei loro rappresentanti commerciali, degli enti che li tutelano (come p. es. la Siae) e degli avvocati che rivendicano i loro diritti nei tribunali.
Quanto agli autori (artisti, letterati, inventori, ecc.), solo i più significativi ricevono qualcosa da parte degli enti presso cui sono iscritti, versando una quota annuale: nessun ente ha forze sufficienti per controllare le violazioni del copyright nei confronti di tutti gli iscritti (la sola Siae ne ha oltre 80.000). Un autore dovrebbe accorgersi da solo che qualcuno sta utilizzando, abusivamente, la sua opera d'ingegno, e procedere quindi per le vie legali, ma, così facendo - e lo può fare - dimostrerebbe di non avere alcun bisogno d'essere iscritto a un ente specifico.
La catena del copyright ha cominciato a essere spezzata da quando sono nati i supporti elettrico-meccanici per la riproduzione delle opere: fotocopiatori e registratori, sino a quelli più propriamente informatici e telematici, come gli scanner e le reti digitali. Prima di questi supporti - che hanno reso possibile una grande diffusione di testi cartacei, brani musicali, film e software, senza pagarne i diritti d'autore - si poteva copiare abusivamente qualcosa solo se si aveva una certa abilità artistica: sono sempre esistiti i falsari e i plagiatori, cioè coloro che utilizzano l'ingegno altrui senza riconoscerne la paternità. La storia è piena di abili falsari e di approfittatori senza scrupoli, soprattutto là dove da una certa opera d'ingegno si possono ricavare profitti economici, e anche di utilizzatori che, in buona fede o per un fine non strettamente economico, si sono avvalsi di opere altrui senza citare la fonte (basta vedere cos'hanno fatto i due evangelisti, Luca e Matteo, nei confronti di Marco).
D'altra parte tutti sanno che avere talento è una cosa, essere dei geni un'altra. Se non vivessimo in società così fortemente antagonistiche, si ammetterebbero più facilmente i propri limiti e si riconoscerebbero altrettanto facilmente i meriti altrui. Anzi, forse ci si vanterebbe d'essere seguaci di questo o quel genio, diffondendone il pensiero il più possibile, nella convinzione di fare il bene dell'umanità. In questa maniera ci potrebbe essere, al massimo, una gara nella libera diffusione delle opere d'ingegno: non basta infatti avere delle qualità per essere apprezzati, ci vuole anche una certa organizzazione per farle conoscere al grande pubblico, e questa non può essere delegata a enti monopolistici, che sicuramente non fanno gli interessi della democrazia.
Viceversa, nella nostra era digitale, grazie alla quale - per merito di qualche genio dell'informatica - è possibile riprodurre facilmente testi, musiche, film e software, chi detiene il monopolio della tutela del copyright fa di tutto per impedire la diffusione di questi strumenti. E la motivazione (ovviamente formale, poiché quella reale evitano di dirla) è sempre la stessa: gli autori e i loro legittimi eredi vanno difesi. Dalla morte degli autori devono passare settant'anni prima che si possano utilizzare liberamente le loro opere. Quindi praticamente, nel corso di questo periodo, soltanto chi può permetterselo potrebbe beneficiare della cultura sottesa alle loro opere, ovvero soltanto chi sottostà al monopolio dell'ente che si è incaricato di distribuirle materialmente. La distribuzione ha un costo e l'utente finale deve pagarlo.
Il problema è che questi enti impediscono agli acquirenti dei diritti patrimoniali (che sono i diritti di accedere a un'opera d'ingegno), di poterli ridistribuire. Secondo l'ideologia affaristica di questi enti, la cultura non può essere ridistribuita (tanto meno gratuitamente), in quanto può essere soltanto pagata. Quindi deve restare patrimonio di una certa categoria di persone. È una cultura di classe. (1)
Questi enti infatti sono privati, tutelati dallo Stato nelle loro esigenze affaristiche. La cultura non viene diffusa dallo Stato e non può essere neppure diffusa gratuitamente dai cittadini. Per esempio, nelle scuole la cultura viene sì diffusa dai docenti pagati dallo Stato, ma i materiali che usano per trasmetterla sono gestiti da editori privati, disposti a chiudere un occhio sull'uso di scanner e fotocopiatori solo a condizione che tutti gli studenti acquistino i loro libri di testo, nonché i diari e altro materiale didattico. Oggi sembrano essere anche disponibili a vendere l'equivalente digitale del manuale cartaceo, ma solo perché, di fronte al boom dell'infotelematica, non sanno ancora bene come reagire, non capendo come poter realizzare gli stessi profitti del cartaceo usando le nuove tecnologie. Da un lato infatti sono consapevoli che in rete è molto facile la distribuzione abusiva di materiali protetti dal diritto d'autore; dall'altro si rendono conto che se non fanno investimenti, attrezzandosi adeguatamente in campo infotelematico, rischiano di dover chiudere.
Oggi la differenza tra un libro di testo e un altro non sta più nel CD accluso, quanto nella possibilità di ottenere gli stessi contenuti in maniera del tutto separata, cioè in maniera tale che l'acquisto della versione digitale non sia vincolato all'acquisto della versione cartacea. Per realizzare una cosa del genere, in maniera tale che l'opera digitale acquistata non sia liberamente ridistribuita, occorrono procedure complesse, non tanto per l'utente finale, quanto piuttosto per l'editore.
I monopolisti della cultura ancora non si rendono bene conto che la cultura è destinata a smaterializzarsi completamente. Se un'intera nazione fosse cablata da potenti fibre ottiche, persino la scuola intesa come "edificio murario" non avrebbe più alcun senso. Quanti italiani analfabeti presero la licenza elementare guardando "Non è mai troppo tardi" alla televisione? Un milione e mezzo! Oggi, utilizzando un computer collegato a una rete telematica, è possibile acquisire qualunque tipo di conoscenza. Ormai la vera differenza fra un ente gestore di cultura e un altro sta unicamente nella capacità di interagire con l'utente finale. La scuola, intesa come "edificio murario", dovrebbe essere trasformata in un qualcosa da utilizzarsi per tutto ciò che in rete non è possibile fare, almeno non nella stessa maniera (p. es. un'attività di tipo ginnico, artistico, ricreativo o socializzante).
*
Esiste nel sito www.red-bean.com un documento molto importante, intitolato Storia del copyright (2004), tradotto in italiano dal sito www.comedonchisciotte.org. (2) Vi si spiega l'origine storica del diritto d'autore, che merita d'essere qui sintetizzata, per farsi un quadro sufficientemente esatto dei termini del problema.
In particolare il testo vuole dimostrare la tesi secondo cui il copyright non serve tanto per tutelare scrittori e artisti, quanto piuttosto i distributori delle loro opere. Questo perché gli autori non hanno mai giudicato il copyright un fattore importante per consentire la fioritura della creatività, la quale si basa su fonti di finanziamento molto diverse. Generalmente anzi gli autori non vedono la copia come un furto, ma con compiacimento, posto ovviamente che a tutti sia noto chi sia l'autore dell'opera originaria. Ancora oggi, per la grande maggioranza degli artisti, il copyright non porta alcun beneficio economico.
La storia del copyright comincia in Inghilterra con la nascita, nel 1556, dell'Ordine degli Stationers (editori, tipografi e librai, che a quel tempo sostanzialmente coincidevano): una casta professionale cui la corona inglese (i cattolici Filippo II e Maria I Tudor), temendo la diffusione di idee protestanti o sovversive, aveva deciso di affidare, in via esclusiva, il controllo di ciò che si stampava, cioè appunto il "diritto di copia" (copyright), e quindi il monopolio delle relative tecnologie, che a quel tempo avevano preso a diffondersi velocemente.
Il copyright quindi era nato come sottoprodotto della privatizzazione della censura governativa: lo Stato aveva affidato a dei privati un privilegio assoluto, destinato a trasformarsi in un colossale business. Fino ad allora l'unica preoccupazione che gli artisti o gli autori avevano avuto era stata quella di far circolare al massimo le loro opere, proprio per intercettare gli interessi di quanti più committenti possibili.
Di regola la gente stampava, se ne aveva le possibilità, le opere che reputava importanti. E quando qualcosa veniva proibita, era piuttosto per ragioni etiche o politiche, non perché si aveva una concezione del copyright come di una proprietà legale che potesse essere posseduta privatamente. Per chiunque sarebbe stato un controsenso limitare la diffusione di un'idea utile, innovativa. Semmai il problema era opposto: come divulgarla in una società dove i lettori erano ancora molto pochi.
All'Ordine degli Stationers (Corporazione dei Librai di Londra) venne offerto, in qualità di polizia privata del governo, il diritto esclusivo su tutte le pubblicazioni realizzate nel Regno, sia per le vecchie opere che, e soprattutto, per le nuove; un diritto che non si esercitava soltanto solo nella stampa tipografica vera e propria, ma anche nella confisca di ciò che non era stato preventivamente autorizzato. Ogni pubblicazione, per essere stampata (o, se già lo era stata, semplicemente diffusa), doveva sottostare al controllo del censore governativo o degli stessi Stationers, i quali, così, non solo non dovevano combattere, sul piano economico, alcuna concorrenza, ma diventavano anche i legittimi proprietari delle opere che commerciavano. Infatti le nuove pubblicazioni venivano inserite nel registro della Corporazione non sotto il nome dell'autore, ma sotto quello di un membro della stessa Corporazione, al punto che questa medesima persona, socia della Compagnia, poteva rivendicare il copyright su una determinata opera, anche nei confronti degli altri soci!
Successivamente, verso la fine del XVII secolo, cioè a rivoluzione compiuta, il governo in carica mutò atteggiamento nei confronti della censura preventiva e parve essere intenzionato a eliminare il monopolio degli Stationers. I quali ovviamente reagirono. Questa volta però la motivazione voleva apparire a tutto vantaggio degli autori. Venne detto infatti che il copyright apparteneva all'autore e che questi, non possedendo macchine tipografiche, lo avrebbe ceduto agli Stationers solo il tempo necessario per la pubblicazione e diffusione della sua opera. In cambio l'autore sarebbe stato tutelato dalla "pirateria", cioè dai tentativi di copiare abusivamente o contraffare la sua opera. E ovviamente egli otteneva una percentuale sulla vendita della stessa.
Dopo ampia discussione in Parlamento, fu approvato nel 1710 lo "Statute of Anne" (3) il quale non veniva affatto incontro alle esigenze degli autori, che, in quell'occasione, neanche fecero sentire la loro parola, ma, ancora una volta, alle esigenze degli editori, molti dei quali, con la fine del monopolio, avrebbero rischiato di finire sul lastrico.
Lo "Statuto" della regina Anna d'Inghilterra, Scozia e Irlanda (rimasto in vigore fino al "Copyright Act" del 1842) può essere considerato il capostipite di tutte le leggi e gli accordi internazionali sul diritto d'autore, fino ai più recenti: la "Convenzione di Berna" del 1971 (4), il "Digital Millennium Copyright Act" del 1998 (5) e il cosiddetto "Decreto Urbani" del governo Berlusconi (2004) (6). A partire dallo "Statuto di Anna", in assenza di censura preventiva, i profitti degli editori salirono di nuovo alle stelle.
*
Tutto ciò, come già detto in premessa, cominciò a subire una battuta d'arresto con la nascita della fotocopiatrice e del registratore (audio e video) e soprattutto col masterizzatore e il peer-to-peer. La copia e la distribuzione di qualunque opera cartacea, sonora o visiva o informatica (come il software) era diventata possibile, virtualmente, a tutti. Gli autori dei libri oggi possono addirittura produrli soltanto in formato digitale, inviarli a una tipografia per ottenerli in formato cartaceo e metterli in vendita autonomamente, previo acquisto di un numero ISBN, in tutti i mercati digitali del mondo.
Internet ha prodotto una rivoluzione paragonabile a quella della stampa quando tutto si scriveva o si disegnava a mano. Con una differenza, che le copie di un libro dovevano essere fisicamente trasportate dalla tipografia ai lettori e il costo era a carico degli editori. Oggi invece i testi possono essere trasmessi via cavo subito dopo essere stati prodotti, a costi del tutto irrisori e con la possibilità, per l'utente finale, di stampare il testo a proprie spese e con la qualità che può permettersi. Il testo, se ha un prezzo, può essere acquistato sia in formato digitale che cartaceo e, in questo secondo caso, viene venduto on demand, cioè solo su richiesta, per cui non vi sono rese destinate al macero.
Fermare il progresso tecnologico in nome di monopoli, privilegi o diritti acquisiti, è ridicolo. Non basterebbe neppure una dittatura politica. L'editoria, la Siae... stanno correndo ai ripari accentuando i controlli finalizzati a vietare la diffusione delle copie, ma senza successo: i siti-web aprono e chiudono con molta disinvoltura e sono capaci di difendersi, in quanto gestiti da persone competenti.
La Siae cerca anche di colpire legalmente chi utilizza senza scopo di lucro le opere protette dal copyright, ma, nel fare questo, oppone il diritto d'autore al diritto alla cultura, compiendo un abuso anticostituzionale. Colta dal panico, ha addirittura preteso o proposto di ottenere delle royalties dalla vendita di tutto ciò che, virtualmente, potrebbe permettere una copia abusiva di un'opera protetta. Agisce cioè secondo un principio, anche questo nettamente anticostituzionale, quale quello della presunzione di colpevolezza: chi acquista un CD vergine o un dominio vuoto è un truffatore potenziale.
È difficile far capire, a chi è abituato a vivere con la logica del profitto, pensando che la cultura sia un patrimonio soltanto di chi se la può permettere, che in realtà essa andrebbe lasciata libera, pubblica e gratuita per tutti, finanziata con le tasse di tutti i cittadini, esattamente come la scuola e la sanità. Se qualcosa va pagato, al massimo dovrebbe trattarsi di un rimborso delle spese, ovvero del riconoscimento di un guadagno da parte di chi sostiene spese vive di pubblicazione e diffusione di un'opera. Agli stessi autori si potrebbero riconoscere, in varie forme e modi, dei compensi attraverso la pubblicità, le donazioni, ecc. Quello che non si può tollerare è che un autore possa pensare di campare di rendita, grazie alle proprie opere, in nome del copyright e, peggio ancora, che tale copyright possa essere esteso ai suoi discendenti per 70 anni dalla sua morte. In ogni caso non si può permettere a dei privati di sfruttare l'ingegno di pochi intellettuali e di monopolizzare la diffusione delle loro idee.
*
La cultura è un bene immateriale: la sua diffusione può dipendere soltanto dal gradimento di chi la fruisce, di chi riconosce all'autore un certo merito. Nessuno può avere il diritto di pensare che attraverso la produzione e diffusione della propria cultura, si possa campare di rendita. La cultura deve rispondere a un bisogno specifico: solo così può essere remunerata. Ma, una volta che lo è stata, la fruizione deve essere libera. Infatti, se un'opera d'arte venisse pagata con soldi pubblici, chi ne fruisce l'avrebbe in realtà già pagata con una parte delle sue tasse, o comunque l'avrebbe pagata con un contributo volontario anticipato per la sua realizzazione.
La cultura dovrebbe essere un fenomeno libero, pubblico e gratuito. Libero perché non si può impedire a nessuno né di produrre cultura né di fruirne. E gratuito perché, dedotte le spese vive occorse per produrre una determinata opera d'arte, la stessa opera non può essere pagata ogni volta che se ne fruisce, a meno che ovviamente non vi siano altre spese documentate.
Delle tre suddette condizioni, la più importante però è la seconda, quella della pubblicizzazione, poiché è con questa che si garantisce la sopravvivenza di un autore. Posto infatti che nessuno dovrebbe avere il privilegio di campare di rendita producendo cultura, né quello di realizzare dei profitti privati su un bene immateriale, e meno ancora sfruttando l'ingegno altrui, è anche vero che un autore ha comunque diritto di esistere in quanto tale. Gli va cioè riconosciuto il merito d'aver prodotto qualcosa di culturale.
Produrre cultura, in sé, non è un merito. Lo diventa però se si finalizza la produzione di un'opera d'arte a un obiettivo specifico, di rilevanza pubblica. Cioè un qualunque collettivo (istituzione, comunità, ente, scuola ecc.) potrebbe chiedere a uno o più autori di produrre un'opera culturale per un determinato scopo, e pagarla con le tasse dei cittadini o con i contributi di coloro che fruiranno di quell'opera.
La cultura non può essere astratta, prodotta senza uno scopo preciso, totalmente indipendente da specifici bisogni collettivi; se un intellettuale può produrre, in teoria, ciò che vuole, non può però pretendere d'essere pagato. Meno che mai un intellettuale o un artista può pensare di fare della sua autonoma produzione di cultura un mestiere. Un intellettuale deve anzitutto svolgere un mestiere sociale, che abbia una finalità collettiva, un'utilità pubblica. La cultura va prodotta sulla base di un'esperienza in atto, come riflessione di ciò che si vive, altrimenti è solo un'astrazione individualistica, un gioco intellettualistico.
Un intellettuale o un artista dovrebbe anzitutto essere un formatore, un educatore, un istruttore, un addestratore, un insegnante ecc., cioè dovrebbe darsi una finalità pedagogica rivolta a un collettivo, o meglio, dovrebbe riconoscersi negli obiettivi vitali di una determinata comunità, dovrebbe cioè essere "organico" a qualcosa. Questa finalità deve avere una funzione istruttivo-educativa o può essere addirittura politica.
Un intellettuale o un artista, un produttore di cultura dovrebbe appartenere a un qualche collettivo. Se vi appartiene, dovrebbe essere questo stesso collettivo a incaricarsi di remunerare il suo prodotto culturale. Lo stesso intellettuale diventa il "prodotto culturale" di un determinato collettivo. Tra prodotto e produttore dovrebbe esserci una continua sollecitazione reciproca, una "corrispondenza d'amorosi sensi", in mancanza della quale non ha alcun senso lamentarsi del fatto che tutti vogliono essere scrittori e nessuno vuol fare il lettore.
Una qualunque opera culturale deve nascere da un bisogno e deve saper rispondere a questo bisogno. La cultura deve uscire da quel limbo di indeterminatezza costituito da intellettuali isolati, che non fanno capo ad alcuna associazione, totalmente privi di senso del collettivo, insofferenti a regole da rispettare.
Detto questo, è bene aggiungere un ulteriore tassello a queste considerazioni sul concetto di cultura e sulla figura dell'autore, altrimenti si rischia di cadere in ulteriori equivoci. Se vogliamo superare la tradizionale separazione tra lavoro manuale e intellettuale o quello tra teoria e pratica, non ha neppure senso che gli intellettuali formino un'associazione a se stante. L'obiettivo che infatti devono porsi è quello di appartenere a un collettivo di persone comuni, non quello di isolarsi da qualunque collettività, costituendone un'altra in maniera elitaria.
Una cultura resta astratta o aristocratica sia quando è individualistica sia quando il collettivo in cui si forma è autoreferenziale. La società non ha bisogno di autori geniali che producono opere eccezionali, ma ha bisogno di intellettuali che aiutino a capire come risolvere determinati problemi. Se poi vengono fuori "soluzioni geniali", questo va considerato un surplus occasionale.
Sotto questo aspetto bisogna dire che la nascita e soprattutto lo sviluppo impetuoso delle reti digitali mondiali sembra offrire la percezione di appartenere a una comunità internazionale, che legittima, in un certo senso, l'esistenza isolata dei singoli utenti. Internet illude l'autore isolato di far parte di un collettivo mondiale, nei cui confronti, solo perché paga una connessione telefonica, ha un atteggiamento puramente rivendicativo, di pretesa o, al massimo, collaborativo su aspetti marginali, che non servono a risolvere i suoi problemi personali, quelli del suo luogo di lavoro, della sua famiglia, delle sue relazioni sociali, del contesto in cui vive quotidianamente. Ogni cybernauta rivendica il libero utilizzo di qualunque forma di conoscenza. Ma non è così che si fa "cultura".
Infatti, se può essere vero - come dice Gennaro Francione, nel suo sito www.antiarte.it - che "l'autore è solo il portavoce di un messaggio d'arte universale, ch'egli esprime in nome dell'umanità; dal che deriva che non ha la proprietà intellettuale delle sue opere, ma il mero possesso (detentio) delle forme artistiche, senza che chicchessia possa vantare alcuna proprietà, né assoluta né relativa, sul prodotto"7, è anche vero che non basta sostenere che la proprietà intellettuale è un furto per "fare cultura".
Il problema infatti non è tanto quello di come permettere a individui isolati, con scarsa disponibilità di mezzi, di accedere gratuitamente a qualunque forma di conoscenza, ma quello di come fare che questi individui isolati diventino un aggregato che possa produrre cultura in proprio, senza limitarsi ad attingere a quella degli altri.
Lo sviluppo abnorme delle reti digitali sembra essere inversamente proporzionale all'incapacità di creare reti reali, con cui poter incidere sui meccanismi, sulle dinamiche della vita sociale, la quale anzitutto è di tipo locale. Internet sta giustificando un globalismo che, per molti versi, è nocivo alla autonomia che devono avere le dimensioni locali e regionali. E noi non possiamo pensare che queste dimensioni siano irrilevanti solo perché ci vantiamo, nel momento stesso in cui ci connettiamo, di avere a disposizione il mondo intero.
Note
1 Quanto questi enti detestino le biblioteche e i centri di documentazione che, previo l'acquisto di una tessera gratuita, permettono la libera fruizione di opere tutelate dal diritto d'autore, è cosa nota.
2 Anche nel sito www.wumingfoundation.com si può trovare un interessante testo su copyright e copyleft (2005).
3 L'originale si trova qui: www.copyrighthistory.com/anne.html
4 Qui nella versione italiana: www.interlex.it/testi/convberna.htm
5 Qui lo si può scaricare: www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf
6 Qui lo si può leggere: www.interlex.it/copyright/urbani2.htm
7 L'articolo è intitolato Sentenza anticopyright e cyberagonia del diritto d'autore.
